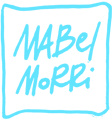Ferdinando Tacconi, disegnatore poco ricordato eppure fondamentale nella storia del fumetto.
Ricordare Ferdinando Tacconi è un po’ come quando, da adulta, torni a casa dei nonni e riassapori odori e colori che sono impregnati nell’arredamento, dalle maniglie delle porte di una volta, quelle in ferro, alle mattonelle dai disegni gestaltici dei pavimenti, ai divani tappezzati in tessuto che danno sempre la sensazione di polvere, tanta polvere – come la moquette nelle abitazioni di fine anni ’70 -, ai libri rilegati dalle coste grosse e dalle pagine ingiallite.
Ne prendi uno, e lo sfogli: l’odore è quello di qualcosa di chiuso da troppo tempo, di dimenticato, di un’Italia che non esiste più, se non nei propri sbiaditi ricordi. Perché appena entri in casa, l’odore di minestra, di cucina, riporta immancabilmente alla propria infanzia che altrettanto immancabilmente è racchiusa in album di fotografie sgranate su carta lucida patinata, e come tale, passata, finita.
Ricordare e scrivere di Ferdinando Tacconi, oggi, è un po’ come ritornare a quel tempo, immaginandolo con la malinconia degli occhi di adulto per un’epoca e un’età che non torneranno più, e quindi immaginarsi e ricordarsi di sé senza rughe, riscaldati da maglioni di lana grossa ricamati con geometrie tipiche di quegli anni, ricordarsi di sé ingenui e privi di malizia entrare nello studio del nonno, varcare quella soglia di autorità, quel non toccare le cose dei grandi.
Me lo immagino così, Ferdinando Tacconi, nel suo studio o angolo di casa arredato come tale: una scrivania vicino a un termosifone, o vicino a una finestra con una tenda dalla consistenza fine – come erano le tende di quando si era piccoli, leggere, quasi raffinate, da salotto –, una lampada da tavolo, un telefono con la cornetta e il filo a spirale elastico, magari un televisore con il tubo catodico in un angolo, su uno di quei mobiletti dai ripiani in vetro – appoggiato su un centrino in pizzo per non rovinarlo -, e con le ruote sotto, e naturalmente quello che davvero serviva, gli strumenti da lavoro, fogli da disegno, matite, pennelli, inchiostro. E libri, tanti.
Dite: chi era Ferdinando Tacconi? Un disegnatore dimenticato, come Gianni De Luca.
Certo, De Luca era un’avanguardista del fumetto, sposava la teatralità al disegno a fumetti, la china graffiante e vaporosa rendeva le sue tavole qualcosa che, a vederle dal vivo ancora oggi, fa sentire molto piccoli e impaurisce, perché non bastano dieci vite a raggiungere quel livello lì, fa sentire inadatti e sbagliati per l’Arte del fumetto, mentre Tacconi, a modo suo importante, era un artigiano su quelle tavole, era un onesto disegnatore che aveva trovato un suo stile riconoscibile ed equilibrato, che poteva disegnare di avventure di guerra, di aristocrazia, di Dylan Dog, di Nick Raider senza mai sminuire i personaggi che andava a rendere sulla carta.
Ci sono quei disegnatori che oscurano i personaggi che vanno a interpretare, Tacconi no; li fa sembrare come se avesse lasciato loro la loro anima, mai scavalcandoli, mai prendendosi la loro scena.
Ecco, avete presente quando in un film un attore lo vedete solo come quell’attore e il personaggio che interpreta passa in secondo piano? Accade anche con i disegnatori. E avete presente quegli attori che quasi mai sono in copertina e che vengono definiti caratteristi? Tipo Giuseppe Battiston. Ecco, tipo lui. E se googolate Battiston, appena lo vedete direte: ah già!, è lui! ha fatto Pane e Tulipani di Soldini, ha fatto il dottor Freiss in Tutti pazzi per amore, era anche in Perfetti Sconosciuti! Quando vedete Giuseppe Battiston in un film, non lo vedete mai come Giuseppe Battiston, ma solo e sempre come il personaggio che interpreta, quindi rispettivamente l’ispettore privato imbranato, il tuttologo e il gay che si nasconde.
Accade anche con i disegnatori. E Tacconi è un interprete misurato, diligente, mai sopra le righe, affidabile. Uno di quei disegnatori di cui non ci si pente mai dell’acquisto, perché fa il suo lavoro ordinato e di qualità, sempre di qualità.
Dite: perché ci racconti di Ferdinando Tacconi?
Perché sono dieci anni che non c’è più, perchè nel mio piccolo voglio rendere omaggio ad autori dimenticati, ad autori che passano e che lasciano un’eredità che non sempre si raccoglie, e che, con il tempo, ci si rende conto della loro importanza nel lavoro che hanno svolto, e forse anche per un’esigenza di ciò che hanno lasciato e di cui dovremmo ricordarci ogni giorno: la passione, la qualità, la ricerca della stessa, ma soprattutto l’affidabilità.
Come a casa dei nonni sfogli la collezione di vecchi Tex, allo stesso modo riprendi i fumetti di Tacconi, e ti manca. Ti manca una sensazione, ti manca un’illusione forse, quella che fa pensare che una volta le cose si facevano meglio.
Non che oggi i fumetti si facciano peggio, intendiamoci; oggi semmai c’è una qualità alta e diversa, forse dovuta anche a una popolarità da social network più facile.
Ferdinando Tacconi, come Gianni de Luca, era uno di cui riconoscevi il tratto: era uno di quelli che quando il babbo ti portava a casa il giornaletto dei fumetti, glielo strappavi dalle mani e lo sfogliavi velocemente per vedere se c’erano i disegnatori con quel tratto che ti piacevano tanto. Te ne stavi in ginocchio sul tappeto dell’ingresso, su quei tappeti di una volta tipo pelo di gatto, e intorno quelle mattonelle fredde di quei pavimenti così anni ’70 che all’epoca erano persino moderni.
Ferdinando Tacconi era uno di quelli il cui tratto faceva innamorare, uno di quelli di cui oggi guardiamo da lontano in un’epoca che quasi non ricordiamo più, quell’epoca in cui fare fumetto era odore di gomma cancellata, il calore della gomma cancellata sulle tavole, quella della pennellata liquida che si spegneva sul ruvido del foglio, quella del vasetto di china aperto, dei polpastrelli neri per pulire un tratto, quella tangibile della tempera bianca con cui cancellavi gli errori, quella del pennino che grattava sul foglio, sui segni a matita, quell’epoca in cui fare fumetto era un atto d’amore, quel fumetto di cui mi sono innamorata.
Avevo nelle bozze questo articolo dalla fine del 2016.
Mi piacciono le ricorrenze, specie se sono a numero tondo: dieci anni, vent’anni, trent’anni, quarant’anni; vedete?, ne sentite la fonia? Il numero tondo misura meglio il tempo trascorso, ha questa potenza nel rendersi conto che, paragonandolo alla propria età, il tempo è davvero passato.
E mi piaceva l’idea di ricordare Ferdinando Tacconi, un signore che disegnava fumetti, e che aveva le sue passioni e il suo trascorso. Era cresciuto negli anni della guerra, quindi era quasi normale che gli aerei militari e le storie belliche fossero immagini genetiche nella sua educazione. Un po’ come mio babbo, quella generazione per cui i film western, i cowboy e gli indiani, erano quelli che venivano tramandati ai figli. Mode, come ogni generazione.
Se si cerca una foto di Tacconi, sembra proprio tipo mio nonno, quei signori con quella particolare fisionomia di chi invecchia negli anni ’80: avete mai notato come sia cambiata la fisionomia delle persone? Guardate i calciatori: pensate ai fisici di Antognoni o Falcao, alti, filiformi, dai muscoli asciutti e tesi; e guardate oggi un Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, sembrano robot come Ivan Drago in Rambo 4.
Ebbene, avevo in canna questo articolo. E poi Lorenzo Barberis su Lo Spazio Bianco pubblica un articolo proprio su Gli Aristocratici disegnati da Tacconi, e ne stila un’analisi molto bella, su come una serie come quella – scritta da un altro signore del fumetto come Alfredo Castelli -, composta da episodi brevi per lo più, fosse una delle basi del fumetto popolare che di lì a poco sarebbe esploso.
Barberis definisce dinamico il tratto di Tacconi, moderno scrive. Ed è vero.
Quel tratto che mi è sempre piaciuto tantissimo e che oggi, non so per quale combinazione mentale azzardatissima – passando da Jordi Bernet -, mi ricorda sempre quello di Toni Bruno. Da quassù la terra è bellissima è un signor romanzo a fumetti, e ogni volta che vedo il segno di Bruno penso a lui, quel signore che dalle foto sembra mio nonno, quel signore dimenticato che disegnava fumetti molto belli.
È uno degli incubi ricorrenti dei disegnatori, e degli autori in generale, quella di essere dimenticati. Gianni De Luca morì e nessuno se ne accorse, per poi riscoprirlo anni dopo, quando giovani autori si erano formati e non sapevano nemmeno chi avesse usato per primo il teatro nei fumetti. Mi ricordo un articolo nel quale si celebrava l’ennesimo autore americano e c’era questa galleria di tavole. Una più belle dell’altra innegabilmente ma innegabilmente – e sfacciatamente – ripresa da De Luca. Apparve su Fumettologica, ma non ricordo di più. Mi fece sorridere. Tutti – iperbole – a incensare un americano quando in Italia siamo stati testimoni di un De Luca.
Non sorprende dunque che persino di un Ferdinando Tacconi non ci si ricordi.
Anche se poi, osservi tuo nipote che ovviamente non ne vuole sapere di ubbidire e te lo ritrovi seduto di fronte alla libreria, con un vecchio giornaletto ingiallito a fumetti tra le mani, che sfoglia con lo sguardo perso e rapito un tratto, dei disegni che tu ricordi lontani, e ti guarda, entusiasta. Ti guarda e ti indica quel segno moderno e dinamico.
Sorridi, un po’ fiduciosa del mondo e delle generazioni future.
E pensi a quello che davvero significa tramandare, ereditare, non dimenticare.
(Foto di copertina presa da internet)