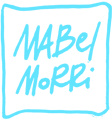Racconto.
4 di 4.
Qui la parte 1, qui la parte 2, qui la parte 3.
Il vrrrrrrrr che sentivo era il sibilo del vento fischiare nelle orecchie, era quello delle ruote che scorrevano veloci sull’asfalto.
Nell’onomatopea fumettistica il vrrrrrr che sentivo quel sabato, lento e soffice dall’incrocio dei raggi e della catena con l’aria della mia velocità in un’azione vettoriale e fisica indica il suono di una sega elettrica. Quando nei fumetti appare il primo piano delle mani guantate che tirano una cordicella, il vrrrrrrr viene disegnato con il font a saetta. Di solito, nelle vignette successive, ci sono anche gli occhi della vittima e in un gioco di bianco e nero il ghigno dell’assassino. Ma io l’ho sempre associato al morbido alito di vento che si infilava tra il cappello di lana e le poche ciocche che ne cadevano fuori, tra la sciarpa e il colletto alzato del giaccone.
Mi chiamavano “L’artista” nello spogliatoio, perché mi piaceva disegnare e leggevo i fumetti, quelli che disegnavo nella mia cameretta dopo le traduzioni di latino e greco, quelli sportivi ispirandomi alle biografie di Paolo Ongaro e alle caricature di Franco Bruna, autori che mi permettevano di sognare che sport e disegno potevano convivere. Gianni De Luca invece mi insegnò che il fumetto è arte. Quella che, da artista, in campo e persino mancina – e di quei tempi non era facile esserlo perché i paragoni si sprecavano -, provavo a inventare in traiettorie verso l’area di rigore.
Alfio, poco dopo l’arrivo di Simona che involontariamente per il suo ruolo fece implodere la nostra abituale struttura modificandola in un assetto nuovo che ci mise qualche partita a oliarsi ma che poi trovò una quadra fluida, mi spostò sulla destra. Non più ala che faceva su e giù come un pendolo sulla sinistra ma esterno che si alternava al terzino fluidificante sul lato opposto, rientrando, se necessario, a difendere ma con licenza di rientrare verso il centro per poter caricare il tiro col piede buono tentando la porta da lontano qualora le barricate difensive ostruissero tutte le linee di passaggio.
Simona giocava davanti alla difesa, ruolo che avevo imparato a conoscere in quel campionato farlocco, ruolo che affinò con la pratica e un’intelligenza rara. Ma eravamo donne, non ci venne mai riconosciuto, anche dopo, anche quando il nostro campionato fu sotto gli occhi di tutti, anche dei pensionati che poi venivano apposta a tifare per noi. Alceste, il titolare del bar a fianco del campo di allenamento, finì per offrirci la cioccolata calda quando ormai le luci iniziavano a spegnersi sia sull’erba sia sulla sua insegna, nell’attesa di parecchie di noi dell’ultimo autobus che ci avrebbe portato vicino casa, Perché tanto, diceva, l’avrei buttata via alla chiusura.
Pedalavo sul lungomare.
L’ultimo ricordo della stagione era quella dei bagnini con stivali di gomma e impermeabili a lavare le sdraio, in piedi sulle cabine ad asciugarsi nel tiepido sole di fine ottobre, mentre a vederli dal marciapiede erano già abbronzati e a torso nudo nel prendere le misure tra un paletto e l’altro per comporre le file di ombrelloni, riprendendo dl magazzino quelle stesse sdraio lasciate seccare mesi prima.
Il tumulto era presente, sempre: lo fu quando sull’autobus Simona mi sorrise andando al campo, trascinando il borsone sul seggiolino davanti al posto su cui sedevamo in fondo, lo fu quando ci riscaldammo con i capelli ancora bagnati nel gelo della campagna con la cioccolata calda servitaci da Alceste, lo fu anche quel sabato nel quale mi telefonò e mi disse di vedersi al mare.
Pedalavo e mi domandavo se quel tumulto avrebbe potuto concedermi qualche ora di tregua. Solo in campo non lo sentivo, non quello almeno, un altro tipo piuttosto, quello delle gambe pesanti, quello del fiato corto, quello del resistere a provare l’ultimo scatto verso un pallone innocuo, che non lo è mai. In campo stavo bene, quel tumulto esistenziale non si presentava su quell’erba, in mezzo a quel fango: non mi ero mai domandata che genere di giocatrice volessi essere, lo sapevo già e rispecchiava in pieno quella parte di me che forse, nella vita poi che avrei condotto, quasi mai sarebbe venuta fuori né tantomeno sarebbe stata così sicura di sé e di ciò che ero. E io ero un’ala, una che rientrava a difendere, una che se le capitava qualche leziosità se la concedeva dietro naturalmente le urla impietose di Pedro che era pragmatico e che quelle finezze non esitava a mandarle a quel paese. Giustamente: e se avessi perso palla sulla trequarti per una giocata effimera come quella?, la vergogna nel sentire le sue imprecazioni e lo scusarsi con le compagne, per cosa?, perché ero l’artista?, anche meno, anche meno cresta così alta.
L’appuntamento era in un bar sulla spiaggia a Torre Pedrera, uno di quelli che ad aprile sembrano usciti dal letargo, ampi spazi ancora chiusi, qualche tavolino negli angoli più caldi e non tutto il menù a servizio, come i gelati dalla vetrinetta o le granite. Ma noi avremmo ordinato la cioccolata calda. Era diventata il mantra della squadra, la bevanda preferita quando le forze scendevano ma serviva resistere per tornare a casa, ancora un’ora di autobus prima del letto dalle lenzuola felpate.
I rigagnoli di sabbia tra le piastrelle componevano immaginarie vie verso il mare di sabbia che mi si apriva davanti, assomigliavano a quelli di fango, a quelli di acqua e fango che si esaurivano nella piletta di scolo in mezzo allo spogliatoio, quando rientravamo e Pedro urlava cosa avevamo sbagliato e cosa dovevamo rimediare.
Quando Simona arrivò ero persa nei momenti del campionato, come sulle pagine del Guerin Sportivo nel Film del campionato, immagini in successione e tabellini con i voti.
Come la prima partita giocata insieme dopo il suo arrivo, prima di Natale, te la ricordi?, le chiesi.
Giocavamo al campo sportivo di Gatteo, una piccola tribuna in ferro sopra alle panchine, due cabine da quattro sedie ciascuna sotto la banchina. Pedro aveva portato altre sedie pieghevoli nel suo furgoncino, su cui caricava qualcuna di noi e Pietro, il volontario che voleva farsi prete e che arbitrava le gare interne del maschile, guidava un pulmino comunale che veniva messo a disposizione come scuolabus, come servizio anziani e disabili e per noi squadra femminile.
Eravamo una bella carovana, scalcagnata e dalla cerchia ristretta, sospettosa perfino quando al campo arrivava qualcuno di nuovo, un’amica, una cugina, un padre, un fratello.
Sì, la ricordo, mi disse.
Ne prendemmo due e Simona, non ancora nel meccanismo del gioco lasciò libero un pertugio nel quale si infilò la 11 avversaria e cacciò un tiro sbilenco che però si infilò in rete.
Quella dopo pareggiammo, partita fisica, tanti passaggi, poca costruzione davanti, a me non giravano le gambe, avevo preso un brutto voto a scuola e il tarlo dell’essere rimandata in estate si insinuò malefico, salvo poi studiare fitto in quelle vacanze e recuperare.
Al recupero a gennaio, in casa sul nostro campo, mi fecero male. Mi entrarono sotto il ginocchio nella parte mediale della gamba. Il taglio non fu particolarmente profondo, non servirono i punti ma sanguinò molto. Ancora oggi quando mi abbronzo, una sottile riga bianca, dritta tra tibia e perone, rimane tale non abbrozzandosi più.
E poi le altre, le altre partite, i sorrisi e gli sguardi bassi, i rimproveri e i pochissimi elogi.
Che avventura.
Ed eravamo lì, a guardare il mare e a bere cioccolata calda ricordando il campionato appena giocato. Qualche nuvola innocua spuntava lontana, a sporcare un cielo altresì perfetto.
Che cosa avevamo imparato?, che cosa ci avrebbe lasciato tutto quel sudore, tutta quella fatica, tutto quel mordere quel tempo che sembrava unico e presente, presente privo di futuro, se non quello, imminente, dell’ultima di campionato, quello che avrebbe decretato il nostro successo o un buonissimo secondo posto.
Non eravamo campionesse. La sensazione era quella di un’amalgama di giocatrici, liceali come me e Simona e Silvia, Chiara, la Rossi, Laura, la Peluso, Elvira che instancabile, da madre e moglie, ci raccomandava l’alimentazione sana, Katia, il nostro stopper e futura laureanda di giurisprudenza, le diciottenni e le ventenni che già lavoravano, Cristina e l’altra Chiara, quella di Morciano, Iole e Raffaella, ragazze e donne messe insieme in una magia inaspettata che stavano vivendo un sogno, anche solo nel tenersi in forma, come Elvira che diceva aspettate a crescere, vedrete da sposate!, e che usava il calcio come valvola di sfogo di qualcosa di solo suo, nel quale poteva rinchiudersi e liberarsi dalle incombenze di ogni giorno.
Non eravamo campionesse e certo il calcio, per noi, avrebbe sempre avuto quella dimensione lì, quella che stavamo conoscendo sotto la presidenza dell’Erminio, un impegno se mai fosse continuato dopo la maturità, almeno per me, preso seriamente si capisce, ma amatoriale, da dilettante, come mi era capitato di sentirmi rinfacciare una volta da bordo campo.
Mi piacevano tutte, andavo d’accordo con tutte.
Eravamo lì, io e Simona e il mio tumulto, a guardare il mare e a emozionarci di quel presente così vivido, quel presente che appena diventato passato, ma non potevamo saperlo certo quel giorno, nel fresco di inizio aprile nella brezza della spiaggia di Torre Pedrera a chiudere gli occhi, respirando, nell’attesa del giorno dopo, quel presente che ci faceva sentire vive, così vive. Avevo sedici anni e mi sembrava di avere il mondo in mano e un futuro radioso, qualunque esso fosse stato.
Era domenica 12 aprile 1992 e avremmo giocato fuori casa, sopra i lidi ferraresi, sul confine veneto.
Per l’occasione, Pedro aveva imposta a Erminio, su espressa richiesta della figlia, un pullman vero, quello da gita scolastica. Con noi salirono anche i pensionati e Alceste.
Nel piazzale davanti al bar di Alceste che si prodigò in colazioni e caffè pagati, con fattura, dal presidente, il cielo terso del sabato prima si era trasformato in un cielo gravido di pioggia. La prima goccia cadde appena chiusa la porta del pullman.
Li informarono che sul nostro campo avrebbero giocato prima di noi il maschile, nulla di cui preoccuparsi sulle condizioni, avrebbero risistemato tutto e pulito, per quanto possibile, gli spogliatoi e poi, avevano messo sole.
Il viaggio fu silenzioso, eravamo tutte concentratissime, io sedetti in un angolo a guardare scorrere il panorama come sempre, Simona, come suo solito, passò la maggior parte del tragitto con la testa appoggiata al vetro. Pedro capitava che si alzasse e percorresse il corridoio, a vedere come stavamo, riflessivo anche lui.
Aveva iniziato a piovere fortissimo. Il Rubicone appariva già pieno attraversandolo e immettendoci poi sulla Romea, perché sì il pullman ma l’autostrada costa e la mappa stradale era bella evidenziata fino al campo avversario.
E fu vero, arrivammo lassù con il sole.
Eravamo concentratissime, pronte a qualunque rincorsa, a qualunque tackle, a qualunque risultato, anche alla sconfitta.
Ma ciò che ci apparve davanti fu peggio della sconfitta stessa.
Nel parcheggio davanti al campo sportivo trovammo radunata anche l’altra squadra. Fu insolito, ma finì che ci facemmo pure amicizia, con le avversarie, andando in un pub a bere la mia prima birra, prima di ripartire per tornare a casa.
Quello che omisero fu che sì, avremmo giocato dopo il maschile, ma quello della Prima Categoria, quello degli Esordienti e quello dei Pulcini persino, sotto una pioggia insistente che aveva messo a dura prova la resistenza del campo e, quando spuntò il sereno, a metà del pomeriggio con le luci dei fari già accesi per la nostra preserale, la fascia destra appariva un pantano, impossibile da giocarci.
Il giudice sportivo dichiarò la vittoria a tavolino e il viaggio di ritorno fu silenzioso come quello dell’andata, un silenzio diverso, pregno di delusione, di disfatta, di poco riguardo e di poco rispetto.
Non ci fu permesso nemmeno di rigiocarla, la Pasqua imminente e il calendario maschile già deciso ci impedì di provare a vincerla davvero sul campo.
La notizia della nostra discriminazione finì anche sul giornale, un trafiletto di due colonne aperto da una foto di un campo allagato, di repertorio evidentemente e non certo di quel campo.
La stagione successiva andò male, la magia si era persa e avevamo avuto qualche defezione: Simona, per esempio, e Katia che si tuffava nel tirocinio a Bologna. Andò male nella misura in cui galleggiammo a metà classifica come i piani alti preferivano, ma non era questo, era l’aria, era cambiata e ne eravamo consapevoli a ogni allenamento, a ogni scatto, a ogni ripetuta.
Il bar di Alceste non esiste più, è stato preso in gestione da un gruppo di ragazzi che lo hanno trasformato in un lounge bar, con poca fortuna. Alceste mancò qualche tempo dopo, all’alba del nuovo millennio, così come molti dei pensionati che ci presero in simpatia e che finirono per tifarci.
Oggi, trent’anni dopo, non gioco più a pallone.
Lo guardo certo, ma un incidente in Vespa, quel tanto sospirato motorino comprato con i soldi della stagione, il primo e la prima di una lunga serie, mi ha lasciato viva ma con la schiena distrutta. Per non bloccarmi, mi è difficile anche solo dare un calcio leggero giocando con mio nipote.
Però continuo a sentire quel vrrrrrrrr nelle orecchie, in pedalate sul lungomare, sfinenti e contro vento, ma piene.
Ogni tanto in questi giri, alzandomi sui pedali ascoltando il respiro farsi corto, quel tumulto mai silenziato si domanda ancora chi io sia.
Senza pace, irrompe nel sonno.
Una notte ho fatto un sogno.
Intorno a me uno stadio pieno di gente, ma io non vedo nessuno, percepisco solo gli occhi degli astanti, come quelle pubblicità nelle quali c’è l’idea di pubblico grazie alla grafica. Il campo è di terra chiara, non c’è erba. Sento il mio cuore, sobbalza per l’emozione di giocare in un campo vero, in uno stadio vero, sobbalza per il cambio ruolo, Pedro che non vedo, che non ricordo di aver visto prima della gara ha magheggiato ancora chiedendomi quel ruolo inatteso – ne sarò capace? – e quando mi arriva il primo pallone, uno di quelli arancioni da neve, quasi che esplode, il cuore. Il mio respiro è totalmente rotto dal primo tocco di quel pallone, un passaggio semplice di inizio partita, aspettando che il gioco entri nel vivo. Eppure l’emozione di quel primo tocco, quel primissimo stok! che echeggia in quella che mi sembra l’enormità di un campo finalmente dalle misure regolari sul quale giocare, mi irrigidisce le gambe arrivando a domandarmi ansiosamente se ho calciato bene il pallone, se ciò che provo non abbia provocato un passaggio troppo breve o semplicemente sbagliato.
La palla si allontana, sembrerebbe un buon appoggio, non sento bisbigli né oohhh di disapprovazione, forse è andata bene penso.
Poi mi sveglio.
Un’altra notte ancora sogno il campo con le pubblicità della Erminio Rossi Costruzioni. Io sto correndo, leggera, senza nessun dolore alla schiena e alle gambe: è tutto così finto, percepisco in pieno di star sognando perché non correvo così bene nemmeno da ragazzina.
Ma mi sveglio comunque col fiatone, come se quella corsa l’avessi fatta davvero.
Una parte di me è rimasta su quel pullman, aspettando quella partita, come se questi sogni fossero un modo per poterla vivere, e giocare; tanti sogni che insieme formano azioni consecutive, quella del calcio d’inizio, quella nel quale corro sulla fascia, quella del mio dribbling a rientrare nel mezzo, fuori area, a esplodere il mio sinistro nel tentativo di sparare la palla nel sette.
Continuo ad andare in bicicletta, a sentire quel vrrrrrrrrrr nel vento.
E continuo a guardare il mare.