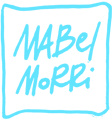Racconto.
3 di 4.
Qui la parte 1, qui la parte 2.
L’autobus vuoto era freddo.
Specie di sera, non tanto tardi ma in inverno, quando cala presto il buio, la sensazione è quella di non aver avuto la possibilità di sfruttare al meglio il proprio tempo, troppo breve, troppa poca luce a illuminare i pensieri belli, troppo buio, ancora, non solo quello fuori dal finestrino della campagna, scura con qualche fioca luminaria di una finestra lontana di un casolare, ma anche quella dell’anima.
Raggiungere il campo in bicicletta era impensabile, il motorino non lo avevo ancora comprato con i soldi della stagione e i miei genitori non potevano sempre accompagnarmi; l’abbonamento all’autobus fu indispensabile e salvifico, aiutata certo anche da orari non estremamente proibitivi.
C’erano momenti della tratta nei quali lo scemare lento dei passeggeri simbolicamente facevano pensare al corso della vita o a una partita di calcio: tanta confusione come in area di rigore prima di un calcio d’angolo nel mentre delle marcature per poi un cambio di giocatrice in una pausa di gioco nella quale fermarsi, respirare un attimo e bere.
Guardavo sempre fuori, sempre quel buio. Non davo confidenza, mi sedevo in fondo all’autobus e ne sentivo le vibrazioni lungo la schiena, mi lasciavo coccolare da quel tremito cigolante e a scatti. Scatti che condizionavano i miei pensieri, quelli dell’arcadia e dei vicini primi sedici anni, quelli dell’abbandono all’ambiente parrocchiale con la scusa dello studio, dei sabato pomeriggio delle vasche in centro e i primi sabato sera in discoteca.
Non la riconobbi subito.
Sedeva con la testa appoggiata al vetro, anche lei persa in chissà quali mondi, raggomitolata in una giacca sportiva blu, simile alla mia, di due taglie più grandi.
I tumulti interni che sentivo non mi permettevano di concentrarmi poi su molto altro che non fossero gli impegni apparentemente importanti, la scuola e il calcio per esempio, l’impegno costante in queste attività, l’energia vitale che usavo per assomigliare ogni giorno alla ragazzina perfetta che faceva le cose giuste che la società imponeva fossero come tali, anche se la più importante, quella che mi consumava nel fuoco giovanile prerogativa dell’adolescenza, quella del capire chi fossi, non solo quello che volevo essere, quello figuriamoci non lo avrei saputo nemmeno trent’anni dopo, ma chi, in quella profonda e viscerale ricerca di risposte che non avrei mai saputo, quello mi lasciava senza fiato, moriva in gola, come dopo una corsa esasperata e affannosa, quando inizia a fare male la milza e i polmoni sembrano non funzionare più.
Simona arrivò al campo verso la fine del girone di andata, all’inizio di dicembre, prima del lungo stop per le vacanze di Natale.
C’era talmente tanta nebbia che eravamo tutte camuffate, prima della moda degli scaldacollo, in berretti di lana grossa a uncinetto e guanti che si infradiciavano appena si sistemavano i dischetti delle ripetute. Il fango era così duro una volta asciugato nelle pieghe della pelle che, sotto la doccia, scrostarlo diventava un’impresa.
La Santarcangiolese femminile giocava nel campo laterale rispetto a quello ufficiale maschile, c’erano ampie parti nelle quali mancava l’erba e gli spogliatoi erano spesso poco puliti, male illuminati e dall’acqua non sempre calda. Ma per me era come giocare a San Siro. Anche solo nel ticchettio sulla passerella di cemento prima di entrare in campo, nella nuvoletta di vapore condensato del respiro emozionato e caldo da riscaldamento, in quei pochissimi applausi dei sostenitori, principalmente pensionati che frequentavano più il bar a fianco del campo che non assistere alle nostre partite e che in dialetto, appena capito che eravamo femmine, bestemmiavano e tornavano dentro a giocare a carte e a bere un cicchetto.
Ma per me era come giocare la finale della Coppa dei Campioni.
I miei colori divennero quelli della mia nuova divisa, gialla con inserti azzurri, dalla trama come si usava nel 1991, dalle righine lucide e opache alternate in successione sopra a pantaloncini azzurro dalla stessa trama. I calzettoni gialli sulle Kronos completavano la mia figurina.
Desideravo ardentemente calzare le Diadora, chiudere i lacci intorno alla caviglia come si usava all’epoca e poi lasciare i calzettoni morbidi sotto il polpaccio. Ma le Diadora costavano un’esagerazione, così con mio padre barattai le Kronos delle quali però mancava il mio numero, ovviando con solette e nastro sulla calza nel tentativo di aumentare il volume dentro la scarpa.
Ma un Natale una zia mi fece un regalone: le Copa Mundial, tredici tacchetti.
La pelle morbida della prima volta che le accarezzai me la ricordo ancora, pelle che fango, erba, acqua e brina avrebbero rovinato col tempo, insieme ai lavaggi, obbligatori onde evitare la multa.
Non lo dicono mai, o forse lo dicono ma troppo poco e male, ma la disciplina è un’affinità elettiva che solo pochi sport insegnano. Nel calcio che ho amato io, quello che oggi chiamano romantico, esisteva, in ogni declinazione, in ogni più rosea prospettiva delle donne che saremmo diventate, anche nell’imporre la scarpa pulita e l’abbigliamento in ordine, dalla tuta alla divisa, perché andavamo a rappresentare l’immagine e la serietà del club, certo, un club piccolo di nicchia come era il calcio femminile a inizio anni novanta, una passione che molti vedevano più come imitazione del Mondiale maschile appena passato che come reale alternativa degli sport comunemente varati per le ragazze.
Quando vidi Simona al campo, quei tumulti che in tanti istanti sembravo controllare, quando facevo uno stop al volo di cui mi sorprendevo anche io, quel momento perfetto e preciso dello stok del pallone sul piede e sul cuoio che echeggia nel campo largo nelle voci ovattate delle compagne, quando mi esibivo in un dribbling allungadomi il pallone ma toccandolo comunque in mezzo, in quell’attimo da respiro mozzato della consapevolezza di un errore imminente qualora avessi perso palla, quando anche solo nella torsione della caviglia sulla pressione del mio corpo che sentivo veniva sostenuto in quella scintilla di godimento orgasmico nel riuscire a conservare il pallone dall’attacco del difensore appoggiandolo dietro a una compagna, anche solo nei dettagli che riconoscevo e che amavo follemente del gioco del calcio, quel controllo con lei non c’era, era perduto. E quelle domande mi uccidevano: chi ero?, chi ero davanti a lei?
Come una droga calmante, la concentrazione nel non perdere il posto in squadra mi sfiancava nell’impegnarmi in ogni allenamento. Volevo giocare, volevo giocare a ogni costo, sentivo di essere brava e di meritarlo, e quei tumulti che comparivano appena Simona spuntava tra la gente in autobus, nell’attesa che le porte sbuffassero nell’apertura automatica, negli sguardi lanciati dalla panca opposta mentre lo strap del nastro andava a chiudere il parastinco sopra la sua caviglia, non avevano effetto negli altri sguardi, quelli durante la partita, quelli in preda all’agonismo, vivi e lucidi sopra alle gote e alla punta del naso rossi.
Il campionato stava andando bene, tutto sommato.
Eravamo una squadra i cui risultati andava bene rimanessero nel mezzo, non troppo vicini alla vittoria del girone, non troppo desolanti sul filo della zona retrocessione.
Il referente della sezione femminile era un piccolo imprenditore del Montefeltro, di quelle zone intorno a Verucchio e che avevano a Santarcangelo gli uffici di vendita, quelli che dovevano apparire eleganti, da azienda del nord, un po’ come noi ordinate in campo e la figlia di Erminio Rossi, così si chiamava il referente, figlia unica si capisce, tracagnotta e bassa, una fotocopia giovane della madre, minuta e grossa anche lei, era un tipo di fisico che non rientrava in nessun modello femminile per gli standard dell’epoca.
Troppo grossa per la danza, troppo pesante per il pattinaggio a rotelle, troppo bassa per la pallavolo, troppo pesante per il nuoto, le limitazioni dei vari sport sembravano surreali eppure funzionava così, quello che si provava non importava, importava solo essere passabili per i ruoli e le maschere che dicevano essere quelli giusti. Ma l’unica figlia adorata di Erminio Rossi non poteva certo subire un’onta simile, per cui il padre costrinse i soci della società sulla quale investiva come sponsor cifre che superavano i sei zeri di vecchie lire ad aprire la sezione femminile, perché se la figlia non poteva eccellere in sport comunemente femminili che almeno fosse un esempio virtuoso in uno sport maschile.
Che alcuni dei miei ricordi più belli su un campo da calcio fossero dovuti all’affetto di un padre di fronte alle lacrime silenziose e dalla sofferenza profonda, mai colmata, di una figlia che nella vita si sarebbe sentita sempre in difetto e in ritardo su qualunque cosa, mi è sempre dispiaciuto, un dispiacere per un’ingiustizia di cui poi nessuno in realtà aveva colpa, ma che c’era. Eppure, nonostante questo, che tackle che faceva la Rossi!, un interno di centrocampo che macinava chilometri e chilometri, correva come una matta, recuperando qualunque pallone passasse dalle sue parti. Una volta, alla fine di una partita in casa, attorniata dalle reti verdi in plastica decorate con gli striscioni dell’azienda del padre, una scritta azzurra sfocata Erminio Rossi Costruzioni su un panorama non meglio identificato rosa e giallo, due su ogni lato del campo, le chiedemmo cosa provasse a giocare sempre attorniata dall’ombra del padre, fisica e non, anche sotto forma di pubblicità, e lei voltandosi da un lato e sputando in terra saliva raggrumata, asciugandosi poi le labbra con la manica, disse solo: “Cosa studio a fare se poi questa merda la devo mangiare ogni giorno, gliela metterei nel culo la sua fabbrica, a lui e agli altri che parlano solo in dialetto.”
Il campionato stava andando bene, tutto sommato. I malumori vari – in fondo eravamo pur sempre per la maggior parte ragazzine adolescenti che si affacciavano alla vita in quegli anni rispetto alle universitarie e qualche donna già sposata che componeva il resto della squadra – lasciavano andare con un’alzata di spalle le voci di corridoio che volevano, quasi pretendevano, quei risultati modesti per non investire più di quel poco che mettevano a disposizione e, qualora un investimento ci fosse stato, sarebbe stato comunque utilizzato per lo sviluppo del maschile.
Il nostro allenatore si chiamava Alfio Pedretti, Pedro per tutti, ex giocatore che in molti additavano come predestinato ma che poi navigò in serie minori fino al ritiro, perdendosi nelle aspettative oggettivamente troppo alte dopo le giovanili nel Cesena e nel mancato salto alla B nella quale giocò appena 12 minuti prima che l’arbitro fischiò la fine della partita e mai più utilizzato. Tuttavia, continuò a masticare calcio prima di aprire un’edicola che esiste ancora, in paese, a Ospedaletto, alternandosi tra l’arbitrare e l’allenare fino a quando qualche bicchiere di troppo gli fecero perdere ogni elasticità e decise di allenare, seduto e con il fumo della sua sigaretta mischiato al fiato del nostro respiro.Pedro allenava come quei padri che vogliono bene alle figlie ma fanno fatica a dimostrarlo, quei rudi omoni da campo di provincia, quello più duro, quello che oggi verrebbe chiamato dal basso, riscoprendo ciò che prima era solo necessità, urgenza prima che passione e se oggi conosco la tattica, lo devo solo a lui. Interminabili arringhe sui movimenti da fare quando Simona prendeva palla e organizzava il gioco, quando bisognava rientrare in difesa e sul come difendere, nella postura del corpo nell’attesa della giocata dell’avversaria, nel piazzarsi in marcatura sui calci da fermo. Aveva un suo disegno ben definito in testa su come dovevamo giocare che non riuscì ad attuare sempre, ma spesso sì e quando capitava, quando capitava… La sensazione di completezza che provavo alla fine di ogni partita che ci riusciva di interpretare come Pedro desiderava è qualcosa che mi porto dentro, nel tempo, la soddisfazione, la più incontrollabile soddisfazione che quasi trascende la modestia è altro che nel ricordare di averla provata, gongolo ancora, il sorriso a trentadue denti e la più pura e gioiosa delle felicità, nel battere il cinque alle compagne, nell’abbassarsi i calzettoni e uscire dal campo con i parastinchi in mano, nell’alzare lo sguardo verso il cielo come se quell’infinito sopra di noi fosse stato, almeno lui oltre agli astanti e ai soliti pensionati che poi ci presero in simpatia, almeno lui nell’eternità del mondo parallelo nel quale quei ricordi sarebbero stati indelebili, almeno lui testimone di quella grandezza dipinta sul rettangolo di gioco.
Venivamo da una di quelle partite quando arrivò quella domenica di aprile, una qualunque domenica nella quale l’aria sapeva di primavera assopita e di estate alle porte, una qualunque domenica per chiunque avesse vissuto lontano dalla nostra orbita.
Era il 12 aprile 1992.
Contro l’obiezione delle famiglie che volevano le proprie figlie la domenica delle Palme, domenica che a detta loro non avrebbero passato comunque insieme, a parte il pranzo, molto meglio così, precisarono, sul campo da calcio. Silvia, ragazzetta solare e molto timida la cui scaramanzia faceva entrare in campo saltellando sempre tre volte sul piede destro appena varcata la linea laterale, aggiunse che quel campionato sarebbe comunque finito male a prescindere dal risultato, “costretta” a suo dire durante le vacanze pasquali ad andare con la famiglia a Euro Disney inaugurato proprio quella domenica. Un viaggio premio, disse negli spogliatoi, premio per modo di dire in quanto il padre, speleologo, in quegli anni aveva “sputato sangue” nel tentativo di presentare un progetto idoneo a sfruttare al meglio i laghetti naturali intorno alla zona di Cervia, sito scelto come ideale nella realizzazione del progetto Euro Disney da parte dell’Italia sul tavolo degli americani, viaggio che per il padre di Silvia significava l’ennesimo schiaffo in faccia per un uomo che voleva semplicemente fare bene il suo lavoro. Con il tempo in Romagna sarebbe diventata barzelletta, specie quando in riparazione venne aperto Mirabilandia il luglio di quello stesso anno, quella per cui mentre francesi e tedeschi si mettevano a lavorare a testa bassa valutando ogni minimo dettaglio per avere nel proprio paese il parco divertimento più famoso del mondo, gli italiani erano ancora a litigare tra loro quando i francesi sciabolavano lo champagne esultando per la vittoria del progetto.
Era domenica 12 aprile 1992 e noi, sorprendentemente e contro ogni previsione, ci andavamo a giocare la vittoria del girone con conseguente promozione, promozione mal digerita dalle parti alte della società, ma pur sempre conquistata sul campo e insindacabile.