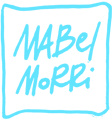Racconto.
2 di 4.
Qui la parte 1.
La prima volta che mi accorsi di lei si stava raccogliendo i capelli in una coda.
Portava sempre i capelli sciolti, ricci che perdevano il boccolo appena crescevano di qualche centimetro in uno di quei tagli scalati che andavano tanto di moda all’inizio degli anni ottanta. Non ho idea se porti ancora quel taglio, non ho idea se l’incavo delle sue guance nella magrezza estrema che può avere una ragazzetta di dodici, tredici anni, sia oggi circondato dalle rughe di trent’anni dopo, ma nel 1988 circondati a nostra volta da un mondo che sembrava fermo ma stava indissolubilmente cambiando per sempre, dalla morte di Andrea Pazienza al primo Milan berlusconiano, dall’imminente caduta del muro di Berlino alla fine della prima repubblica, i nostri occhi erano ancora limpidi.
Io avevo imparato a giocare a pallone da sola, in mezzo alle poche all’epoca auto parcheggiate sotto casa e in mezzo a strade pressoché deserte. La mia porta era il garage di casa, un garage grande delle palazzine di una volta, quelli nei quali ci stavano due auto affiancate oppure mobilio vario e motorini e biciclette, finanche perfetto da arredare come studio di musica, e la mia barriera il cancello basso, un cancello quasi inesistente se inteso come accezione a una proprietà privata.
Tutto quello che vedevo in televisione cercavo di riprodurlo: un certo modo di calciare, un certo modo di dribblare, un certo modo di correre. E mi allenavo, a modo mio, senza allenatori. Non c’erano altre ragazzine e quando c’erano facevano altro, non giocavano certo a pallone. Solitudine che andava marcandosi anche per la mia altra passione, quella per i fumetti, per cui quando Paolo, un catechista di ampie e moderne vedute che organizzava anche troppo rispetto a ciò che gli si chiedeva, ci distribuì le maglie giallorosse in lanina che pizzicava senza una maglietta della salute sotto, nella calca della scelta dei numeri di ragazzette che non avevo mai visto o al massimo intravisto in qualche funzione domenicale, a me capitò il numero 14.
Anticipando ciò che sarebbe accaduto almeno poco più di un lustro dopo, le squadre del primo torneo di calcio femminile tra parrocchie non avevano la numerazione classica dall’1 all’11 ma ogni giocatrice aveva il suo e se schierata tra i titolari giocava anche con uno normalmente da riserva.
Mi raccontarono anni dopo che quel torneo nacque tra bevute scherzose tra scout e chiacchiere e sogni e progetti durante viaggi in pullman organizzati dalla parrocchia, tra canzoni dei primi Elio e le storie tese e prime cotte, in fondo l’epopea avventurosa e romantica alla Goonies era ancora molto viva, impensabile nella fruizione feroce del nuovo millennio che in ogni caso sembrava lontana anni luce da noi e dal nostro universo di jeans a vita alta e Timberland col salsicciotto con il pupazzetto penzolante da un’asola del laccio bicolore. Un giorno assistetti a un dialogo tra Paolo e un catechista di un’altra parrocchia: discutevano sull’importanza del dare gli stessi diritti alle donne, in quel caso specifico anche solo nell’organizzazione di un torneo di calcio femminile. L’interlocutore di Paolo, pur poi partecipando con una sua squadra, aveva un atteggiamento più da missionario che da allenatore; era evidente il suo sentirsi superiore come se una parte di sé fosse comunque contraria a quell’opportunità a noi ragazze.
Non mi sono mai premurata di pensare che non potessi fare qualcosa solo perché la società circostante mi imponeva o mi faceva pensare che fosse sbagliato. Non avevo mai distinto maschio e femmina in alcuni ambiti; certo, a scuola dalle suore c’erano i bagni separati, i grembiuli erano di colori diversi, gli sport che venivano praticati erano influenzati da una cultura patriarcale e maschilista, ma io ero una bambina e questi aspetti non li consideravo affatto, proprio per quell’ingenuità tipica dell’età. Per cui, per me ragazzina che voleva semplicemente giocare a pallone, esisteva solo una regola: se ero brava, se ero più brava di qualcun’altro, meritavo di giocare. Non esisteva maschio o femmina nel calcio, per me, eravamo solo persone, esseri umani che desideravano un pallone tra i piedi e, possibilmente, cacciarlo in fondo a una rete.
Come poteva essere questo blu o rosa?
Si chiamava Simona, un nome oggi praticamente sparito e chi lo porta ha almeno quarant’anni sulle spalle. Veniva dalla campagna, dicevano, dalla periferia. Lo dicevano bisbigliando tra i denti, come se la provenienza avesse potuto incidere sul giudizio, semmai ce ne fosse stato bisogno, della giocatrice o peggio, della persona, con quella infantile e inconsapevole discriminazione che porta spesso a commenti terrificanti. Va da sé che la periferia del 1988 è ciò che oggi è considerato centro, ma sarà stato essere ragazzette e tutto sembrava più grande, forse lo era, certo è che Simona per venire a giocare con noi ci metteva quasi un’ora di pullman. Del perché certe semplici regole, come l’appartenenza alla parrocchia, venissero bellamente ignorate e sovvertite rimase un mistero, ma fu allora che capii che forse non ero del tutto sola.
A vederci lì, in fila tutte insieme, allineate sulla linea laterale del campo in una fantomatica carrellata cinematografica in una lenta sequenza in piano americano, la squadra messa in piedi da Paolo somigliava a un esercizio tra i più riusciti di fisionomie per mano di un abile sceneggiatore. Qualche anno prima avevo visto un cartone animato sulla pallavolo, nell’ennesimo tentativo di inculcare differenze sostanziali tra maschi e femmine, inconscio all’epoca come lo era per me che lo guardavo: ebbene, ogni personaggio tipico poi del disegno giapponese si distingueva per qualche spesso piccolo ma fondamentale dettaglio, dalla protagonista con le lentiggini e il taglio sbarazzino all’antagonista ma grande amica dai capelli lunghi e gli occhi chiari, alle amiche, quella piccolina e magra, quella più robusta, quella dai capelli ricci e gli occhiali, quella con i denti sporgenti, eccetera, fino all’allenatore, maschio s’intende, bonario e aitante nella tuta di acetato.
Si poteva dire che seguissimo involontariamente quella fisionomia da cartone animato, ma fu del tutto casuale.
All’esordio, sotto l’imperioso campanile della chiesa di San Niccolò, nel campo dove si accendeva una delle fogheracce più maestose durante la notte di San Giuseppe, proprio lì in mezzo nel cerchio del centrocampo nel quale, la notte dopo, di quel fuoco si raccoglievano solo i resti del bruciato in una macchia nera dall’odore pungente, al fischio dell’arbitro Gianna calciò in avanti al nostro numero 9 fittizio perché indossava il 12 il primo pallone della nostra squadra.
Sul foglio ciclostilato strappato da un blocco e scarabocchiato sopra le scritte da un lato il nostro schema e dall’altro la nostra formazione, la calligrafia di Paolo, futuro medico, era incomprensibile ma elencava: Maura in porta, Sue Ellen terzino destro, Veronica stopper, Sharon libero, Titti terzino sinistro, Claudia ala destra, Simona mediano, Silvana interno di centrocampo, io ala sinistra, Gianna mezzala e Pamela attaccante.
Non era colpa di nessuno, o forse sì, forse era colpa delle mode e dell’invasione delle soap opera americane, ma se si pensa anche solo alla Gradisca o alla tabaccaia felliniana, non è difficile immaginare che l’idea di rimanere collegati a un universo che non ricordasse costantemente la provincia – seppur turistica e di riviera, seppur folcloristica nella rappresentazione cinematografica, comunque bassa, di estrazione contadina e di poca cultura, di lavoratori infaticabili, di botteghe e di mercati -, era sottolineata anche solo nel chiamare le figlie femmine con nomi esotici di ereditiere texane, così lontane da quella terra dura e da quelle nebbie piene da giustificare quei nomi di campi aridi e bagnati dal sole che avrebbero poi portato non pochi problemi a quelle stesse amate figlie. E di certo in Romagna non mancava l’ironia, soprattutto in quella rivolta a se stessi, per cui avere compagne che si chiamavano Sue Ellen e Sharon a parte l’iniziale incomprensione non portò nessun effetto collaterale.
Affrontavamo la squadra del San Niccolò, allenata da un compagno di università di Paolo. Anche le altre sembravano ben assortite.
Molte di noi andavano a scuola in bicicletta o lasciate dai genitori davanti l’ingresso prima di recarsi al lavoro, tante altre iniziavano a prendere l’autobus in quell’importante processo di fiducia e responsabilità del recarsi da sole in un luogo. Io ero una di queste e Sharon pure: quel fine settimana avremmo giocato insieme la nostra prima partita.
L’aria era umida, l’aria di mare in ottobre lo diventa sempre.
L’Arco d’Augusto prima che venisse chiuso in un’isola pedonale eliminando di fatto prima il parcheggio tattico leggermente esterno ma comodissimo e poi persino le strade che lo circumnavigavano, aveva ai lati le fermate dell’autobus, poi spostate nella riqualificazione del monumento.
Sharon mi si avvicinò aspettando come me il 7.
“Posso chiederti una cosa?” mi domandò.
“Certo.” risposi io.
“Il piatto si fa così?” disse mimando il gesto e provando a interpretare il calcio col piede teso.
Era una bellissima giornata nonostante il cielo fosse grigio, fresca, di quelle che sembrano voler salutare le temperature miti ma fanno finta.
Indossavamo le nostre maglie giallorosse in lanina e loro, le avversarie, casacche in acetato azzurro Napoli.
Perdemmo 15 a 0.
Ne perdemmo altre, quasi tutte, senza un miglioramento apparente. Non certo in tattica, non certo in atletica.
Nel campo dietro la chiesa ai confini del parco giocai la mia unica partita come libero, in sostituzione di Sharon che, come molte altre, iniziarono a defilarsi fino all’abbandono riconsegnando, lavate, le maglie giallorosse in lanina.
Non ci fu più, che io sappia, nessun campionato parrocchiale di calcio femminile.
Finì lì, come quando calava la notte dopo il tramonto su quel campo che oggi non esiste più, trasformato in un ampio e luminoso parcheggio.