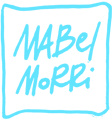Racconto.
1 di 4.
C’è una cartolina.
L’ultima volta che ne spedii una è capitato a Sestri Levante. Tra coccodrilli gonfiabili e fenicotteri rosa, tra le confezioni di bocce da spiaggia, due gialle, due blu, due rosse, due verdi e il boccino bianco, tra costumi e occhiali scintillanti, due espositori vissuti dal continuo girare avanti e indietro, consumati dal frenetico movimento di un tempo glorioso e ormai persino poco oliati, sono pieni di cartoline.
Accanto ai prodotti più nuovi evidentemente più richiesti, quelle risme di cartoline sembrano abbandonate, anche a loro stesse, incuranti dei turisti che non se le filano più, macchiate dal sole, qualcuna stropicciata dalla pioggia, qualche altra impolverata e ingiallita.
La cartolibreria che mi appare all’improvviso oltre la strada guardando a monte, verso una zona residenziale e incorporata in un palazzo di condomini immagino io non più molto arzilli considerata la calma intorno, è in realtà un emporio che sembra vendere qualunque cosa, dalle buste gialle imbottite agli sparabolle col giochino sul coperchio e poi, quelle cartoline.
La signora seduta fuori sotto la tenda, unica presenza umana sotto quel sole a picco della tarda mattinata, quasi appassita nella sedia da regista in legno come quelle di una volta, a differenza di quella giovane, dentro, nella tiepida temperatura dell’aria condizionata, mi guarda dietro i suoi occhiali dalle lenti grandi. Sorrido cortesemente salutandola. Si potrebbe pensare che vedendomi io possa cercare qualcosa di nuovo, invece no, quello che cerco sono proprio quelle cartoline, una in realtà, come si usava un tempo, una cernita pensata e pensosa dell’immagine che andrà a rispecchiare al meglio la mia vacanza a chi la riceverà.
Ecco, c’è questa cartolina, quella iniziale.
Come quel negozio a Sestri, ce n’era un altro, a Rimini.
Piccolo, affacciato da un lato a una galleria e dall’altro sulla strada, quadrato nelle sue due vetrine spaziose, la cui porta d’ingresso sbatteva sempre agganciandosi male nella serratura. I vetri vibravano in continuazione a ogni alito di vento e l’entrata di qualcuno poneva il cliente in imbarazzo costante, col timore di interrompere qualcosa e di disturbare troppo. Il pavimento era di piastrelle rettangolari bianche con incastri di quadratini blu, in un gioco psichedelico delle costruzioni dei settanta. Adoravo quei pavimenti, li adoro ancora oggi, mi ricordano la mia infanzia, le mie prime volte, ma soprattutto il periodo nel quale imparavo a capire che ero un essere pensante e che avrei potuto scegliere, scegliere con libero arbitrio soppesando che le conseguenze anch’esse sarebbero state parte di quella scelta originaria.
Prima che i centri storici delle città di provincia italiane divenissero scrigni il cui accesso era consentito solo ai pedoni e alle biciclette, prima che i ciottolati venissero ricoperti da asfalto rosso antipioggia quando le leggi di una volta permettevano l’esistenza di botteghe che potevano vendere un po’ di tutto, ecco prima del tempo che stiamo vivendo adesso, una di quelle bottegucce da paese – echeggia ancora nei miei ricordi il suono della voce di mia madre quando mi diceva di passare da Achille, il droghiere, a ritirare i tessuti che aveva ordinato e io, piccola, curva su una bicicletta troppo grande per le mie gracili gambe, pedalavo nella nebbia del parco, del Marecchia scuro e pericoloso, attraversando il borgo e poi il Ponte di Tiberio – vendeva anche le cartoline. Ancora più vecchie se possibile, con immagini di una Rimini che non esisteva più già allora, di quelle dalle palette sature riprese evidentemente da fotografie in bianco e nero e colorate con la tecnologia dell’epoca.
Una di esse è una veduta della città dall’alto.
In questo cielo terso, la scritta Rimini campeggia in una grafia tipica di quegli anni, sotto un mare Adriatico che bagna la lingua di sabbia lunga, interrotta dalle cabine e dal lungomare.
La fotografia è stata scattata da un elicottero e comprende il panorama che risultava più appetibile per l’estate: il mare, la spiaggia, il faro, il porto o almeno una parte di esso, quello turistico, non certo quello con i bilancioni dai cui scogli io e i ragazzetti che frequentavo solo nei mesi caldi, ci tuffavamo, rinfrescandoci, lontani dagli sguardi di genitori spesso poco permissivi.
Oltre però, si intravedevano i primi pini marittimi e le prime abitazioni che non fossero l’altra lingua che caratterizzava e caratterizza ancora oggi la riviera, quella inesorabile degli alberghi e della massiccia ondata di urbanizzazione che spolverava in un batter di ciglio le vecchie villette coloniali, quelle dai portici ad arco, arabeggianti persino, con torrette graziose che sfidavano le urla del mare in inverno.
Ecco, oltre, scorrendo con lo sguardo verso il campanile, non quello, quell’altro, quello più piccolo in prospettiva, quello con la punta dal richiamo gotico, accanto a case che iniziavano ad avere tetti e comignoli, antenne da condominio e lenzuola bianche stese che danzavano nel vento, proprio lì, un puntino verde, che non lo era naturalmente ma che il colore dal bianco e nero ha reso tale, quello era il campo da calcio, il mio, quello dove ho imparato a giocare a pallone.
Dal basso e non dalla veduta aerea, arrivare al campo che non era verde ma di ghiaia, quella ghiaietta di sassolini bianchi e terriccio che alle prime gocce di pioggia si trasformava in una pantano, significava imboccare viuzze di pavè scivoloso e attraversare l’unica grande arteria che collegava la città col lungofiume, la via Emilia, non tanto quella paranoica ma decisamente quella che sarebbe stata riprodotta nei club che spuntarono a metà anni novanta in riviera, dando lustro quantomeno a quella pianura padana piatta e ferma, vivida invece nelle notti sul mare, salvarsi poi sul marciapiede di Piazzale Vannoni salutando Aldo l’edicolante che metteva via il Guerin Sportivo per il babbo e i fumetti per me, per poi perdersi nel borgo fino al campo da calcetto, superandolo sulla destra entrando nel chiostro, sotto i portici, nel cortile con il pozzo nel mezzo, entrando in quel microcosmo che è l’oratorio e la vita intorno a esso.
Il borgo delle casette basse e strette, quello che durante la festa dedicata lasciava che le porte delle abitazioni si aprissero ai pellegrini offrendo loro ciambella e vino per un ristoro propizio prima di riprendere il viaggio, lo stesso borgo che venne salvato dal successo di quella prima festa, nel 1979, il vecchio borgo dei pescatori, felliniano d’adozione che avrebbe dovuto essere rastrellato per fare spazio a una zona residenziale, quello stesso che negli anni è diventato d’elite dalla ristrutturazione fino ai prezzi esorbitanti di oggi. Nei miei primi tredici anni però manteneva ancora quell’aura umida, scura e uggiosa, dagli angoli magici a saperli guardare.
Il campo rimaneva poco oltre, al limitare del parco, dietro a palazzi che abbracciavano apparentemente come ombre sicure quella stesa verde e nebbiosa negli autunni più bui.
I ferri dei pali erano già al tempo rossi di ruggine, il bianco io non lo avevo mai visto. Non c’erano nemmeno i riflettori per cui si poteva giocare solo con la luce del sole, anche se le partite con la nebbia al calare del giorno hanno lasciato ricordi indelebili tramutate in leggende che ogni tanto si ascolta ancora, con un bicchiere di vino tra le mani, al bar del borgo dietro proprio quel campo, appena davanti alle case di ringhiera nel cui cortile una volta venne spedito un pallone mai più ritrovato, calciato malamente da uno dei nostri.
Tuttavia era un bel campo, curato il giusto con le strisce di gesso non sempre nette e con le bandierine dei calci d’angolo mai usate, segregate in uno degli armadi dei refettori della parrocchia aperti solo per le lezioni di catechismo.