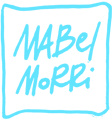L’ultimo Giro d’Italia raccontato su RaiRadio1 da Emanuele Dotto nel maggio 2019. In compagnia del campione olimpico, ora commentatore, Silvio Martinello hanno regalato perle. Perché l’epica del ciclismo passa anche dalle voci che ce la raccontano.
E’ il 1991.
A fianco a me, seduto apparentemente incurante della partita che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi nel meraviglioso palcoscenico dello Stadio Meazza in San Siro, un signore dai capelli canuti sotto un berrettino nero da baseball in velluto e vestito di scuro, sussulta con un auricolare nell’orecchio.
E’ domenica e le partite del campionato di calcio si giocano tutte in contemporanea alle ore 15.
Lo osservo, seguo il filo dal suo orecchio fino alla tasca della giacca. Spunta l’angolo di una radiolina portatile.
Il Milan segna, io alzo le braccia e urlo; insieme a me altre cinquantamila persone e un po’ anche quel signore, non stupito più di tanto.
Sono gli anni degli Invincibili, al Milan vincente e sontuoso i tifosi si sono abituati, a stare lassù, a vederne i trionfi, ai sorrisi delle coppe in mano scendendo dagli aerei e ancora oggi si è in riserva con l’appagamento di quei tempi.
Gli applausi e il frastuono nella cattedrale scemano diversi minuti dopo. Io li sento ancora.
Nel silenzio enorme dello stadio vuoto, sento ancora quell’incitamento.
Come su una strada, dopo che è passata una corsa ciclistica.
Ne si vede una versione nuova di quella strada, agghindata a festa, con transenne e cartelloni pubblicitari finanche traguardi volanti. Prima le indicazioni del Comune, sulle sue pagine social o sui giornali, le avvertenze sulle chiusure anticipate delle strade e quelle alternative nel caso, ‘che poi c’è sempre qualcuno che non lo sa, si ritrova nel traffico congestionato e si lamenta.
All’ultimo Giro – passato da Senigallia sotto il cui traguardo volante scatta Damiano Cima della Nippo Vini Fantini su Marco Frapporti della Androni Sidermec e Andrè Demare della Groupama FDJ -, aspetto che passino tutti i corridori, tutte le ammiraglie, tutta l’organizzazione, tutta la carovana che una grande gara si porta dietro.
Ciò che lascia però sono persiane aperte, sorrisi, applausi, una festa improvvisa e tante chiacchiere con gente sconosciuta con cui condividere un momento, seppur breve, di assoluta felicità.
Rimango lì, prima di prendere la mia, di bici, una da passeggio col cestino in plastica perché dopo l’incidente in Vespa la mia schiena e gli anta mi hanno detto addio alla finta sportiva che fui.
Rimango lì a sentire il lento riprendere del traffico quotidiano, come un risveglio all’alba: il primo furgone di consegne, l’utilitaria subito dietro, un’auto grigia, fino a che anche il profumo della corsa è sparito. Rimango lì a osservare anche l’ultima transenna portata via.
Riprendo la bici e ascolto la gara dalla app della radio sullo smartphone.
Il Giro, dal vivo, mi manca già.
E’ il 1995.
Io e mia sorella siamo nella cucina della vecchia casa del borgo.
La casa è quella nella quale sono cresciuta, i miei ricordi di quella cucina hanno sfumature gialle, quelle sfumature sfocate del taglio della luce di quegli anni, forse per via delle tende luminose, ma ho queste immagini sul giallo, sull’arancio, un qualcosa di caldo.
La cucina era la tipica cucina vivibile, di quelle grandi con divano e televisione, delle case di una volta, quello spazio casalingo in cui passi molto tempo, il tempo vissuto, e sui ripiani c’è la vita, quegli oggetti che usi, che non sono lì sopra giusto per, dal rotolo dello Scottex ai barattoli di caffè e zucchero, dalla bottiglia d’olio al contenitore dei cucchiai in legno, dal bollitore dell’acqua al tostapane, e lì, tra tutti questi oggetti, una vecchia radio bianca degli anni ’70, di quelle con la rotella laterale, qualche pulsante sopra, il nastro nero su bianco delle frequenze radio e i numeri a casella che scattavano ogni minuto.
Quando si è piccoli o adolescenti, la cucina non ha ancora assunto un significato preciso per te giovane creatura che cerca di capire l’esistenza; per te è solo una stanza che c’è in casa ed è prerogativa della mamma, ci stanno i grandi e tu sei un intruso in un mondo che non ti compete o per il quale non sei ancora pronto. Poi si cresce, si diventa donna e la cucina assume significati nuovi, diversi, non è più una parte di casa inaccessibile.
Non ricordo cosa stiamo facendo, io e mia sorella, non ricordo che ora fosse, ma a un certo punto passa questa melodia dolce, questa nenia godibilissima. Mi chiedo chissà chi canta questa canzone. Ci metterò giorni a scoprirne il titolo. Come una volta, ci si metteva tempo a conoscere le cose.
Come la bicicletta.
E’ mio padre che mi ha insegnato ad andare in bicicletta, è lui che mi ha dato il coraggio di andare senza rotelline laterali la prima volta.
Ricordo ancora la sensazione di controllo su qualcosa che non fosse un prolungamento del mio corpo, un braccio o una gamba di cui potevo comandare i gesti, e quell’idea di possibilità.
Ricordo il cortile sotto il balcone della casa del borgo, con la mamma alla ringhiera a fare il tifo, mentre, nell’aria, ascoltavamo forzatamente la musica soffusa dalla radio del vicino dal suo garage.
Ricordo ancora quando mi regalarono la prima, una seria dopo la bici da cross i cui salsicciotti mi vennero rubati un giorno, in spiaggia, nella Rimini nella quale sono cresciuta.
La bicicletta, prima del motorino – fase quasi obbligata in quella parte di Romagna motorizzata che strizza l’occhio alle alte Marche e alle sue sgasate – è stata la mia compagna di viaggio, la mia fedele amica, la mia libertà.
E’ stato sempre mio padre che mi ha appassionato al ciclismo.
Bicicletta, radio, bocce.
Biglie di plastica con le figurine dei ciclisti sulle piste della riviera romagnola costruite sulla lunga battigia prima del mare.
Il Tango della Mondo, il Super Santos, il Cucciolone con le vignette di Giorgio Cavazzano.
Il mio testamento, nei confronti di me stessa e per rispetto ai miei ricordi.
Bicicletta, radio, bocce.
Simboli di un’Italia che non c’è più, simboli di un’Italia ancora viva in qualche anfratto di borghi vecchi e polverosi, di anziani che forse non hanno più voglia di raccontare e ricordare, come semplici foto appese ai muri, muti e silenziosi, immagini che guardano dritto, senza risposte, non più almeno.
In Francia, ogni tanto, in qualche baretto della Provenza che guarda alla piazza del paese, sotto una pergola avvinghiata di viti, a sorseggiare un Pernod e ad assistere ai signori che danno di petanque.
In Francia sì, ogni tanto la si rivede ancora, come da noi.
In Liguria per esempio, alla bocciofila di Chiavari, o alla sede della Federciclismo in una strada dietro il fiume Entella. Ogni tanto, in quelle estati ferme, sonnacchiose, fresche per quella brezza del mare in lontananza. Una radio ad aggiornare del Tour in sottofondo tra il frinire incessante delle cicale.
Di recente, mi è capitato di vedere una fiction del regista Pupi Avati.
Nelle sue storie, la sua Bologna, la Bologna da cui è partito il Giro 2019, per noi riminesi e aspiranti laureandi è sinonimo di bicicletta.
La Bologna di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” (che non è di Avati ma tratta dall’omonimo best seller di Enrico Brizzi, altro bolognese doc) nel quale il protagonista interpretato da Stefano Accorsi, già incrociato nel suo primo ruolo proprio in un film di Avati, nel tentativo di riconquistare la lei del primo amore che pare eterno per poi svanire come ricordo adolescenziale, percorre in bicicletta quella che sembra la salita di San Luca come un disperato corridore alla rincorsa di Coppi.
Ma nelle storie di Avati, il regista racconta anche e spesso dell’Italia del dopoguerra e di famiglie, dei cambiamenti che governi, società, decenni hanno irrimediabilmente trasformato in quella che oggi è l’epoca moderna.
In una scena in concomitanza degli anni del boom economico, nella ristrutturazione del salotto appare la prima televisione, in sostituzione di una radio. Una di quelle radio imponenti, ingombranti persino, messe presto in cantina o in soffitta o addirittura vendute, di quelle che si vedono restaurate nei negozi di antiquariato e vintage in seconde vite inaspettate, una di quelle che sono nel mio salotto.
Io sono nata a metà dei settanta, figlia poi degli anni ottanta, delle musicassette e delle canzoni con i deejay che parlano o all’inizio o alla fine nel tentativo di registrare sul nastro la propria canzone preferita.
E della radio.
Dello sport visto alla radio.
Prima della tv, prima dei supporti digitali, prima di internet, era la radio il mezzo più veloce per sapere cosa accadeva: nel mondo, nello sport, nella musica.
Il gracchiare delle frequenze mentre si cercava quella giusta con la rotellina, quella del volume, troppo alta o troppo bassa, l’antenna abbassata o allungata e bastava un alito di vento a storpiare musica e parole, le pile se la si voleva portare in giro, la presa elettrica in casa se la si ascoltava sul mobile della cucina mentre le madri e le nonne avviavano pranzi e cene.
A metà anni ‘90, con un benessere crescente, le radio, su quei ripiani venivano sostituiti dalle tv, di piccole dimensioni, le prime col telecomando.
Ma lo sport, il ciclismo soprattutto, è passato molto dalla radio: ne ha raccontato l’epica, i suoi protagonisti e le loro imprese.
Come Mario Ferretti.
Come, in epoca più recente, Emanuele Dotto.
Se ogni tanto sentite nei contesti più vari la frase “C’è un uomo solo al comando” sappiate che fu proprio Mario Ferretti a pronunciarla, sappiate che la disse durante il Giro d’Italia del 1949, sappiate che continuava con “La sua maglia è bianco azzurra e il suo nome è Fausto Coppi.”
La tappa era la Cuneo – Pinerolo, non facile nemmeno ora con le strade asfaltate, immaginatela in ghiaia e sassi, immaginatela a tornanti senza nessuna protezione sulle curve.
Fu la famosa tappa nella quale lo stesso Ferretti all’arrivo di Coppi – che aveva dato quasi 12 minuti a Bartali – disse anche, parafraso: “È arrivato Fausto Coppi, per il secondo aspettiamo e trasmettiamo musica da ballo” e fu la famosa tappa che vide Pierre Chany, giornalista dell’Equipe, scrivere “[…] nella poltiglia del Maddalena, l’ho visto (Coppi, ndr) venire via dagli altri. Sfangava, quasi sollevando la bicicletta. Lo accompagnai fino a un paesino francese, mi pare Barcelonette. Lo lasciai andare. Entrai in una trattoria. Ordinai un pasto completo dagli ‘hors-d’oeuvre al caffè. Mangiai con tempi da buongustaio. Fumai una sigaretta. Chiesi il conto. Pagai. Uscii. Stava passando il sesto.”
Emanuele Dotto ha ripreso molto da Ferretti, decenni diversi hanno modificato il modo di fare radio e a Dotto la battuta sarcastica non è mai mancata. Non è mai mancata nemmeno la caramellina per la gola con cui succiava in diretta e nemmeno l’accento genovese più marcato nei momenti di alterazione.
L’ultimo Giro lo ha raccontato con Silvio Martinello, campione di ciclismo su pista e strada (5 ori olimpici) in dirette professionali ed esilaranti, mai sopra le righe e in collegamenti nei quali si respirava una chimica nella squadra di giornalisti, commentatori, tecnici, motociclisti unica.
Come le dirette Twitter, come quella del 24 maggio nell’arrivo a Ceresole Reale, tredicesima tappa vinta da Ilnur Zakarin, nella quale, durante lo smantellamento del campo del tv – compound, continuavano a passare altri giornalisti davanti alla camera. Dotto stava lì, mani dietro la schiena, mano a tenere il berrettino rosso da baseball, mano a cercare qualcosa in tasca, rispondeva alle pagelle di Martinello e rispondeva anche a chi passava continuamente intralciando visivamente il collegamento, con quell’accento genovese di quando è irritato.
Martinello che prima ancora formava con Francesco Pancani un’altra coppia amatissima dagli telespettatori, si è cimentato con la radio ammettendo un “Ho imparato moltissimo” nel salutare Dotto.
L’epica del ciclismo passa anche dalle voci che ce la raccontano. L’epica dello sport passa soprattutto dalle voci e da quelle frasi che poi sono diventate mitiche.
Simboli, di tutto, che si vedono nei vecchi bar dalle insegne arrugginite, dalle cabine del telefono vuote di apparecchi, dalle fotografie in bianco e nero appese sul legno che riveste le pareti.
Emanuele Dotto è una biblioteca vivente, pieno di passioni culturali e culinarie.
Nasce a Genova, una città che è un segno indelebile, per chi ci nasce, per chi la sceglie da profugo, per chi ci va a vivere, per chi ci passa appena, per chi la canta da Marassi e per chi l’ha cantata da una spiaggia piccola, di sassi e focacce e vino, da una barca a remi blu e bianca ormeggiata ormai come omaggio scrutata dalle bandiere del Genoa appassite sotto il sole dei lucernai dei portoncini.
Come la sua radiocronaca sul Mondiale di Bergen, la sua caramellina e le sue opinioni sui prezzi non certo economici della Norvegia.
Come tutte le dirette di quella generazione lì di giornalisti, gente che ti faceva vedere la strada, ti faceva stare nei luoghi dove si svolgevano le corse, ti faceva respirare l’aria intorno, ti faceva sentire la musica del vrrrrrrrrr delle biciclette, quel suono magico dei raggi e della catena che scorre.
“Tutti utili, nessuno indispensabili” usava dire nel giustificare il suo operato in RAI, un giornalista puntuale, serio, competente, che ha raccontato le gare ciclistiche con passione e professionalità, e, certo, la sua Alessandria, e la Sampdoria e il Genoa.
L’ultimo Giro di Emanuele.
Grazie Emanuele.