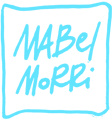Una libreria che oggi non esiste più, sostituita da una di grande catena; un padre e una figlia: il primo, sigaretta pendente dalle labbra, a osservare il reparto cancelleria, la seconda, sparuta e magrissima, a girare tra i corridoi di libri, che oggi come allora avrebbe comprato in toto.
13.000 lire sul prezzo di copertina, un’edizione del 1978 comprata a metà anni ’80, una frase sbuffante del padre alla domanda del poterlo comprare e una minaccia: “Ma poi lo leggi!” e oggi tenere fede a quel sottile “Sì” sussurrato e poco convinto pronunciato quasi trent’anni fa.
La libreria in piazza Tre Martiri a Rimini rimane sotto uno dei portici, quello che va verso l’Arco d’Augusto.
Nella mia memoria di bambina, ricordo tutto dei cambiamenti della piazza: dal ciottolato con i giardinetti nel mezzo, al semplice ciottolato e alle fermate d’autobus sotto la torre dell’orologio, agli stessi autobus che passavano imperterriti e ai parcheggi, prima dalle strisce bianche, poi a quelle blu, fino a far sparire del tutto la circolazione di qualunque mezzo dalla piazza. Poi hanno rifatto la pavimentazione, nel rifarla hanno scavato e trovato resti romani (come al solito) e sono diventate oasi di ringhiere felici per le biciclette; ma ora, un sole visto dall’alto orna la piazza, un sole scivolosissimo quando piove, un sole che è diventato il centro perfetto per l’albero di Natale.
Se non che, l’unica vera pietra storica romana, a parte le scoperte e qualche altra sopra il sole pestata senza nessun rispetto per la storia è il basamento della statua di Giulio Cesare, abbandonato dietro un’edicola ora definitivamente chiusa da cessata attività.
Non so se sapere queste cose mi fa stare bene, ma le so: forse un giorno sarò come quei vecchi che raccontano storie così, senza senso agli occhi di giovinetti che vogliono solo guardare Instagram e godersi ciò che significa la vita per loro. Ma le so, e da qualche parte queste parole finiranno.
Così come ogni negozio è un ricordo: la drogheria è rimasta simile (ma non sono tanto convinta che venda ancora gli stessi prodotti), la farmacia all’angolo e il negozio di abbigliamento che da sempre, salvo qualche cambio repentino e rientrante, è la Benetton. E la libreria: i nomi e i passaggi di marchio per me bambina erano incomprensibili, oggi da adulta sapere che il marchio alla fine era sempre Mondadori non mi cambia poi così molto.
Cecilia, in “Fino a qui tutto bene”, dice alla protagonista che va a prendere l’autobus in piazza: lo specchio dei tempi, i miei 16 anni, passare davanti al Cinema Sant’Agostino e sbirciarne i cartelloni, andare oltre, o tagliare per via Sigismondo, ma via Cairoli, l'”andare oltre” cioè dritto, nella sua lunghezza, era la via di Soci – il negozio che esiste ancora di macchine fotografiche e dove stampavano i negativi delle foto, oggi modernizzato -.
I miei piedini sono chiusi in espadrillas di corda e tela.
L’aria condizionata è retaggio della favolosa America degli anni ’80, timidamente anche a Rimini arriva, ma le estati non sono ancora così torride come oggi, le estati della mia infanzia sono secche, per cui la dolce aria condizionata chimica è molto bassa, soprattutto nella libreria, nella quale se ne fa un uso giusto.
I miei piedini nelle espardrillas giocano ancora con il marmo del portico: non è un marmo regolare, il tempo o forse chissà dei pesi o semplicemente il continuo muoversi della sabbia e della terra in generale ha creato piccole conche, e quando vi arriva la pioggia si riempiono di piccole pozzanghere innocue e fastidiose a pestarle. È un marmo oggi vecchio, con le striature blu a separare piastrelle ocra, mattone, panna, crema, è un marmo nel quale i miei piedini giocano a cercare la giusta misura, come tante piccole scarpe di Cenerentola da provare.
L’entrata ha porte centrali: solo negli anni le porte automatiche laterali hanno assunto una connotazione definitiva; sembra che siano state da sempre così, ma no, hanno subito cambiamenti anche loro, quell'”entrate” e “uscita” così forzate per l’italiano che non è capace nemmeno di essere stabile in una coda alla cassa. Nell’estremo lo è, nelle piccolezze e nello scontato no, non ci riesce. Nella riqualificazione e ristrutturazione della Piazza poi è cambiato molto: lo stesso portico, oggi annerito, non era lo stesso marmo.
Perché siamo entrati? Non me lo ricordo più.
Ma posso arrivarci, deducendo (ecco a cosa serve studiare la matematica), aggiungendo conoscenza e probabilità, e sottraendo, fino al risultato finale con le due lineette dell’uguale.
A mio babbo piacciono le penne. All’epoca, la libreria era anche cartoleria. Ricordo scansie piene di oggetti colorati: gomme da cancellare, penne di diversi colori e forme, matite, righelli, temperini e tutto ciò che poteva rientrare nella categoria, utile o meno che fosse.
E come quando non condividi le passioni di qualcuno, ti ritrovi a girare e guardarti in giro.
Deve essere andata così. Deve essere andata che mio babbo si è fermato al reparto penne e io, comunque bambina – seppur ubbidiente e fabbricata sulla levetta dove mi metti sto e pure senza lamentele -, faccio un passo più in là.
Poi un altro.
Poi un altro ancora.
Poi, c’è un universo sconosciuto e da scoprire.
Crescere a pane e avventura a qualcosa è servito. Persino nelle coste colorate dei libri vi vedevo un mondo diverso, inesplorato per l’infante che ero, assetata di capire, conoscere, elevarmi.
L’ho sempre pensato: più cose si sanno, più possibilità c’è nel sopravvivere. Naturalmente vale come discorso soggettivo, nella mia testa, in un mondo che non coincide con quello reale, tra cemento e luoghi intellettuali, perché in una giungla sarei morta da un pezzo.
E poi trovo questo libricino.
Cosa mi ha colpito?, e perché? Perché lui, proprio lui piccinianamente, tra tutti?
Ho un vago sentore anche di quello.
Avevo capito cos’era l’Olocausto.
Non lo avevo studiato a scuola, ma da per me mi ero interessata all’argomento. Il diario di Anna Frank è dello stesso periodo, Se questo è un uomo uguale. Perché poi io negli anni del mio primo decennio di vita o superati di lì a poco (non avevo ancora il ciclo per cui parliamo davvero di anni dal 1983 al 1989) sapessi o mi interessassi agli ebrei è qualcosa da ricercare nelle mie giornate di catechismo, nelle quali, anche allora, facevo domande e chiedevo risposte senza purtroppo e, a tutt’oggi, riceverne mai.
Lo soppeso.
Ne sfioro le pagine.
Lo chiudo.
Lo riapro.
Immagino sempre, ma credo sia andata così, perché lo faccio ancora – ci sono gestualità che si vedono nei bambini e che si capisce al volo che le avranno anche da adulti, un’espressione, un modo di fare, se lo porteranno dietro per sempre, come il mio modo di scegliere un libro -.
Lo ripongo.
Quel pesantissimo chiedere, posso?, già allora pensavo a quando avrei potuto essere libera di poterlo fare da sola, senza limiti – poi quando si è adulti un bel destro sotto la cintola, dalla Vita, arriva sempre -, e mi avvicino al babbo con il libro in mano. Prendo coraggio, lo stringo e mi avvicino.
Non ricordo se si compra le penne – probabilmente sì -, e sbuffa. “Ma poi lo leggi!” dice alla cassa sventolando un pezzo etrusco da diecimila e uno da cinque con l’Antonello da Messina stampato sopra (il Messina reggerà fino allo smaltimento e recupero di tutte le banconote – le cinquemila con il Bellini entrano in vigore dal 1985 – e servono due anni “sabbatici” per portarle fuori dal commercio) con la sigaretta spenta già tra le labbra per accenderla appena fuori dalla libreria.
Mai fatto.
Fino a oggi.
I miei piedi oggi, sempre chiuse in comode espadrilas, passeggiando con mio padre passando proprio davanti alla stessa libreria: vetrata nuova, esposizione delle vetrine nuova.
Il portico ora, da nuovo anch’esso oggi è vecchio: lastroni bianchi di marmo consunti e sporchi, rigati, rovinata, con una bellezza decadente.
È come prendere in mano una musicassetta, far tornare avanti o indietro il nastro. Il VRRRRR del pulsante azionato, una didascalia nella testa e nell’aria di un suono vetusto. Ne ho ripresa in mano una, di musicassetta, qualche giorno fa: era una musicassetta bianca e rossa, targata RCA, di Luigi Tenco in una raccolta dei suoi singoli. Aveva il sapore di anni finiti, chiusi definitivamente. L’ho cantata a squarciagola, gustandomela e sorprendendomi della memoria che si può possedere. E penso in una gestualità che è stata la quotidianità per anni, quelli della mia giovinezza e semplicemente arrugginiti: i giovani impazzirebbero, impazzirebbero con le musicassette, non hanno tempo e nemmeno pazienza per aspettare che il nastro arrivi o torni al punto che vogliono, abituati come sono al tutto e subito.
Ed è come un nastro: qualcuno, o io stessa, che guarda quell’uomo e quella bambina/ragazza, trentacinque, quaranta anni dopo, passeggiare nello stesso punto, davanti alla stessa libreria, entrambi con i capelli bianchi dopo, in quell’ipotetico rewind, averli visti diversi in altezza e colore, il padre e la figlia un po’ ingobbiti, in quel rewind slanciati, giovani, vivi; oh certo, vivissimi e molto, molto vicini anche oggi, ed è questa la costante. La costante è lo stesso amore in una cosa così semplice come passeggiare insieme, stare insieme, in quello stesso tratto, in silenzio, pure.
VRRRRR, il nastro gira.
Un caffè scoppiettante nella moka, una giornata di fine estate, fresca, limpida nei panorami del monte di Gabicce sulla spiaggia di Rimini e il Monte San Vicino da Montemarciano, nelle Marche.
Lo schermo di un computer e ancora la sensazione sul fondoschiena di mio babbo che mi carica sulla canna della bicicletta tra le vie vecchie e nuove di Marina centro, ‘che perdo il treno e sono in ritardo, in questa immagine così retrò: da quanto non vi capita di vedere andare in giro qualcuno sulla canna di una bicicletta? Anche solo a scriverla sembra un’immagine in bianco e nero alla Don Camillo.
Sotto quel portico, in onde invisibili, risuona ancora quel “Ma poi lo leggi!” con l’accento romagnolo. È lontanissimo, nessuno può sentirlo, rimarrà un’eco nelle mie orecchie, e quando anche io non ci sarò più, sarà qualcosa tra le tantissime cose che sono state dette, pronunciate, pasciute nel vento e nell’aria, perse, mai sapute in memorie finite.
Ci volevo scrivere un fumetto su questo: un luogo, una moltitudine di persone che vi passano, una moltitudine di storie che si intrecciano e si sfiorano senza conoscersi mai; anche solo nel dire di dover andare al mercato perché manca la frutta, o il parlare di lavoro, o nel mentre di una telefonata, il darsi appuntamento, decidere il ristorante per la sera. Mi ha sempre affascinato il tempo, quello che scorre e che non torna più, quello che se stai facendo qualcosa, ci sono milioni di persone che nello stesso istante fanno altro: chi muore persino.
Mi uccide questa cosa. Mi toglie totalmente il respiro, quando si produce quel sibilo in gola, e l’aria non va e viene dai polmoni. Mi uccide. E mi affascina. A modo mio poi, è quello che ho sempre cercato di fare nei fumetti: racchiudere momenti, mettere STOP o in PAUSA, conservarli tra le pagine, immortali, dare loro la giusta dimensione e il giusto peso, nei ricordi poi, quelli che restano.
Ieri sera, prima di addormentarmi ho appena terminato un libro di Fabio Bartolomei, We are family, che mi ha lasciato un po’ così, amareggiata, rattristata, per la vita, per le scelte, le persone che amiamo e che come tutti, anche se ci sembra inaccettabile, se ne andranno. Il prossimo è proprio quello comprato in quella libreria, sotto quel portico.
Ci sono innumerevoli immagini, di me e di mio babbo, nella mia testa, della famiglia anche, nelle “Mele” c’è una pagina scritta a mano in cui racconto un momento di quelli, di quelli che mi porto nel cuore.
Io e mio babbo siamo ancora lì, sotto quel portico.
Una vita a cercare di “essere differenti”, a cercare di trovare una propria strada, a vivere il più intensamente possibile, tentando di costruire qualcosa, e poi, ci si scopre negli anni della maturità a essere delle miniature dei genitori, involontariamente, geneticamente. Si è fatto di tutto per non essere come loro e poi si torna a essere come loro.
Un cerchio, un cerchio perfetto in questa cosa che chiamiamo vita e che, spesso, ci prende in giro.
Ma, come sempre, mi affascina quel qualcosa che rimane, quella traccia biologica ed ereditaria che passa di generazione in generazione.
Il libro è un libro piccolo, la copertina è sbiadita e gli angoli consunti; le pagine sono cerchiate di un alone giallo e ci sono segni di ruggine, pare, sparsi, come macchie di un felino.
Lo inizio questa sera.
Ho riposto Bartolomei nella libreria e ho già messo il segnalibro nel romanzo, e lo stesso, sul comodino.
Prendo una musicassetta vergine, una da 60 della TDK: spingo il tasto REC. Registra.
Finalmente, quasi trent’anni dopo, è arrivato il momento di mantenere quella lontana promessa.