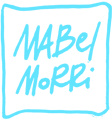“Alias Comics” è una rivista a fumetti in forma di quotidiano che, per tutta l’estate 2017, in allegato al quotidiano Il Manifesto, è uscito in edicola. per il Lucca C&G 2017 è uscito in versione raccolta, abbellita da perché e disegni preparatori editi e inediti.
Mi è stato chiesto come la mia “Fino a qui tutto bene” sia nata e cosa mi abbia ispirata per quel fumetto breve.
Eccoli, nella lunghezza originale rispetto a quella poi pubblicata per evidenti limiti di prolissi.
Una serie di cose.
Fu una serie di cose che vedevo e che vivevo, fisicamente e oniricamente, che influenzarono la stesura della storia di “Fino a qui tuto bene”.
Per esempio, iniziavo a essere economicamente indipendente, e decisi che volevo farmi il motorino.
Non un motorino qualsiasi: la Vespa.
Così, la mia bicicletta del liceo veniva sostituita da un mezzo meccanico, pur conservandola naturalmente, ma era una strana forma di addio. Sono fasi della vita, nelle quali anche oggetti fedelissimi e che ci hanno accompagnato nel corso degli anni, vengono bellamente lasciati in un angolo a impolverare senza neanche degnarli di un “grazie”, tranne quando ritornano a sorridere quando il suddetto oggetto meccanico si rompe, o peggio, è vittima di un incidente; e un po’ per paura e un po’ per decisione, quel tanto fortemente desiderato oggetto metallico viene a sua volta abbandonato, scheletro accartocciato in attesa di demolizione. E allora torna lei, la bicicletta del liceo.
Ritorno a vedere il mare pedalando, invece che percepirlo gestalticamente come una linea piatta all’esterno della mia visuale.
Ritorno a osservare le persone, invece che evitare di prenderle sotto (come con l’attuale Sindaco di Rimini, una volta).
Ritorno a sentire l’aria fresca, fredda, calda, lieve, invece che una continua sferzata gelida che non conosce intermittenza. E ritorno a riscaldarmi naturalmente invece che patire e basta.
Ritorno all’essenzialità, una borsa a tracolla o uno zainetto sulle spalle, invece del portapacchi e lo spazio tra i piedi.
Insomma, ritorno anche un po’ bambina, a spingermi oltre, a Viserba, a pedalare più lontano con le nuove piste ciclabili che il Sindaco ha deciso di voler far costruire, lui ciclista per primo e la città dietro di lui (quindi tutti ciclisti), tutti a fare la Coppa Cobram ogni giorno, a prescindere, dall’andare al lavoro, all’università, a far la spesa, alla “Befane” persino.
Capitò in un giorno di fine settembre.
Pedalai oltre, la stagione era finita, la spiaggia si era ritirata e volevo vedere un mare diverso, una spiaggia diversa.
A Viserba ci sono gli scogli. C’era anche un buon baretto dedicato a Matisse. Hanno ancora delle paste e dei dolci buonissimi.
Quel mare, quella spiaggia ritirata e quegli scogli aprono “Fino a qui tutto bene” nella prima vignetta.
La posa stessa.
Un’amica di Bologna nella casa a Rimini aveva deciso che una stanza sarebbe diventata una camera rossa. Le era partito l’embolo per la fotografia e aveva avuto la possibilità di sperimentarla con favorevole economia: il meglio dei prodotti, dagli accessori alla carta fotografica era in quella stanzetta che dava sulla strada chiusa in pieno centro.
Le prime fotografie le aveva stampate provando il bianco e nero.
Poi il seppia.
Poi il resto.
Naturalmente, chi ha sufficientemente esperienza per trovare soggetti fotografici privi di malizia nelle città di mare, sa che o si va al porto o al mercato, anche quello di pesce, se non ti sgamano a scattare.
La posa era di un vecchietto: anche se in bianco e nero si riconosceva il giubbotto di renna che nella memoria di ogni milanista degli anni ’90 sarà per sempre quello accompagnato a una camicia rosa nel giorno dell’addio al calcio di Marco van Basten, un pantalone sformato e una bici con la canna. Ma non guardava davanti a se, non guardava il mare: la foto lo aveva ripreso nel preciso istante di attenzione verso qualcosa alla sua sinistra.
Era una bella foto.
Credo di averla ancora per altro, conservata da qualche parte nel mio studio, in una delle scatoline che non ho mai più risistemato dopo il mio primo grande trasloco.
Quando aprì il Centro Commerciale “Le Befane” di cui sopra, per molti fu un sospiro di sollievo: riqualificazione di terreni dove prima c’erano solo campi perché la sensazione era quella che oltre la vecchia sede della Coca Cola c’era solo la Circonvallazione Nuova e quando si incrociava la Flaminia non c’era più niente, salvo trattenere il respiro e arrivare a Fiabilandia e, per non passare dal mare, a Riccione; e nuovi posti di lavoro.
Un ragazzo che stava con la mia migliore amica era quello che all’epoca si definiva nerd: sapeva tutto sulle ultime tecnologie e lo si chiamava anche per la configurazione del computer.
Era praticamente l’alba del portatile, i blog esistevano ma erano per persone che sicuramente non facevano parte della mia cerchia, così riminese da avere il vomito e interessata solo alla spiaggia e al nuovo locale dove fare aperitivo e io che disegnavo fumetti ero accettata perché tanto strana lo ero sempre stata, e che disegnassi fumetti era qualcosa di cui parlare giusto per variare da un gossip e l’altro.
Era l’alba di tutto quello che poi oggi è diventato quotidiano, persino il mio battere veloce di adesso sui tasti del Mac, proprio adesso, io che “Le Mele”, la mia autoproduzione di quegli anni, le avevo tutte scritte e battute a macchina con una Olivetti STUDIO 46.
Era l’alba dei social network: lui aveva una pagina su un qualcosa chiamato Flickr, il primissimo, che fungeva come un diario nel quale mettere foto e scrivere i propri pensieri.
Venivamo dalla carta, dai rapporti epistolari e dalle buste da lettera di Poochie e della Holy Hoby Vintage, all’avere una quasi certezza che quei pensieri sarebbero stati letti da una, massimo fratelli o sorelle, come un diario segreto, e non invece pubblicato alla mercé di chiunque.
Quando lui lasciò la mia migliore amica, quelle parole furono per tutti, e quando lei le scoprì, be’, non fu un gentiluomo lui e si poteva intravedere il marcio di quel nuovo modo di comunicare.
Per cui, quando trovò lavoro nello store dedito alla tecnologia pensai fosse proprio il lavoro per lui.
La responsabile, mi raccontò, era un’appassionata di cartoni animati giapponesi, e nel reparto DVD aveva fatto in modo di realizzare uno scomparto solo per i cartoni e i film d’animazione: con il dilagare di qualsiasi serie cofanetto, per chi era rimasto alle immagini della memoria fu una manna, e anche io mi trovai a comprarmi la collezione di Hurricane Polymar e Capitan Harlock.
Per me costantemente in ritardo sulla vita, tornare a riguardare Capitan Harlock era un modo per non abbandonare quasi mai definitivamente il mio essere bambina, mentre la vita bussava e imponeva una maschera. Nel mio piccolo, nel mio studio, non sono mai mancati i cartoni: quando poi sono stati sdoganati pure quelli, non ci si doveva più vergognare di guardarli ancora, concomitanti anche le mode, il vintage e il guardare agli anni ’80 come a qualcosa di poi non così male. O almeno nei quali sono accadute cose, come oggi si fa con i primi ’90 (vedi “da un’idea di Stefano Accorsi”).
C’era un film di Harlock, con la parola Arcadia nel titolo. pensai al significato simbolico di Arcadia, anche biblico.
Pensai che poteva racchiudere qualcosa, qualcosa di grosso, e di importante.
Cosa di più importante fuoco quei bellissimi e terribili 16 anni?
Concomitante a una serie di input che andavano a formare la storia del fumetto, il Ginnasio che avevo frequentato veniva spostato: non più a fianco del Liceo Musicale, ma apparato nella nuova sede del “Giulio Cesare”, un edificio completamente ristrutturato e grande per ospitare tutte le sezioni e le classi, ginnasio compreso.
Quando prendevo 4 in greco, ricordo che c’era della musica che usciva dalle finestre: riportava alla vita.
Quando mi dissero dello spostamento, pensai a cosa avrebbe tirato su i ragazzi appena usciti con un 4, ora che la nuova sede era vicino al mercato coperto e alle medie Panzini.
Poco per volta, Via Cairoli andava svuotandosi.
In quello che una volta era l’edificio che conteneva il cinema Capitol prima che si trasformasse in vari uffici, ci vidi “Pretty Woman”. Il cinema aveva l’ingresso sul davanti, la biglietteria appena entrati proprio di fronte e delle lunghe scale rosse sulla sinistra, e si poteva capire se il film era bello o brutto dalle espressioni di chi usciva dalla sala. Era il 1990, il muro di Berlino era caduto da meno di un anno e il PCI era allo sbando, Lilli Gruber era ancora inviata sul campo di RAIUNO e il Milan di Sacchi e Berlusconi, ma soprattutto per i romantici come me, di Baresi e van Basten, aveva demolito al Camp Nou di Barcellona lo Steaua Bucarest, i rumeni che in quegli anni erano ancora fortemente radicati alla matrice sovietica, come le squadre jugoslave che nelle coppe europee facevano sempre paura, mentre proprio in Jugoslavia iniziavano le prime avvisaglie della Guerra silenziosa.
Il cinema Santagostino stava anch’esso barcollando nelle poche presenze dei film d’essai: mi ricordo di una volta che andai da sola e ci spiegarono che ci ridavano i soldi perché non si era raggiunto il massimo degli spettatori per coprire le spese della proiezione. Nato come cinema della parrocchia, poco a poco divenne un cinema piccolo ma dalle visioni notevoli, di quelli di un tempo, quando i cinema erano in centro città e lo stesso viveva meglio. La cassa era praticamente un vecchio registratore e una scatolina di latta, e ogni volta, in quel andito, sembrava sempre di entrare nel retro di un palcoscenico, con le quinte stantie, in feltro rosso scuro e polveroso; il bar era di fatto un tavolino e, sopra, una merenda ben imbastita, qualche sacchetto di patatine, di quelli piccoli, e qualche lattina di cola e di aranciata. Sembrava triste, come cinema, in confronto ai Multisala che stavano nascendo, con sale enormi e poltroncine comode, e persino l’anello del porta-bibite davanti al bracciolo; sembrava “povero” eppure a disegnarlo, avrebbe avuto gli elementi perfetti per ricreare sulla carta i cinema di una volta, quelli da anni ’80, e, davvero, pensarci adesso, con gli effetti della malinconia che incalza, il sorriso è amaro, perché è stato un altro pezzo di storia della città che se ne è andato, e dimenticato.
Resisteva la libreria, una libreria strana che in vetrina aveva sempre Tex, non so perché.
Oggi ha chiuso pure quella.
Giusto “Gli Agostiniani” d’estate, il cinema all’aperto, restituiva un po’ dello splendore di un tempo.
La fine della via ora ha la parvenza del sentiero che non vale la pena percorrere. Dopo il teatro degli Atti, che è prima del vecchio ginnasio, e a meno che non si sia parcheggiato in quel verso, non la si percorre molto da quel lato.
Quando mi dissero dello spostamento, pensai alla musica, e pensai a quelle scale, al loro peso, le sensazioni poi che ho raccontato nel fumetto. Se davvero quei muri avessero potuto parlare, di quante storie e di quante vite avrebbero potuto dire, e di cui ridere, e di cui piangere.
Fu una serie di episodi, dai più assurdi ai più nostalgici che mi ispirarono per il fumetto.
E credo ce ne siano anche altri, ma il testo mi sembra già abbastanza lungo, quindi mi fermo.