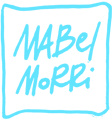Una giornata grigia e autunnale trascorsa seduta sull’ Ektorp all’IKEA a osservare la gente passare. Quello che ho visto:
“Buongiorno.”
“Buongiorno.”, rispondo con un lieve cenno del capo.
“Comodo, vero?”
“Uno dei migliori.”, dico ancora.
La signora ha i capelli cotonati. Mi sorprendo sempre quando vedo una signora con i capelli cotonati appena uscita dalla parrucchiera. Mi riporta alla memoria la lacca che si usava negli anni ‘80, la diceria che faceva aumentare il buco dell’ozono, le videocassette di aerobica di Jane Fonda, il taglio di Farrah Fawcett e il suo sorriso bianco smagliante.
Io ho sempre odiato andare dalla parrucchiera perché non capivo i miei capelli e non capivo il taglio più idoneo a valorizzarli. Pur avendone trovato uno, di taglio, è ancora così.
La signora sorride, testa la morbidezza del tessuto, sobbalza un momento provandone la resistenza, nella sua testa, immaginando nipotini volanti o generi sovrappeso lanciarsi su quel divano.
Mi guarda aspettandosi un assenso alla sua immaginazione. Lo riceve.
Mi saluta e se ne va.
Non ho idea se l’Ektorp l’abbia comprato, ma so che aveva il cordino per gli occhiali perlato, la gonna di stoffa leggera evidentemente confezionata da una sarta e le scarpe dal tacco rialzato.
E che forse avrà un Ektorp nel tinello.
Sono seduta all’IKEA di Ancona.
Questa IKEA è nata prima di quella di Rimini, tanti anni prima, a causa di ballottini taciti di imprenditori di potere che potevano decidere o meno le sorti di affari lontani a noi cittadini, per cui noi riminesi all’epoca dovevamo sempre scegliere se arrivare fino a Casalecchio di Reno nel bolognese o scendere nelle Marche: erano entrambe a metà strada, cambiava molto poco. Col tempo non fu mai un mistero che Valentini – che forniva i mobili alla Mercatone Uno e prima di IKEA massimo esponente di quel genere di mercato – aveva ostacolato l’avvento dell’azienda svedese nel riminese preoccupato per i suoi affari imponendo alle varie amministrazioni succedutesi di avallare IKEA solo se a fianco, dalla prospettiva dell’autostrada, ci fosse stata anche la Mercatone Uno.
Ancora oggi penso che quella di Rimini sia meno bella rispetto a Bologna e Ancona, ma è solo un pensiero senza importanza.
Adesso poi che la Mercatone Uno è fallita, il capannone rimane tristemente scuro da quella prospettiva autostradale così fortemente voluta, vicino a quello splendente dell’IKEA.
Sono seduta sull’Ektorp a due posti di tessuto color tortora.
Mi piace più quello a righe, in ogni caso è un modello per il quale è necessario possedere un gusto raffinato nell’abbinamento, qualità non sempre presenti.
E’ il 1998.
Sul marciapiede di via Savona a Milano noi studenti della Scuola del Fumetto fumiamo l’ennesima Diana prima di entrare per le lezioni. Abbiamo appena fatto colazione al bar di fronte, non c’è ancora il divieto di fumo nei locali per cui quella sigaretta all’aria aperta è un ulteriore vizio. Siamo giovani, abbiamo 23 anni e ci sembra di avere il mondo in mano, con la nostra rivoluzione fumettistica in atto, rivoluzione va aggiunto che perderemo clamorosamente. Ma è prerogativa dei giovani pensare al futuro e cianciare di sogni.
Uno di noi sta decidendo di andare a vivere con la ragazza.
E’ il 1998 e la moda ha deciso che funziona il genere militare quindi spuntano come funghi i pantaloni con le tasche laterali, il mimetico e i maglioni con le toppe sulle spalle; il pizzetto per gli uomini e i capelli lunghi raccolti in un codino sono un’alternativa al gel o ai primi crani rasati; le Spice Girls sono all’apice della carriera e io, nel febbraio dello stesso anno, assisto a una delle due serate evento al Filaforum, oggi Mediolanum Forum. Il compagno di corso è un classicissimo ragazzo milanese calato nella moda del suo tempo, pantaloni larghi, maglie a righe, montatura degli occhiali alla Woody Allen e pizzetto. Ma è anche un milanese che pensa che fuori dai confini esista poco o nulla e che tutto accada prima nella sua città, il che è anche vero, se Milano non facesse troppo l’occhiolino a New York. Fuma e mentre il fumo si condensa nell’aria del mattino e dello smog un po’ saccente dice: e che ci vuole? l’affitto è basso, la casa è un bilocale ma in due ci si sta bene, e poi si arreda da IKEA, oh, non costa niente.
Mi sentii piccola piccola. Io vedevo il mare ogni giorno e ogni giorno frequentavo ragazzi che facevano i viaggi per arrivarci, al mare, e per poco, una settimana al massimo, io invece in cinque minuti ero con i piedi a bagno, ma IKEA non sapevo cosa fosse. Me lo spiegarono e pensai a quando sarebbe mai arrivata a Rimini, se mai sarebbe arrivata. Da allora sarebbero trascorsi undici anni, perché IKEA Rimini aprì nel 2009.
Ti costruisci tutto, compri i pezzi e te li monti a casa, disse, illustrando a noi squattrinati disegnatori in fieri una verità che io scoprii lustri dopo.
Ma in quell’IKEA che proprio quell’anno si trasferì da Cinisello Balsamo a Carugate non la vidi mai.
“Grandi Magazzini” uscì nel 1986.
Era un film diretto da Castellano e Pipolo, coppia di sceneggiatori e registi che potevano esistere solamente nel secolo scorso anche solo per la durata della loro unione artistica durata oltre 40 anni; furono sceneggiatori per qualche film di Totò, di Ugo Tognazzi e di Adriano Celentano. Uno di loro, Pipolo, il cui vero cognome è Moccia, è il padre di quel Federico Moccia autore del best sellers “Tre metri sopra il cielo” che a sua volta, nella versione cinematografica, ha contribuito a lanciare la carriera di Riccardo Scamarcio.
Nella Rimini della mia infanzia e adolescenza c’era il sapore felliniano della bottega e del negozio a conduzione familiare, queste robe da grandi magazzini era contesto di ampi spazi, da grande città e Rimini è a tutt’oggi qualunque cosa tranne che una grande città. Per cui vedere sul grande schermo una realtà aziendale così americana nell’epoca della Guerra Fredda e di “Rocky 4” era un notevole cortocircuito, nel mio piccolo da riminese da frutta e verdura, da merceria, da libreria, esercizi commerciali ben distinti l’uno dall’altro un insieme di tale portata era tanto, troppo per chi era da sempre abituato alla drogheria sotto casa della nonna – Sergio, un mini market il cui proprietario guidava una Nissan Micra pre apertura dogana (il commercio delle auto giapponesi in Italia si aprì liberamente solo dopo la caduta del Muro di Berlino, prima era esclusiva di pochi), all’angolo della stradina che ospitava la sede dell’allora M.S.I., una porticina piccola, un corridoio buio e inospitale, in perfetta linea con le idee politiche di quel partito -.
“Grandi Magazzini” è un film a episodi, sono presenti alcuni dei più grandi caratteristi e attori del passaggio tra anni ‘70 e ‘80 (Nino Manfredi per la mia generazione era un attore vecchio, per dire) e per la prima volta vedo su uno schermo un personaggio gay e un mendicante fuori da un negozio.
Ricordiamoci sempre che è il 1986 e l’Italia è spaccata come lo è oggi, nonostante internet, Milano gode dei fasti dei decenni precedenti e la provincia è quella parte di mondo nella quale le mode e le novità arrivano sempre dopo.
Io “gay” non sapevo nemmeno cosa volesse dire. E i comunisti erano quelle persone che rendevano Ivan Drago una macchina che doveva vincere a ogni costo.
Benedetta innocenza.
L’episodio che trovai più divertente alla fine era quello con protagonista Heather Parisi che per me era solo l’antagonista di Lorella Cuccarini. Negli anni non sono mai riuscita a dire se mi piacesse di più “Vola” o “Cicale”, ci è voluto Twitter, trent’anni dopo, a rendermi simpatica questa americana che parlava un italiano masticato senza mai migliorarlo.
Il personaggio di Heather Parisi nel film è quello che secondo me racchiude la presa in giro della vita: porta occhiali con lenti a fondo di bottiglia, quelli per i quali venivamo prese in giro in modo micidiale noi quattrocchi, e si mette le lenti a contatto non ricordo per quale motivo perdendole all’improvviso. Per tutto il film diventa l’elemento di disturbo finanche di rottura tra uno sketch e l’altro, finendo poi per scambiare il letto della vetrina con quello di casa.
Prima di “Mallrats” di Kevin Smith e La Rinascente poi da piccola accompagnata dai miei genitori, “Grandi Magazzini” è stato il mio primo approccio su celluloide a una vendita variegata che non fosse quella esclusiva dell’edicola o della cartoleria nella vita vera.
Quando è arrivato l’Iper a Savignano, oggi Romagna Shopping Valley, all’alba dei 2000 e un quinquennio dopo Le Befane, l’idea di centro commerciale era ormai non solo chiara ma anche assimilata.
Lungo l’ipotetico percorso che passa tra i vari reparti reti di ceste, piene di irrinunciabili oggetti, spuntano negli angoli. Ne ho una anche qui sulla sinistra: cuscini. A pois qui, a disegni basquiattiani poco oltre, a tinta unita prima di passare ai mobili del salotto. Da uno di questi angoli, un bambino biondo sorridente è tenuto in braccio da una signora dall’abbigliamento giovanile ma evidentemente la nonna. Anche lei sorride, è totalmente rapita dal pupo col ciuccio che si guarda intorno curioso e incapace di capire a pieno cosa lo circonda.
Il nonno è subito dietro, sorride serafico, sereno, spensierato; cerca attenzione dal nipotino ma ciò che lascia è che sembra davvero felice, anche solo di un momento così, con le persone che ama di più al mondo tutte lì, vicino a un Ektorp.
La madre è una bella ragazza appassita dalla gravidanza che spinge il carrello.
La zia è evidentemente quella che porta un passeggino vuoto pieno di giubbotti e in coda a tutta la ciurma. Non viene degnata di uno sguardo, il bambino biondo è l’unico sole di quella parte di famiglia: indica qualcosa e tutti, come girasoli, seguono quel ditino innocente. Il bimbo riempie gli occhi e il cuore dei familiari.
Sembrano pezzi rotti, feriti e rimarginati con spesse venature oro come l’arte giapponese del restauro della ceramica, il kintsugi; perché sono belli insieme, traspare una linea immaginaria di uguaglianza, quei fili sottili che lega ogni famiglia di sangue, quelle che davvero rimarranno nel tempo di chi avrà cura di conservarne il ricordo. Pascoli diceva che i morti restano perché c’è qualcuno che li ricorda, ecco, quei nonni con le figlie sono simili, sono evidentemente una costola l’uno dell’altro e anche il bambino biondo a parte il biondo dei capelli ha tratti non lontani dai quattro. Come una setta che sceglie gli adepti, il piccolo è uno dei pochissimi che può permettersi di esserne accolto.
“Abbattute ma non sopraffatte” risponde il reverendo alla domanda di come gli siano sembrate le sorelle Lisbon dopo la drammatica morte della prima di loro, la tredicenne Cecilia, nel bellissimo e immortale libro “Le vergini suicide” di Jeffrey Eugenides, allo stesso modo, parafrasandolo, sembrano così i quattro: abbattuti, ma non sopraffatti e quel piccolotto biondo dona loro una sensazione di vitalità persa da anni.
Eppure è un giro all’IKEA, una cosa ordinaria: ma chi ha mai anche solo provato una volta istanti come questi, paralleli alla realtà, semplicemente banali ma felici, può capire che la vera felicità è nelle piccole cose, piccolissime a volte, virgole di una frase lunghissima e articolata che è la vita, fatta di punti e a capo, di punti e virgola, di spazi tra un paragrafo all’altro.
Questa famiglia ha appena iniziato a scrivere un nuovo paragrafo del loro capitolo, quello dei quaranta delle figlie, penso.
Arrivano insieme nel reparto ma senza una logica si disperdono come una goccia caduta in terra. Le sorelle guardano i cuscini parlottando, la nonna col bambino ripetutamente in braccio osserva alcuni tessuti, il nonno gira a curiosare anch’egli.
Poi, all’improvviso, come richiamati da un segnale misterioso ascoltato solo da loro se ne vanno raggruppandosi e commentando le rispettive esperienze mentre il bimbo biondo emette un ngh indicando qualcosa che nessuno segue.
Due ragazze, una bionda e una mora, si avvicinano.
La mora spinge un carrello prevalentemente vuoto con appena una confezione di sottopentola incelofanati.
La prima volta che vidi e che riconobbi due ragazze che stavano insieme era al Blockbuster. Sempre una mora e una bionda stavano scegliendo un film tra le corsie di quelle custodie di videocassette vuote. Dopo tanti anni, in un negozio e in una catena che si pensava eterna, retaggio di un commercio che di fatto era rimasto uguale a se stesso per decenni salvo qualche aggiustamento in corsa, in uno spazio che oggi è di gestione cinese, me le ricordo ancora, quelle due ragazze: una con indosso un giubbotto di pelle nero e l’altra un eskimo, entrambe in jeans, una con un modello largo, l’altra stretto, sorridenti, davanti una serata spensierata con un film non troppo impegnativo, si suppone.
Queste sono di generazione diversa, nei decenni la fisionomia delle donne è cambiata e loro fanno parte di questa nella quale la magrezza è uno standard genetico.
Non appaiono felici, c’è tensione ed è palpabile.
Qualche battuta tagliente a denti stretti mentre si soffermano su un modello poco dietro l’Ektorp su cui sono seduta.
Curioso come marche che negli anni della mia infanzia erano molto comuni sono tornate di moda, come la FILA che non vedevo da anni nei negozi e per qualche tempo era praticamente introvabile. Poi qualche anno fa il ritorno di tanti modelli anni ‘80 e ‘90, dal giubbotto jeans alle felpe larghe ai Mom, i jeans a vita alta che per me e molte di noi sono state un incubo e che fieramente oggi indossano le ragazzine.
La mora porta la felpa con la scritta plasticosa FILA su un paio di pantaloni casual, cammina comoda nelle sue Vans; la bionda indossa un paio di jeans su una felpa con il cappuccio, meno appariscente rispetto alla compagna.
E’ lei che si siede e commenta: “Questo è carino, dovrebbe starci. Misura un po’…”.
L’altra bofonchia qualcosa, cerca quello che io immagino il metro di carta nell’espositore sopra alle matite corte, ma non lo trova.
“Lascia stare, faccio io!” ringhia la bionda alzandosi di scatto e prendendo il suo, di metro, chiudendosi in un mondo parallelo tutto suo, composto di immagini visibili solo a lei, di scelte solo sue, di rabbia e frustrazione inespresse, escludendo completamente la mora che si isola a sua volta e si perde in un angolo indistinto del capannone.
Non assomigliano nemmeno lontanamente al ricordo delle due ragazze al Blockbuster, proprio per niente.
Sfilano via chiuse nei loro silenzi, gravide di rimorsi e rimpianti, non per la scelta del divano evidentemente, ma per qualcosa di più grave.
Penso a come IKEA possa anche rappresentare questo: non tanto un desiderio di vita in comune ma anche quello di due vite che si separano e che devono trovare una nuova strada singolarmente.
Ho fame.
Quando ancora abitavo a Rimini è capitato una volta che venissi a pranzo nel self service di IKEA.
Le polpettine svedesi sono una delle prelibatezze il cui fascino mi è rimasto nascosto per anni ma su cui, una volta venuta a conoscenza, non sono riuscita a spiegarmi il mistero sul perché fossero così squisite.
Un pranzo con un’amica fu l’occasione per assaggiarle. Sono una persona prevalentemente buona e non ho mai confessato che per me erano solo polpette, polpettine sicuramente luveriose, ma per non ledere le sue convinzioni me ne stetti zitta, inespressiva. È capitato poi di tornarci a pranzo, ma solo per comodità non avendo terminato gli acquisti della lista per l’ultimo trasloco.
Mi alzo dall’Ektorp e percorro il corridoio verso il reparto ristorante.
Le frecce luminose in terra mi indicano la via, penso a cosa mangerò e a cosa mi va di mangiare, a quale primo ci sarà nel self service. E poi mi va una birra.
L’ultima volta l’ho assaggiata, la birra. Non lo avevo mai fatto e quando è capitato è stato come con le polpettine.
Mi prende voglia di un primo. Mi piace la pasta a pranzo, non tutti i giorni, di fatto quasi mai, disabituata da una dieta iniziata diciannove mesi fa e appena finita rimasta così, senza nessuna voglia di riabituarmi a mangiare come prima.
Cammino piano senza fermarmi ma osservando il più possibile.
Supero l’arco pieno di pupazzi, peluche e giochi appesi.
Che bello il reparto bimbi, che bello.
Con M., la mia migliore amica, prima dei matrimoni e dei figli, quando ancora vestivamo con i pantaloni larghi e le sneakers come le Gazzelle o le Suede, andammo all’IKEA pensando di comprare qualche decorazione natalizia.
IKEA è quel genere di posti che si sa esistere ma nei quali quando si ritorna se non è per motivi tristi, fa un po’ festa. All’epoca non eravamo ancora proprietarie di auto e ci si muoveva in bicicletta o in motorino per cui la fiducia nell’usare l’auto dei genitori faceva tanto adulto. M. aveva appena cambiato casa, un bilocale carino e antisismico con un terrazzo grande vista Miramare monte, non esattamente la casa dei sogni ma l’inizio di quel viaggio che è il crescere che fa spesso molta paura e aveva espresso il desiderio di addobbare casa per il suo primo Natale lì.
Ne approfittava, disse, anche per vedere una serie di piccole cose, dalle tazze ai bicchieri, qualche utensile che durante il trasloco basta un niente per perderlo, qualche pacco di tovaglioli, insomma quelle cose che possono sempre servire.
Erano gli anni di passaggio tecnologico, pre smartphone, gli internet point erano ovunque, i cellulari non sempre facevano foto buone e ci si accompagnava spesso con le macchine digitali. Ricordo ancora quando la telecamera 7.2 della Sony era il futuro, l’oggetto desiderabile per immortalare i ricordi fotografati bene. E poi stava iniziando il percorso culturale della quantità, non più pensare alla foto perfetta da un singolo scatto, in fondo la pellicola costa e non si ha la possibilità di vedere cosa e come è la foto fino alla stampa, mentre con la macchina digitale ci si può fermare un attimo e controllarla prima di cancellarla.
Io sono nel pieno del carpe diem da Attimo fuggente per cui la macchina digitale me la porto sempre dietro.
Ce l’avevo anche quel giorno e quelli dopo, in altre occasioni.
Che bello il reparto bimbi.
Quando arrivammo alla cassa c’erano la miseria di una confezione di sei palle di Natale, un cuscino e due peluche a forma di carota. Quando uscì quello grande fu nostro. Il broccolo ci piaceva meno, ma per le carote impazzimmo. Per non parlare delle lampade a forma di fantasmino. Tutti acquisti per lo più futili ma che ci regalarono momenti che ancora ricordiamo e va da sé che, anni dopo, quasi dimentichi tra i tanti trascorsi insieme e citati, i fantasmini sono diventati i giochi dei figli.
Quel Natale alla fine M. si rimediò a comprare qualche sticker da attaccare ai vetri delle finestre e un alberello bianco, molto piccolo, che poi poggiò in un angolo a fianco del divano e della poltrona, dietro l’abat – jour, dai cinesi nella via di fronte.
La collezione nuova prevede uno squalo, ben più grande dei simpatici carotini e broccoli, ben più spaventoso dei disegni dei bambini diventati peluche (bellissima idea) e dopo aver proposto nel 2018 la matita che naturalmente desideravo. Subito dopo le ceste dei peluche mi si apre davanti lo spazio con le casette a tendone da circo: sopra il tappeto verde coloratissimo, il bambino biondo dondola impegnandosi su un alce giocattolo in legno che scoprirò chiamarsi Ekorre attorniato dai quattro che lo applaudono, lo aiutano, lo filmano, gli parlano amorevolmente mentre la zia si lascia andare in un: “Sembriamo quattro rincoglioniti.”
Ho deciso: mangerò dei tortellini panna e prosciutto, porcosi al punto giusto accompagnati da una birra dell’IKEA. Mentre faccio la fila col vassoio, mentre penso a come pagare – carta o contanti -, mentre impegno del tempo facendo finta di essere presente in quella coda penso all’atavica rivalità tra tortellini e cappelletti, che poi è fasulla in quanto la grandezza e il ripieno della pasta è a discrezione di chi la prepara e di fatto la presunta rivalità si riduce a una mera questione geografica: in Emilia si chiamano tortellini, in Romagna cappelletti, punto. Va da sé che per i bolognesi i tortellini al ragù sono una bestemmia e anche in Romagna il brodo è l’unico accompagnamento meritevole.
Un pensiero veloce mi attraversa riportandomi ad ulteriori ricordi da prime volte adolescenziali. Ma le pennette alla vodka?, che fine hanno fatto?
Sempre in coda, la nuvoletta sopra la mia testa collegata da tre puntini e dentro un ovale dal perimetro morbido, mi porta a immaginare quanto IKEA paghi la birra che andrò a bere solo per il fatto di avere il suo marchio blu e giallo sull’etichetta. Quale birra sarà? Sarà parte del gruppo Heineken? Sarà lo scarto di una della grandissima distribuzione? Sarà come la birra della Coop o della Conad prodotte rispettivamente da Pedavena e Castello? Sarà davvero svedese?
Quando me la stappano e la bevo tutte queste domande evaporano come il luppolo nel bicchiere.
Nello zaino porto sempre uno spazzolino da viaggio per cui, nella tappa toilette, mi lavo anche i denti.
Quando torno sull’Ektorp la prima coppia che osservo mi fa sorgere spontanea la domanda su come possano stare insieme: sembrano Kermit e Miss Piggy, totalmente incompatibili. Non è poi dovuto a pregi o difetti fisici, non significano nulla i capelli a spazzola e gli occhiali di lui completamente fuori moda e nemmeno l’abbigliamento improbabile di lei con colori a caso, dalla giacca di pelle alle sneakers sulle quali cadono malissimo i jeans elasticizzati, no, non è questo. E’ il loro modo di stare insieme, in quella bolla nella quale chiunque di noi, in coppia, produce: sembrano una nota stonata, una stecca su una musica non così bella.
Naturalmente è solo un’impressione, nella realtà è possibilissimo che invece siano perfetti l’uno per l’altra; capita che ci siano coppie che urlano per parlarsi o che abbiano modi sgradevoli ma che poi siano innamoratissimi ed è sicuramente il caso di questi due.
Lui ciondola nella mano la busta blu IKEA, quella che Balenciaga ha inconsciamente (?) copiato in una delle sue collezioni, visibilmente annoiato, lei curiosa qualunque dettaglio in preda a un acuto di ispirazione.
Passano famiglie, bambini che corrono sgridati dai genitori, altre coppie, altre famiglie.
I frammenti dei loro discorsi non sempre includono il luogo che stanno attraversando: un ragazzo per esempio aggiornava un amico sui risultati delle gare di ciclismo.
I pochi operai e commessi hanno volti scuri invece. Non ne passano tanti, qualcuno come un carpentiere trascinava un carrello di assi di legno.
Una volta all’ingresso dell’IKEA Rimini un lungo telo bianco copriva buona parte di metratura espositiva: sotto, in un gioco di ombre cinesi o di teatro sperimentale, operai e architetti si muovevano disponendo misure mentre un trapano rendeva difficoltosi i loro ordini.
E’ una giornata autunnale, grigia fuori e infrasettimanale. Non c’è molta gente anche se un picco interessante arriva verso le 18, 18 e 30.
Gente frettolosa, gente che calcola gli ingombri, gente che pensa tanto pronta a cambiare idea appena gira stanza.
Inizio a essere stanca, le giornate qui possono essere sfibranti.
Mi alzo dall’Ektorp e mi guardo intorno. Osservo l’ambiente che mi ha ospitato per qualche ora salutandolo affettuosamente.
Seguo le frecce e invece di girare per la toilette o per il ristorante scendo le scale in legno al piano terra attraversando il mercato, altro luogo allettante nel quale perdersi in acquisti apparentemente utilissimi, fino a intravedere le casse.
Il magazzino si apre all’improvviso dopo i colori caldi delle esposizioni, è l’unico tratto freddo nel quale la magia si spezza.
Un paio di signori dai capelli canuti sono seduti su due poltroncine di fronte ai pezzi che le compongono. Non c’è traccia delle rispettive mogli ma è evidente che le stanno aspettando, come fossero al bar.
Mi viene in mente di quella volta che salendo le scale d’ingresso incrociai un gruppo di freschi pensionati che erano scesi da un pulmino. Era una domenica mattina, la classica mattina diesel, calma e propositiva come solo la domenica riesce a essere. Le signore, una aggrappata al corrimano, una lenta soppesando ogni scalino, un’altra che le aspettava evidentemente più ginnica con altre tre qualche gradino più sopra, stilavano a promemoria il programma di quella mattina che includeva la pausa pranzo alle 12:30.
Mi sono immaginata i viaggi in pullman degli anziani, quelli organizzati dalla parrocchia, quelli dai circoli vari, considerandoli preziosi per quelle persone che hanno voglia di compagnia e inclusione diversa dopo decenni di lavoro.
Quando sto per passare sotto il cartello Uscita senza acquisti, la vedo: è la stessa signora che si era seduta sulll’Ektorp. Sorride tenendo in mano una Fejka, la piantina finta artificiale del catalogo IKEA.