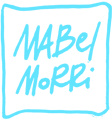Probabilmente in inverno sarò costretta a comprare un nuovo paio di scarpe Clarks, le mie adorate Desert Boot, perché quelle che calzo da qualche anno non mi sembrano tanto in forma.
C’è una foto.
L’odore di plastica è fortissimo appena si apre l’album orizzontale, di quelli di una volta nei quali si raccoglievano le fotografie appena stampate. Sopra, sulla copertina, ci si scriveva con il pennarello indelebile data e luogo. Di solito erano le gite, anche quelle di un giorno.
Con alcune amiche insegnanti parliamo delle gite, di quante ne fanno e di dove vanno; sarà che ho frequentato il liceo artistico dopo un anno di ginnasio ma quegli anni io li ricordo costellati di gite, musei, città, viaggi in pullman interminabili e corse per accaparrarsi i posti dietro all’andata e al ritorno, e, di conseguenza, foto scattate col flash nel buio di quei sedili laggiù.
C’è un’altra foto prima di tornare a quella iniziale.
Il primo scatto è in quel buio in fondo al pullman, nel secondo una luce lo illumina, quel buio, e ciò che immortala è il risultato di quella che io identifico e spiego come il disagio, quello inventato negli anni novanta, quello che ha caratterizzato la nostra generazione viziata e protetta. È il 22 ottobre 1992, dice la data segnata sulla copertina dell’album giallo primario; in un angolo, stampato, il logo dello studio e delle “stampe in 23 minuti” e un numero di telefono, senza prefisso. Il pennarello impugnato da una manina di un’adolescente di diciassette anni ha scritto anche “Verona”. La foto è verso la fine dell’album, il momento del ritorno. Ciò che viene stampato è un groviglio di corpi giovanissimi e ammassati nel fondo dei sedili del pullman: in primo piano la nuca di una chioma lunga di un compagno e Manuela colta nel dire qualcosa guardando l’obbiettivo; lo sguardo di Veronica, nei sedili successivi, è scettico, ma in fondo lo era anche lei, mentre Simona è nell’atto di girarsi ha un occhio chiuso e uno a mezz’asta; Marco, accanto a lei, urla ed è sdraiato a cavallo di due posti; Michele in un sorriso bonario e tonto spunta da dietro Marco. Secondo la prospettiva, negli ultimi cinque ambitissimi sedili ci sono Katia evidentemente allungata per entrare nella foto, Federica in un sorriso strozzato, Andrea che guarda e indica chi sta scattando la foto, Danilo che si stira e me. Io sono seria, guardo l’obbiettivo e sembro sorpresa. Zaini Invicta sparsi qua e là.
Oggi siamo mariti, padri, divorziati persino, mamme, zie, chi se ne è già andato e ci sono tante altre foto, ma questa in particolare ci ricorda che siamo stati anche noi adolescenti, ragazzini e ragazzine, soprattutto ragazzine, a cui batteva il cuore per un ragazzino che poi non è diventato il papà dei nostri figli. E da figlio, questa cosa qui, l’idea che siamo stati ragazzi anche noi e ci divertivamo pure non è assolutamente comprensibile.
In quella gita a Verona indosso pantaloni di velluto a coste fini (di gran moda all’epoca) e un bomber all’americana con le maniche di colore diverso, altro must di quei primi anni dell’ultimo decennio del millennio. Ma non ci importava, il 2000 ci sembrava lontanissimo nell’irruenza e nella turbolenza dei diciassette anni.
Ha un che di sorprendente il fatto che nessuno sia venuto mosso o la foto bruciata in uno scatto veloce: le foto stesse erano di posa, era proprio il metodo con cui si imparava a scattare e quelle in movimento erano d’altronde vezzi artististici. Immortalare un momento era quasi più una questione di azzeccare il tempo giusto, era più ragionato paradossalmente da risultare davvero un’arte.
Ai piedi, me lo ricordano le foto calzavo un paio di Clarks Desert Boot, brown.
Eccoci allora alla foto iniziale.
A Venezia sono già pronte le passerelle di assi in legno in attesa dell’acqua alta prevista di lì a poche settimane. Solo che è una giornata tersa, in quel 1991 e le strade sono asciutte.
La copertina dell’album è verde, questa volta, un verde pisello plastica, il solito logo e indirizzo, il solito numero di telefono senza prefisso.
Una donna di quarant’anni, quelli che ho io oggi, ci sembrava giovane rispetto ai matusa del resto dei docenti ma adulta, troppo nonostante ci sembrasse quella che poteva capirci meglio, ma era anche un’insegnante illuminata. Ci aveva già parlato di Francis Bacon e di Giorgio De Chirico, spiegandoceli pur non essendo compresi nel programma di quell’anno e infilandoli in un cross – over pazzesco di un filone storico che aveva un senso compiutissimo, quel genere di lezioni che facevano innamorare e sognare una carriera artistica da grande.
Su una di quelle passerelle, nell’attesa del traghetto che ci avrebbe riportato al parcheggio del pullman, siamo sedute io, Lidia, Jennifer e Nicola. Non so chi sta scattando. Di foto ce ne sono due però, ma è la prima che mi incuriosisce: io ho una mano alzata, come se stessi dicendo a chi ha la macchina fotografica di aspettare a scattare. Non so cosa sto guardando, ma sono presa da qualcosa, sono rapita da qualcosa. Sono tutti in posa, tranne me.
Ho il giubbotto lungo, quello invernale che poi avrei portato anche nella gita a Parigi nel 1994, la gita di quarta, quella che chiunque agognava.
Ai piedi, come poi anche in quel futuro 1994, calzavo un paio di Clarks Desert Boot, brown.
Le foto non vengono più sviluppate.
Vengono per lo più conservate nella memoria dello smartphone e, per chi vuole, le stampe digitali creano album cartacei da conservare in una libreria o su una mensola. Ma si è perduta l’abitudine di osservare un album di foto, a malapena si sfoglia un quotidiano.
Ricordo serate drammatiche nei salotti di qualche amico dei miei genitori che invitava gli amici e i figli a guardare le diapositive dei viaggi. Le diapositive le associavo sistematicamente alle lezioni di storia dell’arte, osservando foto di quadri bellissimi, per cui trovarmi l’amico dei miei genitori in canotta a fare finta di cadere nel Grand Canyon è qualcosa che cozza violentemente a confronto dei colori bellissimi degli espressionisti.
Le foto, anche quelle che osservo oggi segnate con un cuoricino tra i preferiti, le ho scattate a Venezia nel settembre del 2018.
Sono trascorsi ventisei anni da quella gita a Venezia.
Nel mezzo però c’è Treviso. E un’altra foto.
È il 2009.
A metà anni duemila indicativamente, Massimo Bragaggia insieme a giovani e validi alfieri decide di rilanciare il fumetto a Treviso. Treviso non è né più né meno differente da tantissime altre realtà italiane, priva di voglia di cambiamenti che sia una rotonda o un senso di marcia, abitudinaria, spesso ostile alle novità. C’è di peggio, in questo genere di città: alla popolazione basta quello che c’è, coltivano il loro orto e si fidano degli angoli amici. Anche Jesi, per dire, è così, oppure Bergamo ‘che a parte l’Atalanta si sente dire in giro che “non c’è mai niente qui, non fanno mai niente qui” guardando alle grandi città come poli nei quali c’è la vita e succede sempre tutto. La verità delle grandi città, soprattutto se non si fa altro che aprire la finestra e guardare l’esiguo panorama seppur splendido della provincia, è che non permette una lucidità di giudizio, la verità è che nelle grandi città c’è talmente tanta roba che si organizza che non ci si sta dietro, ma le persone preferiscono giudicare senza sapere e, soprattutto, senza averlo mai provato.
Per cui quando arriva Bragaggia che invece cerca di risollevare una fiera del fumetto uguale a tante altre in Italia e di fatto inutile, le porte da scardinare sono arrugginite e pesanti da aprire. Ma ce la fa. Nel 2008 il rinominato Treviso Comic Book Festival è un piccolo gioiellino che deve ancora crescere tanto, ma con una caratteristica che sarà pressoché costante negli ultimi 15 anni: la tranquillità con cui ci si gode il festival. Nel 2008 il TCBF mi candida al Premio Boscarato nella categoria “Miglior storia breve” con la mia “Ballardini Forever”. Prima di tornare a essere candidata, dovrò aspettare il 2017 nella categoria “Autore unico” con il mio “Il giorno più bello”. Non ho ancora ricevuto un Boscarato, ma nel 2009 uno di quei giovani alfieri, Alberto Polita, mi chiede alcune tavole per l’esposizione in una delle sale più belle della città, quella archeologica.
È fine settembre, è domenica e c’è il sole.
Io e M. decidiamo che la mattata si può fare, così la mattina presto, prestissimo, andiamo in stazione per partire e comprare i biglietti. Ma i biglietti non ci sono, il treno è pieno e siamo costrette a prendere la sua Lancia Y con l’elefantino mentre la mia adorata Vespa S, oggi defunta dopo l’incidente del 2011, viene parcheggiata nel piazzale adiacente le ferrovie.
L’ultima volta che io e M. abbiamo fatto un viaggio insieme in auto si è fuso il motore in autostrada della Nissan Micra del 1994 di cui ho raccontato le gesta nella storia “Poco oltre uno stop” ma con un finale meno tragico nella vita vera. Quel viaggio invece parte con una luce rossa che si accende nella plancia della Lancia Y con l’elefantino. Durerà fino a notte, fermandoci ogni mezz’ora per far raffreddare il motore. Non ho idea di come siamo riuscite a tornare, ricordo però che finimmo al Rose & ’N Crown di Rimini a bere birra e mangiare hot-dog.
Negli anni, io e M. abbiamo iniziato a scherzare su questa faccenda delle sfighe dei viaggi in auto insieme; negli anni, in un oggi dalle tempie imbiancate e dalle rughe più marcate intorno agli occhi, lontane dai volti freschi che ci ricordavamo essere i nostri e che allo specchio in alcune mattine non ci riconosciamo più, ne ridiamo ancora, ne rideremo sempre, fino a quando saranno ricordi così vecchi che presumibilmente con figli e nipoti grandi lo saremo anche noi, vecchie.
Ricordo il caldo che faceva a Treviso quella domenica. Io e M. non ci eravamo mai state lì, per cui la città era una continua scoperta. Era il 2009 e avere una macchinetta digitale con la telecamera a 7.2 era il lusso definitivo. Scattiamo foto a ogni angolo, a ogni cosa, a ogni scorcio, fino a un ponte. Senza un particolare motivo ci sporgiamo, osserviamo le nostre ombre sull’acqua lucente e trasparente e alziamo un braccio in segno di saluto verso noi stesse, verso quelle ombre laggiù. Non ricordo chi delle due aveva la macchinetta in mano che scattò le due foto, non una, ma due, simili nell’inquadratura tranne che una è zoomata e le nostre ombre e il nostro braccio sono più vicine. È caldissimo a un certo punto.
Finalmente riusciamo ad andare a vedere l’esposizione, io conosco Alberto e M. mi scatta l’ennesima foto: io sono magrissima e abbronzatissima, ho collane e bracciali che fanno tanto la me di quel periodo. Ai piedi, manco a dirlo, un paio di Clarks Desert Boot, brown.
Nel settembre del 2018 all’università Ca’ Foscari si svolge l’evento “Agile Business Day”.
A Venezia ci sono tornata prima dei ventisei anni di cui sopra; è semplicemente il ricordo più fresco in Veneto degli ultimi mesi.
Nelle sale adibite ai talk le persone si incrociano e si scambiano seguendo il programma variegato che passa di talk in talk. Io per prima vorrei vederne due, estremamente belli e interessanti ma sono in contemporanea.
Venezia ha momenti magici. A volte sembra statica e ogni tanto sui canali si respira quell’aria alla “Pane e tulipani” che pare possa accadere qualcosa di inaspettato e onirico.
Io e I., arrivate la sera prima, passeggiamo tra i turisti, c’è una cena evento al Casinò e io mi porto a casa una fish da 10 euro come ricordo.
E poi disegno, incamero momenti e li schizzo sulla moleskine. Al ritorno in studio ne viene fuori anche un fumetto di quattro pagine.
Venezia di metà settembre ha ancora lo strascico dell’estate e le temperature leggermente più vivibili, ma al sole ci si abbronza ancora e la sera urge il golfino di mista lana leggera e cotone.
È sempre domenica, è sempre caldo e io calzo ancora le immancabili Clarks Desert Boot, brown.
Poi capisco definitivamente una cosa e cioè che, seppur nella mia visione romantica dell’autunno nel mio immaginario le Clarks siano le scarpe migliori, scopro che no, non lo sono, perché fa ancora caldo e quasi che si cammina ancora scalzi come in spiaggia.
Non so più quante Clarks io abbia comprato e a cui ho dato il cambio, ma sono state tante e che forse, dopo l’ennesimo viaggio, probabilmente un nuovo paio di Clarks arriverà nella mia scarpiera, perché per quanto mi sforzi e la schiena abbia bisogno di una certa tipologia di scarpa con cui camminare, sono sempre loro che volente o nolente ci sono sempre state.