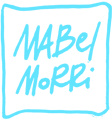La finale tutta italiana dell’allora Coppa UEFA tra Inter e Lazio della stagione 1997 – ’98, mentre un’altra finale – ma di Coppa dei Campioni – si attendeva speranzosi, quella tra Juventus e Real Madrid, triste precedente ancora attuale.
Il cielo sopra Parigi, quella sera del 6 maggio 1998, si colorò di nerazzurro.
Vent’anni dopo, a riguardare quella finale, sembra impossibile che ci sia stata un’epoca nella quale tre squadre italiane si giocavano la vittoria di due coppe europee.
Ivan Zamorano uscendo dal campo, sostituito per ricevere l’ovazione del pubblico nerazzurro per la prima rete segnata quella sera – quella che, di fatto, ha dato il là alla vittoria dell’Inter -, abbraccia e viene abbracciato da Ronaldo e successivamente incrocia Diego Simeone, il Cholo, che lo bacia sulla guancia. Applaude agli spettatori e se ne esce sorridente.
Ripeto: Ivan Zamorano abbraccia e viene abbracciato Ronaldo, il Fenomeno, e incrocia il Cholo che lo bacia sulla guancia, che è in totale contrapposizione dello sguardo di Dybala mentre stringe la mano a Cristiano Ronaldo nella finale di Champions a Cardiff, uno sguardo di un pivello di fronte a un Dio.
Una volta, gli dei erano nel campionato italiano; una volta vedere Ronaldo, van Basten, Maradona e tutti gli altri – e tanti, tantissimi, ne sono passati da questi campi -, era prerogativa italiana. Certo, anche qualche bidone e qualche giocatore esotico, alla Alexis Lalas – americano rosso di capelli molto stile country svestita la maglia del Padova – per intenderci. Ma gli dei erano qui.
Il logo della Coppa UEFA di quell’anno è un nemmeno troppo velato omaggio alle danzantrici di Matisse, solo che invece di essere arancioni su sfondo blu, sono verdi su un bollino giallo scuro, e sono tre. Campeggia sulla manica sinistra delle maglie di quella stagione. Già allora il calcio era merchandising, e l’Inter apriva sì le danze giocando la finale con quella maglia a righe orizzontale in toni di grigio e i numeri e i nomi dei giocatori gialli su pantaloncini e calzettoni, quelli sì, originali neri. Gli scarpini anch’essi neri, in evoluzione naturalmente ma ancora ftutti tendenzialmente neri, tanto che le Valsport bianche di Marco Simone furono, nella finale di Coppa Campioni del 1995 Milan – Ajax, talmente strane che vennero riprese e fotografate con sghignazzi e alzate di sopracciglia dagli astanti – ma molti tifosi se ne innamorarono -. Che poi Weah fece lo stesso con la Diadora che gli confezionò gli scarpini rossi con cui giocò la stessa stagione. La Nike allora, mentre molti tentavano la strada del colore (Diadora nel Mondiale del 1994 per Baggio e Signori fece i modelli in blu nazionale), si proclamò fedele al nero salvo poi ripensarci nel 1998 con la R9, la Mercurial che segnò una svolta radicale nell’industria delle scarpe da calcio. Viene da sorridere a pensare ai ragazzini, ai dodicenni e tredicenni di oggi, che vedono CR7 e la sua linea e credono sia farina del suo sacco, o credono che i calzettoni sopra al ginocchio li abbia inventati Neymar quando il primo a portarli così fu Thierry Henry già all’Arsenal dopo la Juventus.
È con altri scarpini comunque che Ronaldo, l’unico vero Fenomeno, scattò sulla linea del fuorigioco e in contropiede si ritrovò da solo davanti a Luca Marchegiani e lo dribblò come un birillo, infilando il definitivo 3 – 0.
Senza contare che l’Inter vinse quella coppa con Taribo West in campo, certo, prima coppa dell’era Moratti figlio, ma sempre e comunque con West e le sue treccine colorate, il che assume connotazioni leggendarie. Venne anche espulso, in quella finale, perché rifilò da terra, dopo essere caduto dopo un contrasto aereo, a Casiraghi che cadde con lui: cioè, sul 3 – 0, praticamente oltre il ’70, Taribo West salta con Casiraghi, cadono insieme e da terra gli da una gomitata. Lo devo scrivere due volte perché West era uno di quei calciatori che quando faceva queste pazzie qui – e, intendiamoci, non era il primo e nemmeno l’ultimo della lista infinita di teste calde che hanno calcato gli stadi più famosi -, ci si domandava perché giocasse a pallone. Poi venne anche espulso Almeyda, ma stava perdendo, era nervoso, diciamo che nei limiti aveva più diritto lui a perdere la testa che non Taribo West che quella coppa poi l’alzò.
Si giocava a Parigi, al Parco dei Principi, ed era l’Inter di Gigi Simoni – un ex centrocampista generoso, un gregario, cuore e polmoni come quelli di una volta, che passava dalla Serie A alla B, in ordine sparso dal Mantova alla Juventus con passaggio al Torino, al Genoa e nel mentre al Brescia in B e sicuramente ricordato maggiormente per la carriera da allenatore -; un Inter che aveva tra le sue file alcuni dei talenti più gustosi di quei fine anni ’90 – non solo Ronaldo, Simeone e Zamorano -, tra tutti Recoba, genio e sregolatezza che Moratti coccolò come un figlio fino al prestito soffertissimo al Venezia. Ma c’erano già Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Aaron Winter, un portiere affidabile come Gianluca Pagliuca (di quella Sampdoria smantellata dopo il dopo Mantovani, presidente del momento più alto della storia blucerchiati culminata con lo scudetto del 1990 – ’91 e la finale di Coppa Campioni persa contro il Barcellona, con Vialli, Lombardi e Vierchowod alla Juventus e Mancini tra Lazio e Parma), Kanu, Maurizio Ganz, Fabio Galante, Francesco Colonnese, Francesco Moriero (che in quegli anni di Inter credo giocò le migliori partite della sua carriera zampettante sulla fascia destra, almeno in quella prima stagione che culminò con la Coppa UEFA), Marco Branca e poi i “vecchi” Giuseppe Bergomi (che la coppa l’alzò insieme a Pagliuca) e Nicola Berti che mi immagino dispensare in totale contrapposizione del baffo Bergomi consigli ai giovani su come godersi Milano by night.
Ma quella notte, il 6 maggio 1998, il cielo sopra Parigi si colorò di nerazzurro e anche Nicola Berti forse pensò un po’ meno al divertimento e più a festeggiare quel momento.
La finale fu uno di quei curiosi eventi nei quali gli sponsor tecnici erano gli stessi: l’inglese Umbro – che oggi fa storcere il naso abituati al monopolio del duo Adidas – Nike – era nata nel 1920 in Inghilterra ma solo nel 1985 iniziò a commercializzare anche le scarpe da calcio uscendo dai confini nazionali e dei molteplici ricordi che si possono avere della nazionale inglese di quegli anni (su tutti il Mondiale italiano del 1990) non penso di riuscire a immaginare una maglia diversa se non con quei due rombi uno dentro l’altro del logo sulla destra. Era la moda sportiva delle tute e delle felpe enormi e coloratissime e anche il calcio non ne era esente. Ci aveva provato sempre la Nike, nel Mondiale americano del 1994, con il portiere messicano Jorge Campos talmente iconico e decisamente colorato che fu il primo e unico giocatore messicano a finire in uno degli spot pubblicitari Nike dell’epoca, allora sinonimo di popolarità universale. La moda rimaneva tale e la Umbro non faceva eccezioni: la divisa di Pagliuca in quella finale di Parigi è forse uno dei rari casi di sobrietà del periodo, in verde Nike che oggi vestono e hanno vestito generazioni di calciatori, mentre Marchegiani aveva quella bella divisa blu e gialla con logo e simbolo nel centro così ninetees. Mi immagino a indossarla oggi: mero oggetto vintage bramato da tanti, da me sicuramente, seguendo quella contaminazione che finisce davvero sulle riviste di stile (molto interessante il lavoro di un disegnatore grafico che ha realizzato una serie di illustrazioni copiando ciò che vedeva in metro a Londra e indagando su come è cambiato il ruolo delle maglie da calcio usato nel contesto urbano, lontano dai campi da gioco, ma utilizzato capo di abbigliamento).
Oggi la Umbro dopo essere stata comprata dalla Nike è un’azienda satellite facente parte di un altro gruppo di finanziatori e investitori, ma ha totalmente perso il suo appeal, specie quello dei calzoncini, i cosiddetti Umbros, coloratissimi e in quell’acetato a metà tra elasticizzato e il largo che fecero davvero moda alla fine degli ’80.
Non fu così in quella finale. La Umbro appariva ovunque e quelle maglie, anche quelle della Lazio del famoso sponsor Cirio, furono vendutissime.
Era un calcio stellare quello, almeno nei ricordi, un calcio che si dava per scontato: era normale vedere arrivare in finale due squadre italiane, era normale che l’Italia vincesse tutto, ovunque. C’era anche la Juventus, che di lì a qualche giorno avrebbe perso l’ennesima Coppa Campioni contro il Real Madrid, una Juve a modo suo bella, ancora oggi guardata con sospetto, ma semplicemente la Juve, la Juve di Del Piero, Davids e Zidane, la Juve della Kappa prima dei milioni della Nike e adesso dell’Adidas, una Juve con Peruzzi in porta e Ferrara in difesa, quella Juve. A Mondiale ed Europei eravamo sempre lì a chiederci perché non si vincesse anche quelli. Ma la legge Bosman era nata da poco, e l’effetto era un po’ quello del conto in banca pieno e illimitato per cui ci si può permettere qualunque cosa. Avete mai provato a fare shopping sfrenato, anche senza il senso di colpa laterale e obliquo che si insinua una volta tornate a casa? Io sì, e credo di sapere come si sentisse Moratti. Certo, poi ha dovuto lasciare, ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.
La storia che racconto io invece è quella di maglie colorate e larghe, è quella del primo Berlusconi in politica, delle Spice Girls e della loro secondo album Spice up your life che si preparava al tour estivo già sold out (indimenticabile il primo concerto a Istanbul vestite in oro), dei primi Placebo ascoltati su una musicassetta in una Uno sgangherata nella campagna piemontese, dei libri di Enrico Brizzi, di Nick Hornby e di Daniel Pennac (erano gli autori che i riminesotti intellettuali, e io con loro, leggevamo al tempo, in treno tornando dall’università, in spiaggia tra una passeggiata e l’altra, a casa in veranda o sul balcone abitabile), del primo Julia della Bonelli in edicola, di un essere ventitreenni con tutto ciò che comporta, il vivere pensando più o meno al futuro, ma vivere, il meglio possibile per ciò che ci si poteva permettere, e intorno, intorno un contesto politico, sociale ed economico che era così la quotidianità che mai, un giorno, avremmo pensato di rimpiangerlo, o almeno a ricordarlo con così tanta nostalgia.
La storia che racconto io è quella della prima Inter morattiana, di un’Italia degli imprenditori italiani e delle loro aziende, di un’Italia ancora così nazionalista (impensabile all’epoca un presidente e una società straniera, a meno che non si trattasse di gas e robe economiche di geopolitica che da giovani non interessano mai), di un’Italia completamente diversa, già sull’orlo del baratro e che di lì a pochi anni sarebbe completamente cambiata. Non lo strapotere del calcio italico, quello no, quello sarebbe crollato poco più in là, all’alba del 2006, nel 2007 con l’ultima finale tutta italiana in Champions, e il triplete di un Inter quasi completamente straniera nei giocatori in campo nel 2010. Sarebbe durato ancora un decennio più o meno, scricchiolanti, come una crepa in casa a cui non dai attenzione e ci si ritrova a riparare l’intero condominio, perdendo pezzi qua e là, ma con quella incosciente speranza che il calcio italiano non era poi così male. Poi è crollato tutto. Nemmeno il tempo di ragionare su quella crepa.
La storia che volevo raccontare io è quella di una partita giocata bene da entrambe le squadre a mio avviso, anche se è stata definita “senza storia” per il dominio nerazzurro, con la Lazio che riemergeva a sprazzi e un’Inter che piuttosto conteneva benissimo, apparentemente senza troppo sforzo, controllandola, e poi colpendo e sbagliando il meno possibile, a parte i due pali (Ronaldo con un bolide stampato sulla traversa nel primo tempo e Zamorano nel secondo che di fronte a Marrchegiani la piazza ma prende il palo con il pallone che si incurva in una traiettoria malefica nell’ultimo metro e poi viaggia sulla linea della porta per uscire al lato opposto), una partita piacevole, anni luce lontana dai ritmi veloci di un Clasico moderno, ma vera, con ancora qualche rimasuglio del bel calcio di una volta, culminato con Ronaldo, il suo scatto, il dribbling su Marchegiani, e Pagliuca e Bergomi ad alzare la Coppa insieme.
La storia che volevo raccontare io era quella di ragazzi che vedevano sulla Rai in prima serata quella finale, e che poi sarebbero scesi in piazza (alla rotonda del Grand Hotel per i riminesi) a festeggiare, ad andare a comprare se non lo si era già fatto la maglia di Ronaldo, o quella di Recoba, a indossare e sventolare sciarpe e bandiere nerazzurre, a godersi il giocatore più forte del mondo.
Quella che volevo raccontare io era anche quella di una quarantenne che mentre disegna ritrova questa partita su Sky Calcio e se la riguarda, come allora, gustandosela, vent’anni di più sul volto e sulla schiena, a ricordarsi di lei applaudire ma non gioire, di quarantenni che si ritrovano su Sky Calcio a riguardare qualcosa che difficilmente tornerà dopo anni di dominio televisivo di Stato, e se ritornerà non sarà certo così e con quelle sensazioni.
Quella che volevo raccontare io era una storia che è passata, che abbiamo vissuto, ma era talmente bello e fuggevole che non ci siamo resi conto subito della sua grandiosità, se non in una replica su Sky.