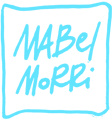Ho avuto sedici anni nel 1991. In quell’anno iniziava la Guerra del Golfo, c’era l’ultimo congresso del PCI a Rimini, Riccardo Cocciante vinceva Sanremo con “Se stiamo insieme” (ci sarà un perché, ancora oggi tormentone) e Sabrina Salerno e Jo Squillo risvegliavano l’imbolsito pubblico dell’Ariston con “Siamo donne”, moriva Freddy Mercury. E i libri? Si andava di classici, perché la narrativa per ragazzi erano ancora i romanzi di Jack London e Mark Twain. E se avessi oggi, nel 2015, sedici anni?
Non voglio nemmeno nemmeno immaginare che tipo di sedicenne potrei essere oggi, nel 2015.
E se non mi piacesse leggere?
Se non mi piacesse il calcio?
Sono cresciuta con le influenze di ciò che era la moda e la società dell’epoca, molto di ciò che sono diventata è dovuto ai fumetti, al cinema, alla poesia, alla musica, alle arti, soprattutto alla televisione, insomma alla cultura di quegli anni. Non so se sarei stata migliore o peggiore, certo è che poi si fiorisce, quasi sempre. Ci sono incontri, ci sono possibilità, ci sono curiosità da investigare e si segue quelle.
Il secondo volume del mio fumetto Volevamo essere le Spice Girls è ambientato nel decennio dei ’90. Sto aprendo un vaso di Pandora deflagrante, sto riprendendo in mano gli album di foto e mi riscopro, la donna che sono diventata in quel volto a volte spigoloso a volte paffuto, e come lo sguardo di oggi, ombroso, stanco, con qualche diottria in meno, riconosca i segnali di ciò che per anni non ha visto: era già tutto lì, apparecchiato, la direzione che la mia vita e ciò che avrei accettato di essere avrebbe preso.
Avere sedici anni non è mai facile in nessuna epoca e decennio, azzarderei persino in nessun secolo.
Nel 2015, prima stesura di questo articolo, la narrativa per ragazzi era profondamente cambiata, diventando una categoria commerciale proficua e in costante crescita in un momento di crisi perenne per l’editoria. Nelle librerie fioccano settori dedicati e festival prima importanti oggi sono ambitissimi e sotto la luce dei riflettori. Molte case editrici si sono inventate la loro sezione per i giovani e i giovanissimi, e molti autori ci si sono tuffati a capofitto, cavalcando l’onda, a volte con ottimi risultati, altre con lavori da sangue agli occhi.
Se guardo la mia libreria poi è piena di romanzi di formazione che vanno da Il giovane Holden di Salinger a Due di due di Andrea De Carlo, prima della moda Hornby e del ciclo di contemporanei da Enrico Brizzi a Silvia Ballestra avevamo Daniel Pennac, e i suoi Malaussene deliziavano noi giovani con avventure surreali. Tondelli era il nome da intellettuali che ovviamente ancora non si chiamavano così e soprattutto di sinistra, coloro dalle cui labbra uscivano solo titoli di fumetti, libri e film a me sconosciuti e io ricordo che provavo un’ammirazione spropositata per quei ragazzi che avevano letto e visto volumi e pellicole a me se non proibiti, quantomeno di difficile reperibilità.
C’è un altro aspetto spesso dimenticato o a cui non si fa caso: la fonte da cui si attinge ciò che nei primi ’20 del nuovo millennio diventa moda e cultura, cioè internet. Che è sterminata.
La mia generazione aveva solo la televisione, tutto passava da lì, al massimo dalla radio o appunto dalla carta stampata, ma la televisione era l’unico canale dal quale partivano i tormentoni. Per dire, le battute della Gialappa’s a Mai dire Gol o di Guzzanti ad Avanzi che noi adolescenti ripetevamo sugli autobus la mattina presto andando a scuola, nei bagni quando si fumavano le prime sigarette o persino, ancora, a ricreazione, erano frutto di quell’unico canale che come un megafono decideva e modificava il nostro gergo. Ancora oggi riecheggia quel “Chi ha ucciso Laura Palmer?” che proprio in quell’inizio dell’ultimo decennio del novecento tormentava mezzo mondo. Per cui, non mi sorprende più che la nostra genetica sia basata sulle battute di trasmissioni televisive oggi ataviche e che perfetti sconosciuti come qualche youtuber oggi sia famosissimo dai giovanissimi pur non essendo mai passato da uno studio televisivo.
Oggi è tutto più frammentato e ci sono fonti diverse, non solo internet ma anche piattaforme a pagamento che, nei miei sedici anni, erano pura fantascienza. Due, ne avevamo noi, appena due canali a noi più o meno dedicati: Italia 1 e Rai Due, la rete giovane dell’ammiraglia RAI.
Nelle serie televisive noi sedicenni degli anni ’90 ci riscoprivano attaccatissimi ai nostri modelli nella morte di Luke Perry nel 2019, il nostro amatissimo Dylan di Beverly Hills 90210, un telefilm oggi fuori da ogni logica di comprensione eppure, contestualizzandolo, assolutamente calato nella visione di società che vivevamo. La sua dipartita a 52 anni ci ha ricordato non solo la nostra età, oggi mariti e mogli, persino genitori, io mi fermo a essere una zia, ma quanto la nostalgia di quegli anni fosse forte. L’alter ego italiano I ragazzi del muretto era un altro telefilm difficilmente digeribile, a guardarlo oggi, ma accidenti!, era così attuale con temi così nostri (dall’eroina agli zingari, dal primo ragazzo di colore in classe alle offese razziste che ci si dimentica che ci sono sempre state, dalle truffe ai pericoli vari, dalla prostituzione delle ragazze dell’est alla vita circense più o meno lecita). Non ci sorprendeva per altro che sia Dylan sia Johnny fossero recitati da attori trentenni, con accenni di rughe che noi sedicenni non conoscevamo sui nostri volti tondeggianti e rosei.
SKAM Norvegia sarebbe arrivato proprio nell’autunno del 2015, che io intravidi perché in famiglia lo si stava guardando ma non certo con lo slancio affascinante che avrebbero avuto gli altri remake europei.
Fino ad allora la serie più travolgente sui sedicenni era l’inglese Skins che però era troppo oltre, troppo lontana dalle nostre città, dalle nostre culture, dalla nostra quotidianità. E in ogni caso non riusciva al cento per cento a racchiudere del tutto l’universo adolescenziale. Non come SKAM almeno.
Che poi questa frase mi scappò fuori a una cena con le amiche. Non ricordo proprio di cosa stessimo parlando, forse davvero dei sedici anni, e con “sedici anni” intendevamo tutto quel lasso di tempo in cui ci sentivamo inadatte e sbagliate e che arrotondammo a quell’età lì, ai “sedici anni”, ma potevano essere benissimo anche i diciassette e i diciotto.
A un certo punto dissi: “Io non ho mai avuto sedici anni”. Poi spiegai che sì, anagraficamente li ho attraversati, ma non mi sono mai sentita una sedicenne. Voglio dire, a tredici anni leggevo Leopardi e mi interrogavo sul perché della vita, giocavo a pallone, e disegnavo quando non dovevo studiare, vita sociale pochissima, di riflesso da mia sorella o i figli degli amici dei miei, quindi una disadattata. Figurarsi a sedici cosa potevo essere. Che poi sarà che con il tempo si diventa indulgenti o ci si rincretinisce, ma se ripenso ad allora, a parte la morte del nonno, i miei primi anni tra ginnasio e poi liceo artistico non sono stati poi così brutti. Insomma, diciamo che, a differenza delle amiche, avevo la camera tappezzata di poster del Milan e quegli anni lì, degli Invincibili, me li sono goduti: saltavo scuola che era un piacere, dietro al Milan che giocava in giro per l’Europa e io con i tifosi rossoneri, come l’anno della maturità che ti facevano terrorismo psicologico sul non fare puffi e io, fregandomene bellamente, me ne scappai quattro giorni ad Atene a guardarmi la finale di Coppa Campioni, quella finale, Milan – Barcellona 4 – 0, quella.
Oggi, sarà il fumetto di cui sopra che sto disegnando, ma mi domando che tipo di sedicenne sarei, e ho un po’ di nostalgia a pensare il tempo che ho perso, o meglio, che ho impiegato a scoprirmi e ad accettarmi; se lo avessi fatto allora, quando avevo sedici anni, sarei diventata la donna che oggi sono?
Ovviamente non potrò mai rispondere a queste domande, per cui mi tuffo in quei libri che se oggi avessi avuto sedici anni mi avrebbero aiutato o anche solo fatta sentire meno sola nel turbinio delle emozioni che si provano a quell’età.
“Mi piaci così” di Francesco Gungui. Edizione Oscar Mondadori, 2008.
Molto, molto, molto piacevole.
Leggero, fresco e ironico, racconta di Alice e, semplicemente, dei suoi 16 anni, racconta della vacanza forzata in Puglia in campeggio con i genitori e con il fratello tredicenne, vacanza costretta e causata dalla freschissima bocciatura al liceo invece di spassarsela con le amiche da sola in Sardegna.
Ve li ricordate i vostri sedici anni? O almeno alcune cose. Vi ricordate di quando avevate il coprifuoco con i genitori? Vi ricordate le prime cotte e il dramma di quello che significava? E vi ricordate come una bocciatura fosse l’unica preoccupazione che si potesse avere a quell’età, oltre alla prima accettazione sociale, ai brufoli e alle Mandarina Duck o gli Invicta che già sembravano da alternativi?
Per me la lettura di questo romanzo è stata una ventata d’aria fresca. Non ho più sedici anni da un pezzo e quasi faccio fatica a ricordarmeli interamente purtroppo, ma questo bel libro di 300 passa pagine fa ricatapultare immediatamente in quella realtà.
Se avessi oggi sedici anni, sarebbe il libro che vorrei leggere per capire chi sono e cosa voglio. Perché in fondo è anche questo che ti domandi a quell’età.
Alice è la classica ragazzina che pensa di non essere nessuno, si sente sfigata, con le tette piccole e il culo grosso e che poi invece scopre di essere quella di cui tutti si ricordano, che poi è un po’ come ci siamo sentite tutte. Gli stereotipi ci sono tutti, dalla dea dalle ancelle dietro cioè la figa della scuola che diventa naturalmente una sua amica (con sorpresissima finale che spiazza) al migliore amico che è un ex ma che non è ben chiaro fino a che punto sia tale. E poi i problemi con i genitori, il fratello tredicenne, i nonni, i limoncelli con la mamma al bar del campeggio.
A me sembra un’altra vita eppure le sensazioni sono le stesse.
Così mi domando, oggi che i sedicenni per me sono come gli alieni, se alla fine tutto non si riduca al fatto che i sedici anni sono uguali in tutte le generazioni. O almeno quelli che avevano sedici anni nel 2008 quando è uscito questo romanzo, quando si usava ancora Messenger di Msn, il wifi non era ancora entrato in modo scontato nelle case degli italiani, si usavano ancora gli internet point e avere un blog come i protagonisti del libro era una roba da giovani.
A me ha fatto tenerezza, pensarmi nel 2008 mentre entravo nei miei trenta da single volenterosa a divertirmi fino a che ne avevo e a ricordarmi il lento e graduale abituarsi all’uso della tecnologia, una storia che può essere quella di tutte.
Lontana certo da Hunger Games dei nuovi sedicenni del 2015 (per arrotondare a un anno tipo zero), libri crudeli, spiazzanti persino, ma che credo raffigurino bene lo stato d’animo dei giovani che noi, per esempio, trovavamo in Dylan Dog, quel fardello e quell’inconscio pesante che si spera sempre di sciogliere, prima o poi.
Ecco, piuttosto questo romanzo di formazione ha lo stesso sapore dei nostri Goonies, il bene che sconfigge il male però con quella sensazione da pop corn dove più che altro il futuro, qualunque esso sia, è possibile, e persino Twilight ha un’idea romantica di vampiri che era già pervenuta in Buffy.
Insomma, sorprendente, divertente, scritto tra l’altro bene, sarcastico e vero. Estivo solo per ambientazione ma per tutte le stagioni e per tutti quei sedicenni che hanno sogni e anche poca autostima, questo “Mi piaci così” mi ha rallegrato.
“Almeno il cane è un tipo a posto” di Lorenza Ghinelli, Editore Rizzoli, 2015.
Una perla, questo libro è una perla.
Davvero bellissimo.
Lorenza Ghinelli con leggerezza (che non significa superficialità) tratta i temi cari con un’ironia rara.
Fino ai libri precedenti, l’autrice ci aveva lasciato luoghi illuminati dal pulviscolo, soffusi, un’alterazione di stanze apparentemente calde ma con quell’angolo buio dal quale usciva un terrore profondo che mozzava il fiato e stringeva la gola dello stomaco, tramortendo. I suoi personaggi erano ragazzini innocenti nel posto sbagliato al momento sbagliato, o meglio, calati in realtà che non avrebbero dovuto essere le loro, attaccandoci all’idea che l’infanzia debba sempre essere belle, rosa e felice. Bellissimi certo, tutti i volumi precedenti, uno dei quali La colpa finalista al Premio Strega.
Abituati dunque a scenari e mondi che scavano nell’anima, Almeno il cane è un tipo a posto sorprende per quella luce di cui sopra ma totale, priva apparentemente di quell’oscurità tra le doghe, risultando uno di quei libri che mancano quando si finiscono.
Romanzo corale e solare, ambientato in un condominio le cui famiglie abitano e si mescolano, con una struttura ben innescata, Lorenza muove i personaggi e le loro azioni mantenendo sempre alta l’attenzione.
Confesso di essermelo bevuto, leggendolo conquistata e rapita, non riuscendo a staccarmene.
E confesso che il salto dai mondi precedenti a questo, conoscendo il lavoro di Lorenza, è stato spiazzante, eppure apprezzato; ricordo che da ragazzina quando un mio autore preferito cambiava immaginario ero sempre molto contrariata, perdonando difficilmente l’evoluzione che poi anche io, da adulta, avrei provato nella mia carriera, e per via semplicemente di quell’equazione calcistica per cui squadra che vince non si cambia, e se un libro era bello in una data bolla si ricercava sempre quella, uguale a se stessa fino che non scoppiava.
Di Lorenza Ghinelli ho apprezzato molto questo cambio di direzione raffrescato per altro da una scrittura ancora più evoluta e ricercata, strutturalmente impeccabile, che scorre liscia senza farsi accorgere delle fondamenta costruite sotto.
Google libri lo racconta così: “Massimo non è uno sfigato: ce lo hanno fatto diventare. La colpa al novanta percento è di Vito. È lui ad avergli affibbiato il nomignolo di Minimo, e se ti danno quel soprannome negli spogliatoi della piscina, è difficile che gli altri pensino che il tuo è un problema di altezza o di torace stretto. Vito però ha un segreto, un segreto fatto di lividi e serate trascorse trincerato in camera sua, e Massimo, suo malgrado, sta per scoprirlo. Poi c’è Celeste, divisa tra l’essere se stessa o trasformarsi in come mamma e papà la vorrebbero; Stefania, che desidera soltanto dimagrire; Margò, alle prese con un’estate da gigante prima di tornare hobbit a settembre. Intorno a loro, un’intera galassia di amici, parenti e adulti alle prese con una tempesta di incontri e scontri che nel corso di una manciata di giorni li cambierà per sempre.”
Io posso solo aggiungere che se lo avessi letto a sedici anni sarebbe stato come quei volumi preziosi che ci si porta dietro in ogni libreria e casa che la vita impone, in trasferimenti emotivi e logistici che si vivono.
“Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen.
Nelle cicliche riscoperte, Jane Austen è diventata un personaggio alla Steve Jobs, cioè con quell’aura di leggendarietà la cui grandezza, visionarietà e avanguardia viene esaltata e riconosciuta in qualunque angolo del pianeta.
Così come Louise May Alcott.
Non a caso, ogni generazione di sedicenni ha il “suo” Piccole Donne al cinema con le attrici del momento. Il mio, per esempio, era quello con Wynona Ryder nel ruolo di Jo, ben lontana dalla madre di Stranger Things, perché Wynona eravamo noi, tutte noi, ventenni a metà anni ’90, in piena moda grunge e dal taglio di capelli alla Rachel, e che si innamorava di quell’aitante, ribelle e insoddisfatto Ethan Hawke in Giovani, carini e disoccupati.
Così come ogni generazione ha i suoi Star Wars.
Di fatto autrici del passato dalle cui opere vengono prese a piene mani sceneggiature che sono assolutamente moderne, e continuano a esserlo.
Far rientrare però Jane Austen in questa tipo classifica è più un regalo alla me stessa ragazzina romantica che ero a sedici anni.
Tra un’Eneide e un Apuleio, tra un Platone e un Sofocle, avevo bisogno di altro, mi ci imbattei e lo lessi. Certo, poi tornai a Proust, alle affinità elettive goethiane e ai dolori del giovane Werther, Rilke, Kierkegaard e compagnia bella, con questa idea che si sviluppò in me in quegli anni, per cui mi immaginavo quel periodo eleggendolo a mia epoca perfetta, nella quale potevo essere capita, compresa, sorvolando sul fatto che, volendo vivere una vita simile, avrei dovuto essere ricca sfondata e concedermi il lusso di avere così tanto tempo a disposizione da impiegarlo nell’investigare le parti recondite dell’anima, probabilmente soffocando quella parte di me stessa che romanticamente e drammaticamente sarebbe finita come Virginia Wolf, sposando comunque un vecchio facoltoso e conducendomi a un’infelicità perenne e incomprensibile.
Crescendo ovviamente queste idee passano e oggi, certo, credo che questa sia l’epoca che mi è stata concessa, l’epoca delle donne che alzano la voce volendo farsi sentire e a combattere le loro battaglie, e donne come quelle descritte dalla Alcott e dalla Austen sono vetuste zie che hanno iniziato, in un altro modo e in società diverse, queste lotte che per noi sono occasioni da passare alle giovani per concludere ciò che noi non siamo riuscite a fare.
Ne scrivono tesi di laurea, le dedicano titoli di libri (Jane Austen book club di Karen Joy Fowler, spensierato e gradevole da cui è stato tratto anche un film dalla regia televisiva ma altrettanto piacevole), Hellen Fielding e la sua Bridget Jones ci ha costruito il suo successo e fa parte di quella narrativa definita per donne che per anni e ancora oggi rimbalza sulle fascette.
Mister Darcy ed Elizabeth Benneth, pur rientrando in una società di doti e mariti, sono una di quelle coppie che nell’immaginario pop (dovuto alla televisione di cui sopra) sono diventate come Maria e il Comandante von Trapp in Tutti insieme appassionatamente, altro film da cui si continua a prendere a piene mani. Piacciono e continua a piacere Lizzy, il suo essere nelle regole ma non propriamente calata in esse a sottolineare che lei non è soltanto una donna come tutte le altre. Che ricordi, era la prima volta che leggevo di un personaggio femminile che rivendicava anche il suo cervello, che tentava di essere indipendente scontrandosi con la società dell’epoca e intransigente nei confronti della perenne immobilità di quella stessa società che viveva, in anni nei quali per altro la donna iniziava a prendersi i suoi spazi. Da Lilli Gruber prima donna a condurre il Tg più visto in Italia, il Tg delle 20 su Rai Uno, alla Tv delle ragazze di Serena Dandini ai video degli Aerosmith con Alicia Siverstone (e sì, Liv Tyler) che MTV passava a ripetizione, video nei quali le ragazze interpretate dalle due non erano più ragazzine da pubblicità telefonica alla “Quanto mi ami?” ma giovani donne che il telefono lo avrebbero riattaccato in faccia al ragazzino all’altro capo della linea, giovani donne che non si lasciavano mettere i piedi in testa dai ragazzi, li usavano e li gettavano, in ammiccamenti sensuali e anche saffici, che apparecchiavano a un altro movimento che sarebbe venuto poi fuori, quello LGBT, ancora pervaso culturalmente dalla malattia dei gay, l’AIDS, la mia prima pandemia vissuta, e che avrebbe urlato come non mai le sue battaglie. Battaglie di tutti, perché sono i diritti di tutti alla fine.
Orgoglio e pregiudizio è chiaramente un romanzo che sente il peso degli anni nonostante traduzioni eccellenti e moderne, ma si legge ancora con quell’innocenza e quel romanticismo che più per ricordo che per formazione, avvolti da maglioni larghi quali due taglie, in camerette tappezzate di poster di cantanti e calciatori sulla carta da parati prima che il muro verniciato prendesse la meglio (per risparmio ovviamente), sdraiati in letti massicci su pavimenti graniglia, dietro tende oggi démodé, in inverni grigi da anni ’90, riporta in un batter d’occhio al 1991.