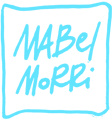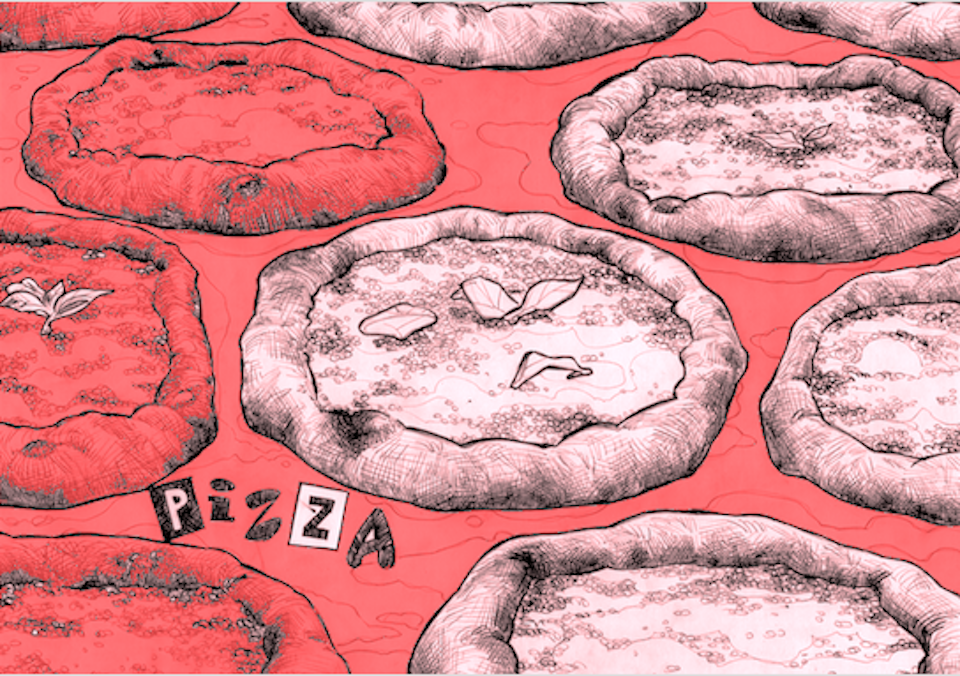
La pizza è quel cibo che ti salva sempre.
Oggi c’è un ristorante di cucina asiatica, ma nel 1987 c’era una pizzeria di media bontà abbastanza lontana dalle zone frequentate usualmente e abbastanza lontana da poter provare a essere una ragazzina di 12 anni in un ambiente non protetto dai genitori, nell’imperfezione e nell’inconsapevolezza della propria essenza come poi suppongo dovrebbe essere una ragazzina di 12 anni.
Non ci sono più ma se ci fossero le cartoline che raffigurano Piazzale Kennedy, luogo su cui si affacciava la pizzeria, avrebbe l’Hotel Bellevue imperioso e con ancora il colore di quegli anni, un grigio sbiadito nel grigiore di una piazza che solo nel tempo di trent’anni avrebbe cambiato colore – un salmone acceso dai filtri di photoshop -, forma e struttura rendendo quelle stesse cartoline testimonianze fotografiche di una Rimini che non esiste più.
Uscire era una festa a quei tempi, nonostante fosse la Rimini gommosa e fluida della scritta pubblicitaria coi colori dell’arcobaleno e delle code interminabili sul lungomare, una coda di luci chiare e rosse praticamente ininterrotta dal porto di Rimini a Riccione.
Uscire era una festa perché, sembra incredibile, ma l’infanzia di molti della mia generazione non era solo giocare per strada senza particolari pericoli di investimento, non era solo vivere spensierati tra i film sui lupi mannari e i libri di avventura di Mark Twain, tra un “Goonies” e un “Indiana Jones”, ma anche e soprattutto si viveva nel quartiere. Si arrivava all’edicola, al bar dove il nonno stazionava tra partite di carte e di biliardo, alla piadineria vicino alla scuola, al Conad nuovo nuovo appena inaugurato sostituendo una concessionaria di automobili: solo la fogheraccia di San Giuseppe del 19 marzo era un altro motivo di allontanamento dal quartiere, nel giro in bicicletta tra una parrocchia e l’altra, di quartiere in quartiere.
Uscire significava che i genitori ti lasciavano con la zia giovane oppure coi nonni, ma soprattutto significava Coca – Cola con la pizza.
Verrebbe da dire che eravamo molto protetti, ma nel pieno degli ‘80, ecatombe delle vite di tanti, tra disperati, ragazzini, Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Miriam Malossi e sua sorella un paio d’anni dopo e tanti insospettabili, non tutti hanno avuto questa protezione. Eravamo liberi certo, ma sempre nel quartiere. Chiaro che se poi il quartiere era quello del V Peep, di Via Acquario, del Bar Praga con incursioni al Melody Mecca, o anche solo vie parallele di periferia e di incontri sbagliati toccava stare più attenti di altri.
Ricordo una delle poche volte nelle quali ho tentato di cambiare la farcitura della pizza.
Normalmente nell’infanzia gli amici sono i figli degli amici dei genitori, bambini con cui si è costretti a giocare e a trovarsi bene, anche all’asilo o alle elementari vale la stessa regola, per cui quella sera di agosto, umida e fresca, nel nuovo quartiere de La Gaiofana costruito intorno al Ristorante Pizzeria da Carlo vigile nella zona dal 1969, provo a prendere una Wurstel e l’immancabile Coca – Cola.
Non ne prenderò mai più una, tornando alla Margherita che da sempre mi contraddistingue.
Nella pizzeria del 1987 i camerieri servono in camicia bianca e farfallino, i copritavoli sono di tessuto bianco e i tovaglioli sono intonati con la tovaglia.
Sento il gas della bibita ghiacciata scivolarmi nella gola, sento lo scoppiettio delle bolle nello stomaco mentre il ghiaccio si scioglie inzuppando la fettina di limone.
Poco dopo, nel tempo, sceglierò che il ghiaccio e il limone nella Coca – Cola non li sopporto.
Ecco perché quella volta, la volta nella pizzeria del 1987, sarà l’ultima nella quale berrò la Coca – Cola col ghiaccio e col limone nel bicchiere.
Di seguito, nell’ordinazione, mi arriverà una Margherita non tagliata e con una foglia di basilico nel mezzo della mozzarella sciolta.
Il corridoio è buio, solo una luce che sembra un neon in un angolo ornato con una fioriera piena di sassi ma priva di piante e che la gente usa principalmente come pattumiera rende visibile quei pochi metri di moquette prima della tenda della sala.
Il Modernissimo quando viene inaugurato è l’ennesimo cinema nel centro di Rimini, un centro pieno di vita e di negozi che funzionano, dagli angoli nascosti e spesso pericolosi – in quella che oggi è l’Ala Nuova del Museo di Arte Moderna c’era ancora lo scheletro del vecchio ospedale, poi diventato Ospedale dei Bambini e nel parchetto adiacente si raccontava che ci fossero ancora i resti dei bambini sepolti -, come Piazza Ducale, luogo di spaccio nel cui vicino giardino comunale, incustodito, la gente si bucava di eroina prima del bell’aspetto che ha da dieci anni a questa parte.
Il centro storico ha ancora il parcheggio intorno al Castel Sismondo e il Teatro Galli è arraffato da impalcature e cartelloni pubblicitari che servono solo a coprire le rovine della Seconda Guerra Mondiale, ancora presenti.
Quando patatine e popcorn non bastavano era sufficiente percorrere via Gambalunga, qualche metro dal cinema, fare la fila e prendere uno o più quadrati delle pizzette della Pizzeria del Secolo.
Era l’epoca nella quale si poteva uscire dal cinema, non solo per fumare (in alcune sale si fumava ancora, non era ancora legge e il divieto era un simbolo che per educazione e buon senso si andava rispettando) ma anche per comprare un pezzo di pizza. Non c’erano misure restrittive e non c’erano controlli, erano appena iniziati gli anni novanta ed eravamo terribilmente giovani, così giovani che “Dirty Dancing” era V.M.14 al Supercinema osservati dall’alto della biglietteria dalla signora Flora, che non ne faceva passare uno, di minore.
Di fronte alla Pizzeria del Secolo c’era la galleria che portava alla Banca di Rimini.
Era una galleria che nei miei ricordi hanno, come al solito, un contorno soffuso e romantico. Ci andavo quando facevo le vasche e iniziava a piovere, mi ci nascondevo con un’amica, la attraversavo per tagliare l’angolo quando ero in ritardo passando ulteriormente dal negozio di scarpe Baldinini che aveva un paio di colonne e una rientranza, e quando ero bambina e aspettavo il nonno che era dentro la banca – una banca dall’architettura classica, dagli sportelli posizionati in circolo, un tavolo e qualche sedia nel mezzo della sala -, il custode con una serie di teleschermi delle videocamere, chiuso in una teca che dava sulla stessa galleria, mi faceva un po’ impressione.
Quando con mio nipote in braccio gli raccontavo che quella galleria chiusa e che nel tempo, chiusa a sua volta la banca, era diventata campo degli skaters, era un luogo che meritava una visita, i cui muri avevano nella memoria la me stessa di trent’anni prima e chissà quante altre persone che non esistono più, un ragazzo che superava il passaggio semi aperto di una saracinesca mi domandava sbuffando che se dovevo entrare, sottolineava che quella era proprietà privata, ho capito che quei passaggi erano fermi da qualche parte, in una realtà parallela di un passato che non può più essere presente, ma che lo è stato e lo è stato in modo emozionante e curioso, inciso nelle curve del marmo, nella calce delle lastre della pavimentazione, nelle colonne che ornano la galleria, in uno di quei piani temporali alla Nolan da mal di testa.
La Pizzeria del Secolo non è altro che un negozio con una vetrina, un arredamento risistemato agli inizi degli anni novanta ma mantenendo sempre le caratteristiche di sempre: quadratini di pizza sprizzanti olio, con la pasta leggermente scottata nel fondo e talmente gustosi da finire nelle guide del cibo da strada delle migliori collane.
Si potrebbe dire che non sei mai stato riminese, anche di acquisizione, se non hai mangiato almeno una volta nella vita la pizzetta del Secolo, ma nel mondo fluido di oggi sembra quasi campanilistico. Era un mondo diverso, noi eravamo ragazzi diversi e quello era un luogo di aggregamento, era un luogo nel quale ci si incontrava, semplicemente, e quando da adulto ci si ritrova in luoghi che apparentemente non cambiano mai, seppur dotati di targa di ottone di locale storico, fanno casa, fanno nostalgia, fanno che ci si portano i nipoti.
Ci sono state pizze con ex, pizze con le amiche, quella dei 39 anni al Settimo di Jesi, pizze con i genitori, pizze da asporto per le partite della Nazionale, pizze dopo aperitivi distruttivi, pizze del dopo partita con la squadra, e poi ci sono pizze che si ricordano con emozione.
Di fronte casa, a fianco del passaggio pedonale che nell’ultimo anno ha vomitato studenti su studenti, dalla tragedia di Corinaldo ai Friday for Future, dalle scontate libertà dell’andare a scuola al silenzio della quarantena, al ritorno di quella libertà mai così apprezzata durante gli esami di maturità all’uscita per ritrovarsi per le ultime chiacchiere, Freddy’s è il primo esercizio commerciale che i ragazzi incontrano.
Ricavato dagli spazi a uso commerciale sotto il portico di un condominio di mattoni rossi, Freddy’s non ha nulla di moderno. Persino il microguida col volante che regala le biglie ha le gambe di vernice azzurra scrostata e leggermente arrugginite e il distributore di palline è abbandonato in un angolo praticamente in disuso. I tavoli sono tavolacci di metà anni novanta, metà legno metà plastica, pesanti e rovinati, il vino alla spina è di quelli distruttivi per chi non ha lo stomaco di ferro. Non avrebbe nulla di invitante, se non fosse che l’unica cosa che fa, cioè la pizza, è qualcosa che dovrebbe finire sulle guide Michelin.
Durante la quarantena Freddy’s, pur potendo, è rimasto chiuso.
Verso la fine di aprile quando i dpcm hanno permesso alle prime attività di riaprire, anche Freddy’s piano piano ha rimesso a posto il locale, sanificato e aperto al pubblico.
Uno di quei tavolacci erano piazzati davanti all’entrata, una coda ordinata e distanziata iniziava a formarsi.
Un tardo pomeriggio mentre i clienti storici tornavano anche solo per un saluto da lontano, mi affacciavo sull’uscio del giardino, sulla strada privata, per prendere un po’ d’aria facendo aperitivo con un bicchiere di rosso. Freddy ha alzato la mano, al di là della strada, oltre il giardinetto del condominio dei mattoni rossi, in segno di saluto.
E’ da lui che ho preso la mia prima pizza del post lockdown e la sensazione di libertà, seppur con mascherine e guanti, gel e distanze, è stata commovente.
Non mi è mai sembrata così buona una pizza, come se fosse la prima volta che la mangiavo. Che per quello che abbiamo vissuto, quasi un po’ lo era.