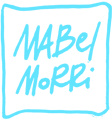siamo stati educati al 33 giri e al 45, i nostri genitori ascoltavano i dischi in vinile e noi siamo cresciuti con le musicassette. poi sono arrivati i cd e quando anche questi sono diventati oggetti obsoleti, ci siamo abituati all’mp3 fino a oggi a Spotyfi. dio del cielo. mi sembra di aver vissuto mille vite.
in questi passaggi generazionali, mi sento come i nostri genitori quando si sono scontarti con la dura realtà di internet e imparare a usare il computer, racchiusa in forse l’unica storiella di ZeroCalcare che mi sia mai davvero piaciuta.
hai passato anni a collezionare musicassette e cd (per non parlare del drammatico cambio da videocassette a DVD) ritrovandoti stanze intere boccheggianti di materiale non riciclabile e oggi ti basta una nuvoletta come contenitore e scopri stanze libere che avevi dimenticato di avere. quindi fai i figli perché adesso lo spazio ce l’hai.
roba che se non hai una presa elettrica ciao, sei perso, tu e i tuoi dati.
io ho sempre vissuto abbastanza male i cambiamenti, specie questi; poi ci si abitua anche a quelli, però, vuoi per indole vuoi per carattere, dall’alba dei tempi preferisco la concretezza all’evanescenza. preferisco il tocco del cofanetto, il leggere il booklet, la materialità di un oggetto in cui la musica custodita ha significato tanto o poco per me, il girarmelo tra le mani e ricordarmi che c’è una storia dietro legata alla mia storia personale, il pensiero che ero in un dato momento in un dato luogo che oggi non esiste più probabilmente e con persone che ho perso. così, complice un’inaspettato e bellissimo concerto di Niccolò Fabi sotto le stelle di Recanati al Lunaria, avevo voglia di ascoltarlo ancora e riprendere in mano i suoi cd. cercarli, ha aperto un vaso di pandora insospettabile e mi ha fatto trovare cd impolverati per cui le domande: e questo da dove scappa fuori? ma, soprattutto, perché l’ho comprato?!?! sono uscite spontanee.
ecco dunque alcune scoperte per cui vi autorizzo a togliermi il saluto quando mi incontrate per strada.
Natalie Imbruglia, White Lilies Island, 2001.
e ho scoperto non essere nemmeno l’unico.
Natalie Imbruglia, a parte essere un gran bel pezzo di figliola, si ricicla cantante e il suo Torn spopola sull’allora MTV che trasmette il suo video cinquecento volte al giorno. la musichetta simpatica, il suo musino buffo, i suoi acuti sofferenti abbinati a quell’azzurro dei suoi occhi in espressioni nostalgiche, il suo taglio maschile e sbarazzino abbinato a un abbigliamento molto ninetees e tutto fuorché sensuale, buca lo schermo. Torn in realtà è una cover di un gruppo sconosciuto norvegese e la Imbruglia, australiana e stellina di una soap opera molto popolare nella terra dei canguri, prova la carta musicale regalandoci perle che ci ricordiamo sicuramente.
però questo album che regge il mio ascolto il tempo necessario fino all’ultima traccia, tutto questo schifo non è. inizia con la bomba That Day che personalmente trovo una gran bella canzone e dal video simbolico: lei cammina in questo tunnel dai colori bui e blu con persone sfocate che le passano accanto ignorandola e che, a volte, le sbattono addosso, per poi arrivare alla fine del tunnel con un sole pieno e una luce che la illumina. che, quando uscì, fu anche significativo dei tempi, tempi di gente che non si accorge più del prossimo e di lei tipo dalla bassa autostima che però, nel suo profondo intimo devastato da quelle cose che nella vita capita che ci devastino, esce da questo limbo e torna tipo a vivere. il resto delle canzoni sono ascoltabili, senza infamia e senza lode, roba da classifica di MTV quando c’era TRL.

Take That, The Circus. 2008.
avrei anche il primo del loro ritorno, Beautiful World del 2006, quello che contiene Patience. mentre Robbie Williams scalava le classifiche e loro singolarmente hanno toppato alla grandissima, tornano insieme anni dopo, maturati, nostalgici e non sono nemmeno tutto questo schifo. tralasciando Back for good, la loro discografia mi ha sempre fatto cagarissimo, figuriamoci poi quando Gary Barlow aveva i capelli biondo ossigenato.
gli album della loro seconda vita, complice anche il mercato discografico in forte evoluzione e in cui un singolo basta per celebrare o affossare chiunque, permette ai quattro superstiti di riprovarci. bei ragazzi lo sono sempre stati, rivederli adulti e ripuliti di lustrini, cinghie, robe trasparenti da sex shop e senza quei balletti imbarazzanti, dà la sensazione che anche musicalmente li si possa rivalutare. fino a un certo punto. le canzoni sono melense e più autoriali, ma niente di eclatante. questo è quello che contiene Greatest Day. e sì, anche io le confondo e mi sembrano tutte uguali, domandandomi: ‘spet, qual è? poi la ascolti e dici: ah sì, questa! ma te la dimentichi tre nanosecondi dopo l’ascolto. come per i cd della Imbruglia vorrei raccontare del perché e del percome io li abbia, ma proprio non me lo ricordo. non ho la più pallida idea di quando e dove li abbia comprati. posso solo sperare che fossi ubriaca o molto triste tipo il tunnel del video della Imbruglia, perché proprio non me lo spiego.

Robbie Williams, Life Thru a Lens. 1997.
l’abbandono ai Take That ha provocato orde di ragazzine piangenti e disperate, ma niente in confronto al ragazzino che si filmò in un video diventato virale in un tempo pre youtoubers quando in Europa non si sospettava la potenza di questo mezzo. il ragazzino biondo ossigenato in una valle di lacrime chiedeva di smettere di dare contro alla sua amatissima Britney Spears additata continuamente per non mi ricordo cosa. e pensare che Britney, a vederla nei video oggi, in confronto a Miley Cyrus è un’educanda e nel suo pop ha cambiato radicalmente l’idea dello stesso. certo, mai come Madonna, ma il suo lo ha fatto. quindi, potete capire quanto fosse niente in confronto la dipartita di Robbie dai Take That.
Robbie ci prova con una cover di George Michael, Freedom, più arrabbiata della ballata lunghe dal video con le top model degli anni ’90 dell’ex Wham!. poi fa uscire a traino, senza che contenga la cover, questo Life Thru a Lens. è quello che contiene Angels, per il resto, adesso, alla nona traccia ho mal di testa.

Francesca Chiara, Il parco dei sogni. 1999.
chi? appunto.
per quel che ricordo, me lo regalò un amico di Milano, quello che, mentre io ascoltavo i Cure, gli Smiths e i primi Marlene Kuntz, tentò di convertirmi a Britney Spears. l’unica musicassetta che posseggo con le canzoni della Britney, un best of, me la fece lui. questo sarebbe potuto bastare per interrompere bruscamente e incrinare irrimediabilmente l’amicizia, ma il cuore è un’altra cosa e queste disavventure ti fanno capire che l’indulgenza e la pietà possono essere valori umani e quasi ti senti meglio nell’accettare nella tua vita persone che hanno gusti simili, un po’ per crogiolarti nella tua superiorità, un po’ perché in realtà ti danno informazioni su questo mondo a te totalmente sconosciuto che ti permettono di crearti una base di cultura generale che ciao.
credo di aver ascoltato solo la canzone con la quale Francesca Chiara partecipò a un San Remo giovani di non so quale anno, Streghe, e per arrivarci le prime due tracce. lo stile è quello tipo maledetto con questa voce evocativa ridondante, trita e ritrita, ma si sa, il mercato della musica butta sulla piazza qualunque personaggio sperando che sfondi. lei si vestiva di nero, con anelli grossi alle dita e delle ciocche bionde sui capelli nerissimi e lunghi. insomma, personaggio da streghetta alternativa dalla musica roccheggiante con testi che raccontano quanto sia diversa lei, di quello che vorrebbe fare e delle sensazioni che questo comporta rispetto all’esterno globalizzato e omologato. quando ho trovato questo cd era talmente impolverato che ve l’ho fotografato così, con le ditate per aprirlo, per farvi capire l’ascolto divoratore negli anni.

Sagi – Rei, Emotional Songs part 2. 2007.
che esista su questa terra anche una parte 1 è agghiacciante. siccome non voglio farmi del male riascoltandolo, sfogliando le pagine dei libri della mia memoria, credo siano cover di canzoni famose rifatte in chiave lounge. e se c’è una musica che mi dà la nausea ascoltare è quella lounge. sappiate che giro alla larga anche dai locali di questo genere, è come una malattia o un virus dal quale stare a debita distanza. o se non sono lunghe sono rivisitazioni di cui, per quel che ricordo, non se ne sentiva il bisogno di sverginare ciò che era bello prima. o almeno, c’è modo e modo. me lo regalò un altro amico con il quale, dopo questo regalo, questa volta ho rotto l’amicizia. scherzi a parte, la vita ti porta a conoscere e frequentare soggetti che nemmeno tu sai come sia potuto essere possibile, ma sai solo che quando lo ricordi con le amiche, loro ti dicono: ah sì, in quel periodo non eri tu per niente!. il che forse, a ripensarci oggi, era vero. ma ci sono quelle situazioni che non riesci a vedere e poi quando ci sbatti la testa hai l’illuminazione.
se vedete in giro questo cd bruciatelo con un rito voodoo dalle parole incomprensibili e liberate il mondo.

Lene Marlin, Playing My Game. 1999.
album del 1999, ne conserva tutto lo stile. lei ha la faccia talmente norvegese che non fai nemmeno fatica a confonderla dagli svedesi o dai danesi. la prima traccia è Sitting Down Here che poi fu il secondo singolo, più piacevole della più famosa Unforgivable Sinner con la quale sfondò il mercato inglese. Sitting Down Here fu addirittura colonna sonora di un film francese, di quelli generazionali alla primo Muccino nel quale faceva recitare il fratello dalla faccia da patata Silvio che sputazzava appena apriva bocca. lo so perché ero a Parigi per sa la madonna e vidi la locandina e in metro ne vidi il trailer. ricordo anche che avrei voluto vivere l’esperienza di andare al cinema in Francia senza capire una sola parola, ma mi fu impedito. a parte le prime tracce un po’ più sportive, le altre, se hai un fucile, non esitare a spararti. fino all’ottava traccia, quella Where I’m Headed. che a riascoltarla forse è questa la colonna di quel film francese. non lo sapremo mai e rimarremo incommensurabilmente nel mistero.
siccome il non ricordarmi canzone e film mi stava mandando ai matti come quando state scrivendo una cosa e non vi viene una parola e ce l’avete lì, gira intorno, è sulla punta della lingua e vi sforzate di compiere tutti i collegamenti mentali per farvela venire fuori, apro Wikipedia e sì, la canzone è Where I’m Headed e il film si intitola Mauvaises fréquentations. ora, il perché fossi a Parigi nel 1999, questo sì, non basta Wikipedia.
e comunque, dopo l’ottava traccia, ci si rispara.

Modà, Quello che non ti ho detto. 2006.
deve averlo dimenticato qualcuno. è impossibile che io abbia speso soldi per i Modà. impossibile.
quando io mi metto in testa di scrivere articoli come questo, è perché davvero c’è qualcosa da salvare o da ricordare o anche semplicemente rispolverare, ma i cd presi in considerazione potevano in un qualche modo colpire quella parte di noi di cui ci siamo sempre vergognati e che oggi possiamo finalmente urlare al mondo. e ascoltati appositamente, c’è davvero quel misto di nostalgia e imbarazzo nello scoprirci a canticchiarle, ma c’è un limite a tutto.
quando mi è vento in mente di scrivere un articolo di questo genere, ho valutato e spuntato i cd che potevano rientrarvi, ma quando ho preso in mano quello dei Modà, ecco, c’è stato quell’attimo eterno di oblio.
mai ascoltato, non so cosa dirvi.
posso solo affidarmi alle parole del mio amico Christian che ha tanti pregi ed è una delle persone più intelligenti e colte che io conosca, ma quando mi viene a dire che per lui Kekko dei Modà è un genio, il dubbio mi si insinua. Christian dice che Kekko è un genio perché ha fondato il successo della sua band con canzoni che hanno sempre gli stessi due o tre accordi e i testi sono così Kekko che anche cantati dagli altri ti accorgi che le ha scritte lui. quando poi mi ha anche detto che al loro concerto ci era andato, be’, si è salvato solo raccontando di quando parlava con una mamma in fondo al pubblico che gli ha chiesto: anche suo figlio è là davanti? e lui: no, sono solo. e lei si è lentamente allontanata da lui tipo lebbroso.
sì, devo averlo dimenticato qualcuno, uno di quegli amici con cui ho rotto l’amicizia. non si spiega.

The Corrs, Talk on Corners. 1997 & 1998.
in quegli anni pre nuovo millennio, l’invasione di gruppi irlandesi aveva avuto il suo apice con i Cranberries, ma questo non servì a limitarne l’invasione. di chiunque. figuriamoci in un paese come il nostro, anglofono di tradizione, con tutta la bella musica italiana che abbiamo, Modà a parte. quindi, qualunque ballata o canzone fosse orecchiabile ci arrivò.
i Corrs sono un gruppo formatosi nel lontano 1980 e le sonorità sono innegabilmente soft dai testi semplici. composto da un fratello e tre sorelle, questo cd è, come gli altri, un ricordo vuoto. è lì, nella risma, e la mia faccia è quella del mah. canzoni dimenticabilissime, gli intermezzi scozzesi con le cornamuse misti al celtico alla Loreena MacKennit dovrebbero essere quel sale e quel pepe su un cibo né carne né pesce. e invece, l’unico risultato è togliere il cd dal lettore, rimetterlo nel contenitore, chiuderlo, e lasciarlo impolverare come quello di Francesca Chiara. che poi qualche singolo dai, di quelli ah sìììì! lo trovi però non è che ti cambia la vita, ecco. del perché io abbia il cd precedente a quello che contiene la canzone del loro successo planetario, Breathless, o ho un fiuto pazzesco o sono talmente all’avanguardia che in perfetto mio stile sbaglio tempi e momenti. mi sa che poi una traccia di questo disco venne anche usata per la pubblicità di una marca di gomme da masticare. bah.

The Wallflowers, Red Letter Days, 2002.
ma prima nel 1996 c’era stato Bringing Down the Horse. che avevo comprato perché una rivista musicale ne parlava bene. siccome poi ero nel mio periodo “gruppi americani”, dai Countin’ Crowns ai Weezer e alle garage band in generale, questo avrebbe potuto anche non essere male.
The Wallflowers sono il gruppo capitanati da Jakob Dylan, il figlio di Bob Dylan. QUEL Bob. ora. se sei figlio di Bob Dylan, anche se sei un genio il paragone è talmente improponibile che a prescindere hai perso in partenza. guardate Cristiano De Andrè che razza di fine e sì che come musicista non è una pippa, ma quando tuo padre si chiama Fabrizio e ha scritto canzoni che la gente si tatua sulla schiena e ovunque abbia spazio sulla pelle, be’, la tua vita non è facile e sarà sempre condizionata dall’ingombrante ombra paterna. giusto Paolo Maldini ha superato Cesare, ma sticazzi, uno su un milione. e siamo in un altro campo, letteralmente.
il primo è quel rock molto americano dalle parole masticate e dai testi corposi e velatamente ispirati ai significati profondi della musica che hai ascoltato fin dall’infanzia, cioè quella di tuo padre. o almeno un tentativo di scrivere storie musicate. anche se fin dagli albori, in qualunque intervista, sottolinei che il tuo genere musicale si discosta completamente dall’impronta paterna. sembra quasi che il piccolo Jacob, annoiandosi a morte tra le chitarre del padre, abbia pensato tipo be’, dai, questa roba della musica non è male, se provassi a farla anche io?
i cd non sono malvagi, inutili, ma non malvagi, melodie carine e dal ritornello che rimane facilmente in testa. però probabilmente se non fosse stato Jakob, il figlio di Bob Dylan, è lecito pensare che forse il ragazzo con il suo gruppo avrebbe fatto un pochino più di fatica a emergere.
il secondo Red Letters Days è decisamente più commerciale, canzoni orecchiabili con però immancabile la strizzata d’occhio ai testi autoriali. la traccia When You’re on Top che apre il cd lancia il disco perché scelta dalla Labello, anni fa nel paleolitico, in una pubblicità per il burrocacao Labello Active nel 2002. lo spot vedeva un uomo su un catamarano che armeggia le corde con una semplicità stupefacente e si bagna le labbra, seccate dalla salsedine e dal sole. ecco che, con un altro gesto semplice e con un’unica mano, in bilico su un lato della barca e con l’altra a tenere la corda della vela (!!!), l’uomo ruota il cilindro e si passa il burrocacao sulla bocca. lui, la forza del vento e del mare e il burrocacao, con sotto When You’re on Top. la canzone di fatto fa, perfetta e, trainata dal passaggio costante in televisione, traina a sua volta il cd. il video della pubblicità l’avrei anche trovato, ma è in russo e senza musica. e non mi sembra proprio il caso di linkarlo.
cosa aggiungere? la musica dei The Wallflowres c’era o non c’era, be’, non ci cambiava la vita, anche se When You’re in Top si canticchia bene.

Jewel, Pieces of you, 1994 0 1997.
in un altro mio periodo, quello folk, ascoltavo e compravo dalla Ani di Franco a chiunque, chitarra in mano e voce suadente che raccontasse a mo’ di cantastorie musica – e che puntualmente non comprendevo perché la mia conoscenza dell’inglese è limitata -, era mio.
Jewel rientra in quel mio momento storico di ricerca. perché? non lo so.
come dire, messo in un lettore come sottofondo musicale durante una cena mentre intorno a un tavolo tu e le tue amiche chiacchierate fitto fitto dopo un mese che non vi vedete, fa un vallo. è quel genere di musica che se becchi quello che ne ascolta anche solo una nota, ti definisce intellettuale o se davvero ti vuole bene ti dice che sei una dalla musica particolare. allora cerchi su Youtube Ai seu te pego di Michel Telo e lui, inorridito, esce sbattendo la porta e non ti ringrazia nemmeno per la cena. ascoltato invece soli, di notte e roba che sei anche un po’ triste, prendi di nuovo il fucile di cui sopra, sparati e spera che la tua morte sia meno agonizzante di questo cd. la canzone qui sotto è, per altro, una di quelle tipo ritmo ritmo ritmo. e ho detto tutto.

Enya, Paint the Sky with Stars, the best of, 1997.
la musica onirica di Enya è stata altamente sdoganata da pubblicità, servizi al tg e di tutto di più e utilizzata quando c’era qualcosa di magico che, all’infinito ascolto, alla fine quasi ti piace. certo, ogni volta che ascolti Caribbean Blue ti viene una voglia di fare un tuffo in quell’acqua cristallina (squali permettendo) della madonna e una voglia di vacanza del signore. ormai è fatta, l’immagine che ti viene alla prima nota è quella di queste spiagge lontane dal mare blu e verde, quei paradisi terrestri (squali permettendo) per cui fai carte false per andarci nelle ferie di gennaio.
di solito però, è anche il cd che, scovato durante un trasloco, lasci a tua madre che magari lo mette su quando le sue amiche vengono a giocare a burraco il giovedì pomeriggio. lei ne è quasi contenta e, in realtà, tu ti liberi di quella roba.
a parte tutto e toni scherzosi, è comunque stata la prima a proporre questo genere, o almeno la prima che con questo genere ha venduto milioni di dischi, indi, chiunque dopo di lei abbia provato a fare altrettanto, è solo un copione. e a noi quando sentiamo musica così, nelle librerie new age con l’incenso acceso e cristalli vicino alla cassa, o anche solo in giro, il nome Enya è lì senza colpo ferire. semplicemente.

vorrei finire con il botto, ma mi sono accorta che molti cd sono usciti intorno alla seconda metà dei ’90, il che mi induce a pensare che li ho vissuti sul pezzo, se ascoltavo musica così. però a parte la colonna sonora di Titanic, i Texas o L’Aura e Dio del cielo cos’altro, vi avrei tediato con quella musica lì perché quelli erano gli anni di abuso consumabile dei Compact Disc e la musica, c’è poco da fare, era quella. chiaro che Blur e Oasis, Cure, Joy Division, Smiths, i primi Placebo e gli altri Dei fanno parte di quella caterva di cd, ma quella è altra roba. e, bambini di tutto il mondo, non ci si sorprende di conservare ancora quei cd, dovrebbe essere doveroso averli in tutte le mensole di qualunque casa. e magari, quando ne ho voglia, davvero davvero vi propongo un articolo dei cd fondamentali dei nostri vent’anni. quelli lì, quei ’90 che sembra incredibile aver attraversato e invece sono la nostra storia e ciò che siamo ora.