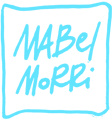L’estate è cambiata: non è più quella secca dell’infanzia ma alterna ondate di umidità devastante a periodi più freschi. I programmi televisivi estivi invece, che ci sia Sky, Netflix o il digitale terrestre, non cambiano mai: sonnacchiosi e datati. Eppure non potendo uscire tutte le sere, capita nel fare zapping di trovare quel film americano che non vedevi da tanto ma che fa sempre piacere guardare quando il cervello è al pascolo. 1 di 2.
Una sera umida, in campagna rinfresca leggermente ma senza quell’escursione termica che ricordo in Vespa, salendo per Covignano per raggiungere San Fortunato a vedere Rimini di notte e dando le spalle all’umidità marittima.
Ma quelle estati non esistono più, sono lampi nella memoria che si accendono chissà perché e che rotolano come le sterpaglie alte nella pista estiva della discoteca Paradiso, discoteca nella quale negli ’80 i miei genitori facevano da matti, nei ’90 passavano la palla a noi figli e nei 2000 i nostri, di figli, non sanno nemmeno che esista e che sia mai esistita.
Anche in campagna ormai è caldo.
Una sera di quelle lente, stanche. Si è lavorato, si è mangiato il gelato e non si ha voglia di fare troppo tardi, meglio mezz’ora di tv e poi nel letto a leggere.
Di lucciole se ne vede ancora qualcuna nel campo di ulivi di fronte. Ma che magia alla fine di maggio a vederle intermittenti nell’oscurità, che magia.
Il divano è sempre quello, il copridivano anche, la televisione sulla mensola pure.
Il telecomando è lì ed è totalmente percepibile il sentirsi svaccati senza nessun tipo di voglia, come in spiaggia quando si prende il sole, quando non si ha mai la sensazione di star perdendo tempo.
L’aria è talmente ferma che persino le zanzare ronzano annoiate.
Una pubblicità dei gelati confezionati, un programma in replica, una partita di basket di gara 5, una di tennis di un torneo su terra rossa, il canale di arte e la spiegazione sui Fenici, un film di Stanlio e Onlio, un’altra partita in replica delle nazionali di pallanuoto Croazia – Spagna, una pubblicità di una birra in un salvagente galleggiante dalla forma di un fenicottero rosa, RAI Storia, Real Time, una puntata di una serie televisiva di decenni fa, un’altra sul crimine, un altro programma di approfondimento in diretta il cui tema principale è il ritorno del costume intero, l’intramontabile Law & Order, un’altra pubblicità turistica di spiagge vicinissime e ancora sconosciute, D-Max, un altro film…aspetta un po’, quella chioma bionda, quel doppiatore, quei muscoli, quella figaggine indimenticabile nella mascella contratta, “È uno dei miei”, “Body fatti i cazzi tuoi…”, labbra in un “Ohh…” che sfuma e il volume che si alza.

Point Break, l’unico, quello vero, quello di Kathrine Bigelow del 1991. Ripetiamolo insieme: mille novecento novantuno.
Poi Keanu Reeves e Patrick Swayze camminano mezzi nudi con quei fisicacci da schiuma alla bocca lungo una fila di macchine parcheggiate su quelle loro strade americane adiacenti le spiagge lunghissime.
La trama dice: “Keanu Reeves, agente FBI, si infiltra in una banda di surfisti sospettati di essere rapinatori di banca. Imparerà a volare tra le onde e subirà l’influenza di Patrick Swayze, guru della tavola da surf.”
Fanno surf di notte, Patrick Swayze è all’apice del suo essere figo figo in modo assurdo e pure romantico avendo recitato l’anno prima in un altro blockbuster del calibro di Ghost dopo il quale idem e gli studenti del ginnasio, me compresa, esultavano perché una locuzione latina era diventata il nuovo modo di dire tra i giovani. Erano gli anni ’90, erano appena iniziati gli anni ’90 e io e milioni di ragazzini avevamo solo 15 anni, Patrick Swayze ci aveva fatto sognare con i “balli proibiti” – orrido sottotitolo di Dirty Dancing, vietato ai minori quando uscì al cinema (ripetiamolo insieme: V. M. 14) -, ci aveva reso più sopportabile la morte e l’amore foreva, e ce lo ritrovavamo pure a fare surf, filosofia di vita che stava venendo riscoperta all’epoca.
Dal film nasce la moda delle rapine con le maschere dei presidenti – Aldo, Giovanni e Giacomo le useranno nel loro Tre uomini e una gamba per rubare la appunto gamba del titolo a egiziani o marocchini (non ricordo) dopo averla persa nella famosissima scena di calcio in spiaggia – e lei, la ragazza di Keanu Reeves nel film nella scena della festa indossa un abito a minigonna in quel velluto liscio catarifrangente che andava tanto di moda in quegli anni e io lo so perché ne avevo uno uguale color rame con cui andai a diverse altrettante feste, tra cui quella al Cellophane per carnevale. Alle volte penso di essere stata davvero una vera adolescente dei miei anni calata pienamente nel pensiero e nell’universo nineties, anche solo per ricordarmi di un vestito che per fortuna ho buttato via e di cui non esiste più nemmeno un reperto fotografico, spero.
C’è tutto in Point Break: azione, pistole, surf, figaggine varia, inseguimenti, lanci da un aereo col paracadute, libertà a ogni frame (il bungee jumping era già stato inventato), romanticismo e finale pure poetico che quasi a Body gli vuoi bene e che muoia facendo surf ha una sua giustizia.
La verità è che guardi Point Break e ti viene una gran malinconia: perché non è un film degli anni ’60 eppure ci sono attori morti, tu avevi 16 anni e gli anni ’90 li stavi vivendo in pieno cercando di capire chi fossi, che cosa volessi e ti affacciavi al mondo pensando che fosse tutto possibile. Il Muro di Berlino era appena crollato, Tangentopoli non era ancora arrivata e le Torri Gemelle erano ancora in piedi, la domanda È più figo Dylan o Brandon? era LA domanda e nel mentre Tondelli e di lì a poco (1994) Enrico Brizzi avrebbero parlato a chiunque della mia generazione, facendoci sognare ancora di più.

Di Biagio è stato ricollocato dove aveva fatto abbastanza bene, all’Under 21; Under 21 che non gioca le partite di qualificazione al Mondiale di categoria perché organizzato in Italia, per cui gioca solo amichevoli. Una di queste viene giocata a fine stagione, contro la Francia. Si sente aria di vacanza lontano un miglio, specie per i calciatori che non avendo più impegni aspettano solo il momento per fare le Instagram Stories da mete caraibiche e paradisiache.
La partita annoia appena la Francia segna, stancamente si porta alla fine del primo tempo e del secondo non ne vedrò nemmeno un minuto.
Mano al telecomando e su Spike trovo L’avvocato del diavolo. Al Pacino è doppiato da Giancarlo Giannini e il discorso finale è uno di quelli che ogni tanto si ha voglia di ascoltare ancora su YouTube. Keanu Reeves e una giovanissima Charlize Theron sono di una bellezza superlativa e il film è giocato totalmente sul divino e sull’inferno, sulla moralità e sugli effetti lascivi e seducentii del male, lussuria, ricchezza, dissolutezza, il pacchetto completo insomma.
La trama dice: “Giovane talentuoso avvocato di provincia riceve proposta da importante studio legale della Grande Mela a far parte del suo staff. Quel che sembra una meravigliosa opportunità nasconde un nefasto inganno”.
È un film evidentemente della seconda metà degli anni ’90 con i suoi difetti e i suoi pregi, evidentemente mirati a un incasso esorbitante merito anche di una sceneggiatura pazzesca e attori straordinari. In fondo questo sono stati i novanta: grandi film americani a evidenziare come macigni la supremazia nel campo con quell’ultimo colpo di coda delle Grandi Commedie Americane che scemerà a fine 2000 e l’avvento di un internet e piattaforme sempre più a portata di tutti e, non meno importante, l’ascesa delle serie tv nell’evoluzione di quelle che erano i telefilm della nostra infanzia, cambieranno completamente il nostro modo di guardare il cinema.
Non ultimo, il concetto di libero arbitrio che poco prima del finale ci lascerà di sasso e poi, con un sorriso amaro, ci farà capire la possibilità di scelta. Il Tum tum tum con cui parte invece subito dopo Simpathy for the Devil dei Rolling Stones risuona ancora nelle orecchie, insieme al tentativo di strizzata d’occhio e quel tchtck strascicato tra le labbra con una smorfia che chiunque di noi ha provato a fare almeno una volta senza riuscirci.
Curiosità simpatica che oggi fa sorridere amaramente: nel film, poco oltre l’inizio c’è la scena di un ricevimento al quale Keanu e Charlize devono andare in quanto è la loro entrata ufficiale nell’alta società newyorchese e una delle organizzatrici dice: “Doveva venire anche Donald Trump, ma non ce l’ha fatta”.
E come direbbe la migliore Missironi: brrr..rabbrividiamo…
Ridi e scherza Elizabethtown di Cameron Crowe inizia ad avere la sua età e se fosse un figlio andrebbe all’ultimo anno delle medie. Lo scovo su Sky, in una serata pre Mondiale priva di qualunque attrattiva in televisione.
Nel 2005, tredici anni fa per l’esattezza, gli effetti delle Torri Gemelle non erano ancora così spiccatamente evidenti, si potrebbe dire che la mia generazione appena affiorata al decennio dei 30 risentiva ancora tantissimo dei novanta in una bolla di riequilibrio, per cui si viveva con gli stessi difetti, o almeno con la stessa illusione, del decennio precedente: avevamo ancora tutta la vita davanti. Ci innamoravamo e l’amore era ancora quel punto interrogativo enorme, iniziavamo a lavorare dopo lauree e simili, io iniziavo a scrivere e disegnare per bene e mi premiavano pure per le mie autoproduzioni, storie a fumetti che oggi rileggo e ne sento ancora la potenza di quegli anni di mezzo. E poi c’era ancora la musica, quella folk che imparai ad amare in quegli anni nella quale bastava una chitarra e una bella voce per creare l’atmosfera. Erano gli anni di Costruire di Niccolò Fabi, di Diamonds on the inside di Ben Harper, della Ballardini e della Germana Zama di Faenza, dei jeans con la loffa e le Waffle della Nike.
Elizabethtown è un film che parla di vita, nell’accettazione della morte di un genitore, di fallimento nel lavoro (l’idea di fallimento ossessiona quelli della mia generazione), di piccole grandi cose per poi concludersi con la scelta più semplice e neanche tanto scontata a volte: vivere, affrontando ciò che capita, senza lamentarsi troppo. È per altro un perfetto concentrato di quello che ero io a metà 2000; magari con le mie storie di allora non c’entra nulla, ma io ne vedo analogie continue.
Resistevano certo alcuni miti, compreso l’on the road americano, e venivano sdoganati tipi e tipologie di viaggio differenti, Cammino di Santiago compreso. Ecco perché quando Orlando Bloom inizia a viaggiare attraversando gli Stati Uniti, molti che come me non impazziscono per le mete comuni hanno gongolato.
A tale proposito Orlando Bloom a metà 2000 vantava ancora la fama del fighissimo elfo Legolas nella saga de Il Signore degli Anelli e cercava di scrollarsi di dosso quella figaggine da personaggi eroici, mentre Kirsten Dunst recita da così tanto tempo che quasi ci si dimentica che era la bambina vampiro di Intervista con il vampiro con Brad Pitt all’ennesima potenza della sua altrettanto figaggine (su riviste come Cioè o Top Girl si sprecavano i sondaggi tipo “È più bello Hugh Grant o Brad Pitt?” come anni prima su Dylan e Brandon di Beverly Hills 90210), la Luz nel film Le vergini suicide tratto da quel capolavoro di romanzo che è Il giardino delle vergini suicide di Jeffrey Eugenides della primissima Sofia Coppola che prende a piene mani dall’immaginario creato dal film Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir del 1975 (pellicola che non lasciò indifferente mai nemmeno me), la Maria Antonietta sempre della Coppola – e comunque sempre scelte raffinate nei ruoli della maturità, da Lars von Trier a Michel Gondry del Se mi lasci ti cancello, altro cult -, fino alla razzista che si ricrede ne Il diritto di contare film bellissimo ma del quale rimango sempre restia a tesserne le lodi, imprigionata dalla domanda: fin dove la ricostruzione realistica di un periodo è tale se in piena Guerra fredda, con gli americani stressati in una corsa contro il tempo con i russi per solcare lo spazio, nessuno alla NASA fuma almeno duecento sigarette a testa e addirittura il personaggio di Kevin Costner non fa altro che masticare chewing-gum gialli? Insomma una Kristen Dunst matura e bellissima e una carriera lunga e onesta e di tutto rispetto.
Di certo, ho tentato per anni di avere il taglio di capelli di Orlando Bloom e di vestirmi come Kirsten con la gonnellina floreale, la canotta bianca e le infradito e sembrare bella come lei. Ma era una fase. Forse sto invecchiando, ma sono tornata a vestire le maglie da calcio come un decenne che va allo stadio col babbo.

Al liceo artistico al quale passai quando capii che latino e greco erano sì molto affascinanti ma a me piaceva raccontare storie mie e non tradurre i testi di filosofi morti da secoli, c’era una ragazza bionda, di San Marino, che sapeva disegnare benissimo. A dire il vero al liceo c’erano tantissimi studenti che sapevano disegnare benissimo, coglievano le somiglianze con un nonnulla e realizzavano carboncini e seppie superlative. Anche io mi difendevo bene ma nell’esecuzione non ero brava come loro: curioso poi che io disegni fumetti e praticamente nessuno di quegli oltre 300 ragazzi abbia continuato studi artistici.
A ogni modo c’era questa ragazza sammarinese che disegnava benissimo.
Un giorno a lezione di Figura ci diedero come compito a casa quello di disegnare il volto di un personaggio famoso: io ero nel pieno del mio periodo Milan, credo che portai Maldini o van Basten, lei invece nel suo bel Canson bianco 50×70 portò Tom Cruise. Era effettivamente uguale: se non fosse stato per le dimensioni del foglio (avevamo cartelline che erano più grandi di noi) avrei considerato l’idea del ricalco.
La foto da cui era presa era una di quelle molto comuni di Tom Cruise, di lui cioè col suo sorriso finto da posa su uno di quei giornaletti tipo Cioè e simili; le dissi: “Ha i denti storti.” e lei: “Ce li ha lui così” con quel modo così romagnolo da azdora che era da schiaffi in faccia.
Già Tom Cruise mi stava sulle palle, non impazzivo per i suoi film e il suo modo di recitare quarant’anni dopo lo trovo ancora insopportabile e impostato (anni dopo avrebbero detto di Hugh Grant che faceva continuamente tic e faccine e io continuo a non capire come delle facce impostate di Tom Cruise non se ne sia accorto nessuno in decenni) eppure nei primi anni novanta era uno degli attori del momento, quello che muoveva le masse e i film che interpretava erano sempre blockbuster.
Per cui quando sugli schermi arrivò Codice d’onore che parlava di avvocati della Marina, scoprii che esistevano casi nei luoghi rigidi delle istituzioni e uno di questi avvocati era Tom Cruise, affiancato da Demi Moore i cui agenti riuscivano ancora a farla recitare in film di ottimo livello e rispolverava Jack Nicholson che dopo i fasti dei ’70 e i primi ’80 aveva subito il colpo dell’invecchiare e si ricuciva una seconda giovinezza nei ’90 galoppando in ruoli che sono diventati mitici.
La trama dice: “Base americana a Guantanamo a Cuba. Un militare meno coriaceo degli altri viene punito secondo “il codice d’onore” dei marines. Un avvocato d’ufficio indaga.”
Tom Cruise mi appariva molle e con le faccine come sempre, americano nel suo girare la mazza da baseball per concentrarsi nel lavoro e sorprendente il personaggio di Demi Moore che sottolineava la sua carriera e in un atto di emancipazione molto forte nei ’90 pretendeva il giusto riconoscimento del suo lavoro, cosa alla quale il personaggio di Tom Cruise, maschio alpha per eccellenza, acconsentirà a concederglielo aiutato nel risolvere un cavillo che teneva ferma l’indagine e dunque impossibilitato a proseguire nelle accuse del processo.
Il film è uno di quelli che nella marea di ottimi film con ottime sceneggiature tratte da ottimi libri usciti in quel decennio rischiava di essere tralasciato, ma la sceneggiatura è davvero scritta bene, la pellicola tiene il ritmo e anche le faccine di Tom Cruise sono sopportabili grazie alle qualità del film.
Nicholson poi è doppiato da Giancarlo Giannini e risuona ancora nelle orecchie “Piccolo arrogantello bastardo…” sussurrato a Tom Cruise che lo incalza facendo salire la tensione nella scena finale del processo e il monologo finale è da applausi nel suo inizio urlato “Tu non puoi reggere la verità!” facendo intendere che serve un capro espiatorio, che il suo lavoro è garantire libertà a quelli come Tom Cruise, che prima va bene questa libertà ma poi viene contestato come viene raggiunta, fino all’apoteosi della tensione, “Fu lei a ordinare il codice rosso?!?” “Certo che lo ordinai!, che cazzo credi?!?”. Fine, altri applausi.
Negli anni della mia infanzia due tra i più bei film che mi capitò di vedere, The Goonies a parte – che per quelli che nel 1985 avevano 10 anni come me non fu solo un film, fu IL film, quello che cambiò tutto nei significati -, furono Picnic ad Hanging Rock che mi sconvolse e quarant’anni dopo lo ricordo ancora come se lo avessi visto ieri e – ma solo perché mia madre aveva un debole per Harrison Ford per cui in casa si guardavano tutti i film con lui che vi recitava – Witness, del quale ricordo ancora una recensione che diceva: “…e Lukas Haas è un bambino vero.” sottolineando suppongo l’incapacità dei bambini attori dell’epoca, probabilmente inetti o quantomeno molto finti. Da lì in poi, tanti dei film che hanno segnato qualunque aspetto della mia vita nell’arco di venticinque anni sono dello stesso regista. I temi affrontati nei suoi film sono molti che mi hanno ossessionato per tanto tempo: il mistero, l’amicizia tra ragazze e qualcosa di ineluttabile e inspiegabile che cambia radicalmente la vita (Picnic ad Hanging Rock), il terrore di un incidente aereo (Fearless), l’amore impossibile perché le regole lo impongono (Green Card), l’andare contro ciò che è finto e cercare la propria via essendo se stessi (The Truman Show), la passione per una materia trasmessa da un insegnante capace e non banale (L’attimo fuggente) e sono tutti suoi, di Peter Weir.
L’attimo fuggente lo rivedo una sera nella quale in televisione vengono proposti programmi interessanti per via della formazione del nuovo governo o quantomeno nell’attesa che lo stesso si formi, eppure, a fronte della situazione politica italiana singhiozzante e imbarazzante, mi estraneo da questa Italia e mi godo il film del 1989 per il quale molti della mia generazione hanno desiderato diventare insegnanti.
Robin Williams è il nome di punta su cui regge il cast, ma film nei quali gruppi di ragazzi e ragazze costruivano qualcosa – amicizia, amore, sette segrete eccetera – che rimaneva nel tempo come ricordo ineluttabile del bel tempo che fu, erano abbastanza ciclici e in quasi tutti i generi. Eravamo cresciuti con il Brat Pack e i vari Breakfast Club, St. Elmo’s fire, Bella in rosa, Class, avevamo visto I guerrieri della notte che ci aveva fatto capire che da Hell’s Kitchen era meglio starci lontano o anche solo non prendere mai la metro di notte a New York – ma soprattutto un uso diverso della mazza da baseball – e il più accomodante I ragazzi della 56ma strada, Animal House piuttosto che Porky’s, insomma eravamo forgiati dai film di gruppo, anche collegiali (i libri poi aiutavano molto da Jane Austen a Piccole donne e anche gli sceneneggiati RAI tipo Cuore con Johnny Dorelli) per cui all’ennesimo film nel quale nuovi giovani attori si affacciavano a diventare adesivi nei nostri diari eravamo già pronte. Tom, Patrick, Ralph (che però era rimasto indietro facendo ripetutamente dai la cera togli la cera), Matt, Emilio, Rob, C.Thomas (che anche lui nella mia memoria rimane il bravo ragazzo che dà un passaggio a un replicante efferato assassino) erano già nomi più o meno noti, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Josh Charles e gli altri ci erano nuovi anche se io avevo una predilezione mai terminata a tutt’oggi per Ethan che amavo dai tempi di Explorers.
Il film è ambientato in un collegio di quelli esclusivi americani freddo e fangoso e una delle scene più belle ha una luce autunnale che ne esalta la malinconia, ha frasi da scrivere sui diari e rispolvera il latino nella traduzione italiana con carpe diem. L’insegnante che insegna la materia e la vita insieme dalle lezioni anticonformiste ha fatto più danni di quelli quantificabili, in anni, i miei, nei quali frequentavo il ginnasio così rigido, per cui quando a mia volta sono diventata insegnante dopo aver scelto questo lavoro per maestri spaziali incontrati nel mio cammino e una delle mie allieve ha deciso di diventare disegnatrice di fumetti, mi sono sentita come Baggio quando sbaglia il rigore contro il Brasile nella finale di Pasadena al Mondiale di USA ’94.
La versione al femminile, escludendo Picnic a Hanging Rock, arriva nella prima metà 2000 con Julia Roberts che fa l’insegnante emancipata e tra le sua allieve c’è la fidanzatina d’America dell’epoca Julia Stiles, la mia adorata Kirsten Dunst e Maggie Gyllenhaal nell’abbastanza piacevole Mona Lisa smile, ma senza tragico epilogo.


L’ultimo martedì di fine luglio, tornata dal Portogallo dei surfisti sperando di incrociare Body e Johnny (e finalmente capendo il vento e il freddo che fa, agitando la manina dicendo tanta stima ma io nell’oceano non ci metto più piede), scopro che su RAI 3 propongono la serie dei film di Rocky. Quello che capita è Rocky III, forse il più dimenticabile dei capitoli, ma col senno di poi mica tanto a rileggere gli anni ’80 e il contesto nel quale film come questo venivano proposti. In fondo Rocky IV era a due anni dall’uscita e il clima internazionale che si respirava era leggermente diverso dalle belle estati calde da bolla di sapone della riviera romagnola. Nel 1982 con l’Italia campione del mondo, con la pena di morte con la ghigliottina abolita appena un anno prima in Francia, con il governo tecnico di Spadolini e Andreotti da una parte mentre Enrico Belinguer salutava la lotta per infarto, io stavo attenta a non pestare siringhe nei giardinetti e in spiaggia per l’epidemia dell’eroina e, soprattutto, a non cadere nelle buche per via della tragedia di Alfredino Rampi l’estate prima. E poi crescevo, nell’infanzia di bambina felice, mentre l’effetto retromania riscoperto nei 2010 si faceva già sentire con Sapore di mare dei Vanzina. Intanto nel mondo la questione Medio Oriente era sempre sui tavoli dei potenti per essere discussa in un continuo credere che la soluzione fosse da parte dell’occidente, con la forza, con le armi, con gli interessi, con i soldi, con trattative segrete incessanti, ma soprattutto con quella supremazia da uomo bianco colonizzatore di cui ancora oggi si fanno i conti. In mezzo, le dittature del Sud America di Videla e Pinochet col ruolo molto ambiguo degli Stati Uniti, il Muro di Berlino e la Guerra Fredda, per cui quando uscì il capitolo successivo, quello dell’intramontabile “Ti spiezzo in due”, a noi bambini di 8, 10 anni, non sembrò un film che trattava anche di propaganda politica, ma solo del buono contro il cattivo. Ci insegnavano ovunque che i russi erano i cattivi e la libertà americana era da difendere, tutto un certo tipo di mondo era permeato da questo nuovo vento americano pop dalle tazze I <3 NY di Milton Glaser e le magliette bianche con quella scritta così iconica. Non era nemmeno di nostra competenza d’altronde e a tutt’oggi non mi sento in colpa per non aver capito davvero cosa guardavo e interpretarlo: ero una bambina e il mio unico compito era di crescere felice con i giusti valori e ideali perché avrei avuto il resto della vita per coglierne il marcio e gli inciuci e anche per educazione, ci sono quei bambini più svegli perché i genitori parlano con loro o discutono dell’attualità, io no, io avevo il calcio e i cartoni animati giapponesi.
Rocky III si discosta da questi argomenti e, a guardarlo oggi, è un film medio che riflette lo specchio dei tempi, dal costume alla moda, alla tecnica di inquadrature (ci sono certe zoommate che fanno molto sorridere) fino ai dialoghi. È un film che si guarda parlandoci sopra; appaiono Hulk Hogan e MR.T e noi bambini negli ottanta non potevamo certo non sapere chi fossero: il primo, famoso per il wrestling che all’epoca stava esplodendo come fenomeno, e il secondo era uno dei protagonisti di A – TEAM che personalmente adoravo e il cui capo, George Peppard, che io ricordo col sigaro in bocca di lato, era l’affascinante Freddy in Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn. Per cui c’era una concentrazione di ciò che tirava in quei primi anni di inizio decennio, tanto è vero che Rocky e Apollo nei loro abiti sartoriali sembrano più due gangster che sportivi arricchiti, calzando stivaletti col tacco e pantaloni affusolati che scendono leggermente a zampa d’elefante. E poi l’abbigliamento sportivo, quei tagli a vivo delle felpe e i calzettoni di spugna con le strisce colorate; ricordo che avevo una felpa a girocollo con quelle scritte americane che andavano tanto e, un giorno, per sentirmi dentro un film, tagliai le maniche per ricreare quei modelli che vedevo sullo schermo. E impazzivo per quelle calze di spugna con le strisce colorate, ricordo che mi feci comprare dai miei genitori tutti i colori disponibili. Anche se le magliette tagliate sopra la pancia, i pantaloni a vita alta, i loro muscoli gonfiati e sudati, soprattutto nella famosa scena della corsa sulla spiaggia (e annesso abbraccio festoso nell’acqua) ha un senso di gayezza da Village People che fa tanto immaginario eighties e pensare che quelli fossero i modelli da maschi alpha dell’epoca fa davvero tanto sorridere, in senso buono, perché trovo affascinante contestualizzare mode, modelli, musica, cinema, italiano anche, perché conoscere la storia anche di queste cose fa capite molto del percorso fatto capendo un po’ meglio gli anni che stiamo vivendo.
È un film con effetto nostalgia, anche questo, e del quale poi sono riusciti a ricavarne pure qualcos’altro, partendo da dettagli assolutamente dimenticati nel tempo, perché l’unico motivo per cui io lo ricordavo era la morte di Mickey, l’allenatore storico di Rocky (la trama infatti dice: “Quando Rocky viene messo K.O. da Mr. T, il suo allenatore per l’emozione muore. Il suo posto verrà preso dall’ex avversario Apollo Creed”), e invece non solo. Nel film Creed, costola della serie Rocky, si saprà chi ha vinto l’incontro promessa del finale tra Rocky e Apollo nella palestra vuota, dopo che lo stallone italiano ha steso MR. T Clubber qualcosa allenato appunto da Apollo. Il film finisce con questi pugni incrociati che diventano un quadro sul quale scorrono i titoli di coda. Sì, ma chi ha vinto quell’incontro? Tocca guardare Creed.
Quando a fine luglio 2015 Mediaset propone sulle proprie reti la pubblicità per la Champions League 2015/16 facendo la parodia della scena dei vasi in terracotta in Ghost, chi aveva visto al cinema quella pellicola o anche scoperta negli anni dopo capì quanto fosse diventata eterna, in un certo qual modo.
Ricordo che all’epoca quella scena così romantica stava quasi per essere vietata ai minori da quanto risultava osé e sexy; ricordiamoci sempre che il cambiamento è sempre molto lento, per cui quel bacio appassionato in un paese come l’Italia di fine anni ’80, seppur anni indicativi di una svolta radicale, in realtà in cittadine marittime e nella provincia romagnola più feroce il cambiamento rimaneva ostico e la gente restia ad accettarlo, un po’ come oggi verrebbe da dire.
Come scritto sopra, Patrick Swayze nell’arco di pochi anni aveva fatto una tripletta che manco Cristiano Ronaldo, azzeccando tre ruoli che, a tutt’oggi, due decenni dopo, ricordiamo ancora con malinconia e gioia e visibilio ogni qual volta lo si vede sullo schermo. E prima di Julia Stiles, c’era lei, Demi, come fidanzatina d’America. Un giorno, un giornalista o uno dedito all’arte dell’analizzare la società, dovrà scrivere un articolo sull’importanza di Demi Moore e il suo ruolo nell’industria cinema americana come attrice e personaggio pubblico, sposando per altro Bruce Willis che in quegli anni era il macho per eccellenza surclassando anni di Sly e Swarzy e posando nuda e incinta nel 1991, su Vanity Fair America della serie Britney, Miley e simili levate! (che c’ero prima io). A pensarci, Demi è stata proprio una pietra miliare del cinema e interprete perfetta dell’epoca (come Natalie Portman ed Emily Watson d’altronde a modo loro in momenti diversi), probabilmente dovuta a buoni agenti, ma credo che negli Stati Uniti pur con le loro evidenti contraddizioni, la meritocrazia sia importante, almeno all’inizio; poi diventa sistema, ma almeno nei primi passi, se si arriva al successo globale, quanto meno una possibilità credo la diano. A ogni modo, Demi ha sempre scelto ruoli non stupidi, pericolo che poteva correre e molte altre hanno dimostrato di poterci cadere. In St. Elmo’s fire per esempio appare come una sgallettata e invece risulta essere un personaggio molto bello che a un certo punto affronta se stessa e la situazione e va dal bellissimo Rob (Lowe) e gli dice che proprio non va, dimostrando una maturità rara per i personaggi di quegli anni, soprattutto femminili (e ricordiamoci sempre che nel 1990 usciva Pretty Woman che ancora rincorreva il mito del principe azzurro, una roba che esiste dal dopo guerra per capirci); è l’amante di Robert Redford in quella che venne definita cagata ma oggi è un cult come Proposta indecente, film che scatenò discussioni moraliste notevoli quasi quanto Perfetti sconosciuti, oltre che sorprendersi che nei tanto agiati ’90 che si sente raccontare ci fossero giovani che faticavano a emergere, come oggi per altro, e sempre controcorrente fu il capo di Michael Douglas nel ribaltamento dei ruoli in Rivelazioni da un romanzo di Michael Critchton (altro nome forte nei novanta e da un altro suo romanzo Spielberg trasse Jurassic World). Certo, poi ha recitato anche nei bruttini Striptease e Soldato Jane, però col senno di poi per il significato del ruolo della donna e della sua emancipazione (il primo usando il corpo per emergere e sfruttandolo, ma la donna ha anche un’anima, il secondo per sottolineare che una donna può fare le stesse cose degli uomini o almeno gli stessi diritti di difendere la patria – Katy Perry nel video di Part of me riprende questo film -) almeno nelle intenzioni c’era un senso plausibile.
La Demi Moore che compare in Ghost è una sciacquetta romantica vestita malissimo, a prima vista, e invece guardando meglio il film è l’essenzialità della moda casual del 1990: un po’ grunge che stava per investire il mondo e un po’ moda con le camicie extralarge come moda voleva, alla fine io, riguardandolo, anni dopo quando indossa una maglietta girocollo verde pur con i jeans a vita alta l’ho trovata bellissima.
Mattatrice però del film è Whoopi Goldberg con il personaggio di Oda Mae che sale alla ribalta e insieme a Sister Act diventa nuova icona della comicità di inizio decennio.
Funziona tutto in Ghost, dai tempi romantici ai tempi drammatici, dalla comicità all’ultra corporalità e spiritualità, qualunque battuta è perfetta come tempistiche e anche la tonalità dei doppiatori sembrano tali, insieme alla musica che diventa eterna. Funziona anche il triangolo tra Patrick, Demi e Tony, un classicissimo lui, lei e l’altro, sdoganato da Truffaut e riproposto moltissimo e sempre da allora in poi. Il Tony per altro, l’amico che pure si sorprende nel rivedere Sam, dopo, è il nipote del Goldwyn del marchio del leone che ruggisce; sì, sì, quello della casa di produzione Metro – Goldwyn – Mayer.
Funziona così bene che oggi, adulta e non più ragazzina, poter dire addio ai propri cari è un lusso raro e impossibile; quando uscì Ghost il mio adorato nonno era morto da pochi mesi per cui mi fece molto effetto pensare, credere nel dolore, di poter dire addio a chi si ama, e, soprattutto, in un momento nel quale la fede cristiana con cui ero stata educata vacillava talmente che sperare che la vita continuasse in un altro modo e mondo era consolante. O forse ero solo una ragazzina molto impressionabile. E quegli erano gli anni giusti per rimanere impressionati.
Qui la seconda parte.